
Tutte le immagini che illustrano quest’articolo sono nel pubblico dominio, litografie a colori tratte dalla rivista ottocentesca Prophetic Messenger, nota anche come Raphael’s Almanac.
di Stefania Consigliere e Cristina Zavaroni *
Per comprendere i tempi non ordinari, le categorie dei tempi ordinari non bastano. Bisogna cercare altrove ed è così che certi autori diventano pienamente comprensibili. Che bastasse l’induzione di paura per dominare intere popolazioni l’avevamo letto nei libri di Hannah Arendt, George Orwell, Christopher Browning e Zygmunt Bauman, ma abbiamo cominciato a crederci davvero solo nell’inverno del 2020. Ancor più difficile trovare una spiegazione per la strage delle coscienze che immediatamente ha diviso la popolazione italiana in fazioni avverse mai più ricomposte e per lo strano oblio che oggi avvolge il biennio pandemico.
A cinque anni e qualche mese dal suo incipit, l’evento più significativo (speriamo) della nostra vita collettiva sembra ai più un episodio lontano, politicamente irrilevante e per nulla attivo nel presente.
Il fatto è, però, che quella stagione non è mai finita.
1. Rimasti e disvedenti
A partire dal settembre 2021, quando scrivevamo della necessità di ritrovarsi, abbiamo viaggiato molto come ambulanti dell’antropologia medica. Dappertutto abbiamo trovato lo stesso quadro: un piccolo gruppo di rimasti pandemici che non si dà pace per l’accaduto e una maggioranza di disvedenti che quasi non se ne ricorda. Esso ricalca, a grandi linee, la divisione in fazioni cristallizzata nel marzo 2020 e poi continuamente ribadita dagli eventi successivi.
Le due famiglie, che ancora non si sono ritrovate, schivano il confronto. La distanza tra loro non discende da un disaccordo argomentativo, da scelte consapevoli o dalla normale dialettica della lotta politica, ma da qualcosa di più profondo: la risposta di ciascuno agli eventi è stata dettata non tanto dalla ragione, ma proprio dalla sensibilità, dalla percezione, ovvero dallo strato primo della presenza al mondo e della possibilità di fiducia. Prima e oltre qualsiasi riflessione o confronto, alcuni hanno sentito lockdown / zone rosse / green pass / obbligo vaccinale come misure sanitarie giuste e salvifiche, altri come intollerabili violenze di stato. A partire da lì, complici i media, nessuna ragionevolezza ha più avuto corso.
Fra i rimasti pandemici c’è un dolore che non passa: quello per la rapidità e la protervia con cui la maggioranza ha ceduto su tutto ciò che, fino all’attimo prima, sembrava intoccabile, dall’umana solidarietà al buon senso, dalla logica aristotelica a certi principi costituzionali. In molti di loro non è mai guarita la ferita per gli insulti degli amici, per le esclusioni dai pranzi di famiglia, per il disprezzo dei compagni, per l’ostilità dei colleghi.
Quando poi si è tornati ad abitare gli stessi spazi, di scuse ne sono arrivate poche. A fronte di ciò, ai rimasti è successa una cosa minuscola e tremenda: è venuta meno la possibilità di fiducia nella tenuta di ciò che li circonda. «Se è possibile questo, allora è possibile tutto», scrive Christa Wolf in Cassandra. Romanzo che, oggi, parla come non mai.
Se alla gran parte dei nostri contemporanei è parso sensato lasciare i vecchi da soli, non salutare i morti, sfilare il mondo da sotto i piedi dei figli, accogliere come se nulla fosse le contraddizioni logiche più evidenti [1] e ostracizzare chiunque esprimesse un dubbio, si fa difficile pensarli come prossimi, e men che meno come compagni di lotta. I rimasti temono che, al prossimo comando impartito dai vertici, la maggioranza risponderà come a quello precedente: ottemperando.
I disvedenti, per parte loro, alla pandemia non ci pensano più e non capiscono perché i rimasti continuino a rimuginarci sopra, se non per via di un baco masochista o per sottrarsi alle ben altre impellenze del mondo. Che, a onor del vero, sono tante e sempre più pesanti. Moltissimi non ricordano, o forse non hanno mai avuto bisogno di sapere: quando arrivano le diverse varianti della Sars-Cov-2? Nell’autunno 2020 eravamo in lockdown o no? Come funzionavano le zone a colori? Qual era la differenza fra green pass, super green pass e green pass rafforzato? In quali mesi serviva l’autocertificazione per uscire di casa e in quali per prendere un treno? Qual era la struttura logica del pass vaccinale? In che periodo era vietato ai ragazzi al di sopra dei 12 anni prendere un bus se non vaccinati? Quando sono cominciate le sospensioni dei sanitari e quando quelle degli insegnanti? E quando sono finite? L’obbligo di mascherina per strada? E cosa c’entrano in tutto ciò i portuali di Trieste, la sede della CGIL di Roma, la lettera di Scurati a Draghi?
La linea taglia la società nella sua interezza ed è esiziale nella compagneria. Qui quasi tutti i disvedenti hanno trovato, negli anni seguenti, che molto non tornasse: l’anatema sulla cultura russa, le giustificazioni del genocidio dei palestinesi, gli inni alla storia europea e ai suoi nuovi missili. La mancata connessione della miseria attuale agli eventi pandemici, però, dà alle loro analisi un timbro crepuscolare, come se i contorni restassero sempre un po’ sfocati.
Dall’altra parte, molti fra i rimasti trovano più facile restare nella ferita aperta dalla gestione pandemica – leggere articoli che ne parlano, ripercorrere i fatti con altri rimasti – che ricostruire un senso di profonda alleanza con chi, quella volta, era dall’altro lato del fossato; e quelli con meno strumenti critici a disposizione – o con specifici interessi economici – sarebbero disposti ad alimentare, tanto in ambito medico quanto in ambito educativo, religioso e politico, movimenti “anti-sistema” di carattere socialmente reazionario.
In entrambi i casi c’è qualcosa di anomalo, che fa pensare a «strutture di sentimento» innestate come corpi estranei nella nostra configurazione psicofisica, come fossimo biglie con un peso nascosto che non riescono più a rotolare dritte. Quelli più accorti stanno lavorando la questione singolarmente ma – anche dal punto di vista di chi li sostiene – è una fatica immane sanare nel singolo una ferita che si riapre continuamente perché ciò che la provoca è collettivo.
2. Tu chiamala, se vuoi, accumulazione primitiva
Primo esercizio psico-storico: se alla fine del 2019, quando un gran numero di rivolte in giro per il mondo dava filo da torcere ai governi, un qualche Nostradamus avesse previsto che, nel giro di pochi anni, avremmo finanziato una guerra contro una potenza nucleare, votato un governo dichiaratamente fascista, abbandonato i nostri figli agli schermi, rotto le catene di approvvigionamento del gas, acclamato il «nucleare pulito», tifato per uno stato coloniale nel genocidio live di un popolo colonizzato, saremmo scoppiati a ridere e la faccenda si sarebbe chiusa lì. A valle, invece, è facile constatare con quanta rassegnazione abbiamo sopportato l’insopportabile. Com’è stata costruita questa rassegnazione?
In quanto fatto sociale totale, la pandemia ha investito ogni aspetto della vita soggettiva e collettiva. Accelerando bruscamente una serie di processi già in corso, è stata volano di un rivolgimento nelle strategie di accumulazione capitalista e di governo delle popolazioni nel Nord globale. Con il venerando strumentario marxista, la si può descrivere come inizio di una nuova fase di produzione, distribuzione, scambio e consumo la cui locomotiva è una joint venture fra le industrie del digitale, del biotech e della guerra. Con lo strumentario libertario, la si può declinare come inizio di una nuova fase politica autoritaria, se non anche pre-totalitaria. Accumulazione e controllo non possono essere separati, pena l’illeggibilità del quinquennio 2020-2025.
Per descrivere la filosofia economica della Scuola di Chicago, Naomi Klein ha parlato di shock economy, l’imposizione di politiche neoliberiste approfittando di uno shock causato da un evento contingente o, se il caso, creato ad arte. In questo senso, la pandemia può essere letta come prima applicazione massiccia, in terra NATO, di strategie economico-militari già lungamente rodate altrove. O forse è una storia ben più antica, che ciclicamente si ripete. Per potersi imporre, e poi per continuare la sua espansione, la logica del plusvalore deve ogni volta distruggere le condizioni precedenti di esistenza ed espropriare ciò che prima era comune, che si tratti di terre, corpi, saperi, affetti, attenzione, genoma, sonno. Ciò è fatto, nel modo più rapido, applicando pura e semplice violenza.
Il nome tecnico di questo fenomeno è accumulazione primitiva e, secondo i compagni di Midnight Notes, non è solo il momento fondativo dell’economia capitalista, ma la sua condizione di possibilità, un esproprio che si ripete ogni volta che i cicli produttivi devono cambiare. Dalle recinzioni all’AI, ogni nuovo ciclo riversa sulle popolazioni tutta la violenza necessaria per disciplinarle alle nuove esigenze: ogni nuovo ciclo costruisce la sua antropologia distruggendo quella precedente.
Si può discutere a lungo, e utilmente, se ciò avvenga perché così funziona la logica dell’economia capitalista (ipotesi funzionalista) o perché qualcuno decide che così debbano andare le cose (ipotesi intenzionalista); e se sia il capitalismo a fare particolarmente schifo o se non sia solo l’ultimo rampollo di una lunga genealogia di sistemi di dominio.
Per parte nostra restiamo in bilico fra i due scenari, ma di certo sottoscriviamo le osservazioni di Avery Gordon in Cose di fantasmi sulla cattiveria del sistema che, inevitabilmente, contagia chi lo fa funzionare. Fatto sta, comunque, che da quattro secoli a questa parte ogni nuovo ciclo di distruzione diminuisce progressivamente gli spazi di autonomia delle collettività, rendendole integralmente dipendenti dal circuito del capitale anche per le cose più fondamentali e apparentemente inappropriabili.
Con questo strumentario, la pandemia in generale, e il lockdown nello specifico, potevano fin da subito esser letti, in analogia con altri fenomeni di pedagogia nera, come dispositivi di rieducazione violenta a tappeto. Terrore a reti unificate, isolamento fisico, sospensione degli istituti culturali fondamentali, semplificazione del discorso pubblico, biopolitica dell’assurdo (le zone a colori, i banchi a rotelle, la candeggina sulle strade), induzione di paralisi cognitiva, polarizzazione emotiva, criminalizzazione della dissidenza, militarizzazione del quotidiano con continui abusi in divisa e occultamento dell’obiettivo ci sembravano mappare con la plasmazione di una forma umana monadica, dipendente da schermi e piattaforme, teatralmente obbediente ai comandi di uno Stato neo-paternalista, supina al richiamo religioso dell’ideologia scientista, ben disposta verso il controllo poliziesco-militare, rotta al neo-feudalesimo burocratico e pronta a cedere ogni potere decisionale agli esperti. Compiutamente raggiunta durante il lockdown, la sostituzione della comunità dei corpi e degli affetti con lo spettro glaciale della socialità informatica è un esempio emblematico di distruzione delle più fondamentali autonomie a scopo estrattivista.
A pandemia ancora in corso, il nuovo shock della guerra in Ucraina, con l’allucinante bandierismo europeo, avrebbe spalancato nuovi orizzonti ermeneutici, poi rinforzati dal genocidio a Gaza, dal trumpismo, dall’attacco israelo-statunitense all’Iran, da ogni singola decisione dell’UE e da tutti i contorcimenti geopolitici in corso, fino ad arrivare all’assurdo di una guerra termonucleare che, mentre scriviamo, si profila sempre più nitida nell’indifferenza, se non anche nel bellicismo, di una parte della popolazione.
In questo teatro degli orrori c’è, per fortuna, una discontinuità: quella segnata dalle mobilitazioni italiane e internazionali per la Palestina. Forti e strutturate durante l’inverno e la primavera del 2024, con anche l’occupazione di molti atenei e scuole superiori, esse continuano tuttora a opera dei molti che trovano insopportabili le immagini in arrivo, le smargiassate dei potenti, la falsa coscienza dei media. A differenza di altri mantra, quello del «c’è un aggressore e un aggredito» è stato rispedito al mittente, a riprova del fatto che gli spiragli di lotta compaiono quando, collettivamente, si decide di aprirli.
Secondo esercizio psicopolitico: se è vero, come scriveva Walter Benjamin, che il senso del passato appare solo nel presente e di fronte al pericolo, allora il periodo pandemico diventa davvero leggibile solo sullo sfondo del nostro presente.

3. Violenza strutturale # 1. Scemo chi legge.
Una volta che la popolazione è convenientemente assuefatta alle nuove forme di controllo e il nuovo modo produttivo è stabilizzato, la violenza puntuale e ad alta intensità degli inizi si diluisce e si allarga, trasformandosi in violenza strutturale, ovvero in una specifica organizzazione dell’iniquità. È quanto stiamo vedendo. Nessuna delle strategie di gestione pandemica è mai più stata dismessa: né l’emergenzialismo, né lo squadrismo epistemologico, né il controllo poliziesco-militare dei territori, né l’oltranzismo delle regole, né il governo per assurdo, né il tecno-fascismo. La differenza, rispetto ad allora, è che ci abbiamo fatto il callo: la new normality è diventata normality e basta (come attesta il DL Sicurezza tanto nel metodo quanto nel merito).
Dando per assodata la critica alla strategia emergenzialista (cfr. ad esempio i testi di Andrea Miconi), qui cominciamo dallo squadrismo epistemologico, e cioè dalla squalificazione di ogni sapere non perfettamente allineato. Il silenziamento delle voci critiche ha colpito in modo durissimo la dissidenza da sinistra, incluse le voci scientificamente titolate delle università del nord globale. Oltre al caso celebre del prestigioso British Medical Journal, ostracizzato perché criticava la doxa pandemica, anche le scienze sociali – disciplinarmente tenute all’analisi critica del presente – hanno avuto vita dura. Molti fra coloro che le praticano hanno mostrato la loro codardia scegliendo di tacere; i pochissimi che hanno aperto bocca l’hanno fatto a loro rischio e pericolo [2].
Oggi di molte cose non si deve dubitare. Ma se torniamo alla doxa pandemica (secondo cui una pandemia per cui non esistevano terapie efficaci minacciava la sopravvivenza dell’umanità ed era quindi necessario confinare l’intera popolazione e attendere la salvezza da un vaccino), è chiaro come quasi tutte le domande dirimenti siano rimaste senza risposta.
Se il Sars-Cov-2 sia entrato in scena per contagio animale o per fuga da laboratorio è stata una delle prime domande censurate. Una volta stigmatizzati i pipistrelli, in Italia non se n’è mai più potuto discutere pubblicamente (mentre in Francia, per un controesempio, l’ipotesi che il virus provenisse dal laboratorio di virologia di Wuhan è stata presentata dalla carta stampata già a partire dal 2021). Servirebbe un serio studio scientifico, certo… Ma sarà ben difficile arrivare a conclusioni attendibili in un contesto in cui ogni ipotesi è legata a doppia mandata alle fazioni politiche statunitensi. Inoltre, da allora, la crisi della replicabilità nelle scienze ha raggiunto un tale livello da confondere qualsiasi criterio “oggettivo”: nella letteratura scientifica, come nella vita, bisogna decidere di chi fidarsi, and so much for science.
Sull’inefficacia delle terapie esistenti si sono già espressi i sanitari che, a più riprese, hanno manifestato in piazza il loro dissenso – ed è bene ricordare che la loro categoria è stata fra le principali vittime tanto della pandemia in senso stretto (per numero di morti) che della sua gestione (eroi angelici durante la prima ondata, cinici criminali durante la campagna vaccinale).
Come causa del disastro sanitario, la sparizione dei medici di base suona assai più convincente: non erano le cure a mancare, ma i curanti, soprattutto dove il dilagare della sanità privata aveva già indebolito la medicina pubblica. Sul perché si sia scelto di sopprimere la prima linea di intervento, intasare gli ospedali e infine causare stragi nelle RSA non si è mai più discusso. Stralci di queste vicende, lungo gli anni, sono passati per i tribunali, ma senza particolare risalto nonostante il numero dei morti di ospedale, di RSA o di isolamento casalingo.
Il lockdown, con il suo corteo di violenze e assurdità, è almeno servito a contenere i danni della Sars-Cov-2? È un’altra delle domande che, collettivamente, preferiamo ignorare, ma pare che la brutalità del confinamento non abbia avuto alcun influsso sull’andamento della malattia (Cfr. Inchiesta sul confinamento, di Théo Boulakia e Nicolas Mariot, pubblicata sul numero di marzo 2025 di Le Monde Diplomatique).
Per finire, fra le molte questioni divisive incontrate nell’arco delle nostre vite nessuna eguaglia in tossicità quella relativa al vaccino anticovid. La tratteremo solo per un aspetto: era noto fin da subito che Comirnaty, il vaccino a mRNA di Pfizer divenuto poi, nei fatti, l’unico disponibile, aveva effetto immunizzante – impediva il manifestarsi della malattia sintomatica, specie nella sua forma grave – ma non sterilizzante, cioè non era in grado di bloccare il contagio. Ne segue che tutto l’impianto del green pass non era solo politicamente vessatorio, ma anche logicamente fallace, almeno secondo Aristotele. Nondimeno, proprio intorno al green pass si sono prodotte le discriminazioni peggiori e le ferite più profonde.
Domande di questo tenore sono diventate illegittime e basta articolarle per essere fatti fuori come complottisti. Così Matthieu Amiech, lapidario: «l’anticomplottismo è una psichiatrizzazione della critica al potere, tanto più facile quando questa critica è maldestra e disarmata».
4. Violenza strutturale #2. Very long Covid.
Un’onda sferzante di malessere psichico, fisico e sociale continua a travagliare la popolazione, un very long covid che ha a che fare con tutte le «determinanti di malattia» entrate in azione nel biennio pandemico.
C’è, per cominciare, il long Covid in senso stretto, la permanenza a lungo termine di una varietà di sintomi dovuti, tra l’altro, anche alla capacità delle proteine del virus respiratorio Sars-Cov-2 di passare la barriera emato-encefalica e colpire il sistema nervoso centrale. La pagina che il CDC gli dedica parla di affaticamento, offuscamento della coscienza, peggioramento dei sintomi dopo uno sforzo fisico anche modesto, febbre, tosse, fiato corto, palpitazioni, difficoltà nel concentrarsi, mal di testa, problemi di sonno, vertigini, diarrea, costipazione, problemi olfattivi, dolori articolari e muscolari, rash cutanei, mutamenti del ciclo mestruale: un insieme difficile da spiegare e difficile da gestire, che ha colpito una certa percentuale di soggetti, indipendentemente dalla gravità della malattia.
Oltre a ciò, si è ipotizzato che l’aumento nel rischio di sviluppare, o riattivare, alcune patologie possa essere correlato al covid – è il caso di talune malattie autoimmuni – e/o alla vaccinazione anti-Covid, nel caso della pericardite. Nel quadro dell’antropologia medica, niente di tutto questo può essere letto come mero dato biologico, come effetto puramente meccanico dell’incrocio fra un organismo e una proteina: le malattie non sono enti naturali del mondo ma processi storici complessi, nei quali agiscono inestricabilmente fattori biologici, decisioni politiche, assetti sociali, distribuzione del potere, presupposti culturali, movimenti psichici e relazionali e via dicendo. E poiché la depoliticizzazione delle malattie è un’efficace strategia per ottenere l’impunità dei responsabili, rimandiamo i perplessi ai testi di Ivan Illich e dell’antropologia medica critica [3].
Poi c’è il diffondersi e l’aggravarsi di una serie di fenomeni già ben noti e presenti che, dopo il 2020, hanno visto una secca impennata e che, come il long covid, vanno letti entro un quadro causale complesso.
Dopo la pandemia, un certo numero di persone sono rimaste in casa. Letteralmente: non sono mai più uscite. Nel caso dei più giovani si parla di hikikomori, ma non ci sono solo loro. Lo stesso segno psico-politico si legge nell’uso delle mascherine all’aperto, che alcuni non hanno mai più abbandonato. Queste manifestazioni di ritiro sociale, terrore della morte e capitalizzazione della salute hanno cause storiche profonde, che rimandano alla costruzione moderna di soggetti monadici e che la gestione pandemica ha esasperato.
Il sonno sta sparendo dalle notti di tutti. Negli anni Settanta della nostra infanzia l’insonnia era un problema occasionale degli adulti già un po’ in là con gli anni; oggi, in molte famiglie, è la situazione normale: i genitori non dormono per via delle angosce della vita adulta in tempi cupi, i figli non dormono perché catturati dallo scrolling o per via di una continua attivazione ansiosa. Gli effetti di medio termine sono pesanti, sia dal punto di vista fisiologico che per la tenuta dei nuclei familiari. In Regno Unito, riporta il Guardian, c’è un vero e proprio mercato nero della melatonina, somministrata ai figli da genitori disperati per riuscire a dormire almeno qualche ora a notte. L’assalto capitalista al sonno, denunciato da Jonathan Crary qualche anno fa, è arrivato a compimento.
Nei nidi, nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole elementari le certificazioni di autismo – le cui manifestazioni, in senso ampio, comprendono problemi sociali e di comunicazione – sono talmente tante da imporre una riflessione che non può più limitarsi ai tecnici della diagnosi. Se è possibile che i numeri dipendano anche da un problema di sovra-diagnosi, è altrettanto vero che le osservazioni spicciole, quotidiane, di maestri e maestre indicano un peggioramento generale delle capacità relazionali, che coinvolge larga parte dei bambini e che, in alcuni, si manifesta in modo acuto. In parallelo sono aumentate le diagnosi di disturbi specifici dell’apprendimento, le diagnosi di ADHD e le richieste di certificazioni BES. Tradotto in termini antropologici, la messa in forma dei bambini nell’occidente contemporaneo produce effetti che non ancora riusciamo a interpretare e a gestire del tutto.
Fra gli adolescenti la situazione è drammatica. La loro salute mentale era già sotto attacco da quando, nel 2006, gli smartphone con schermo tattile hanno cominciato a diffondersi. All’inizio del 2020, tuttavia, molti genitori stavano ancora resistendo alla «balia elettronica» con politiche educative di accesso limitato agli schermi e ai social. Quando, a marzo, tutti gli scolari d’Italia sono stati costretti alla DAD – e quindi a molte ore obbligatorie di esposizione a schermi, telecamere, internet e «contenuti» – la possibilità di resistere all’informatizzazione della vita dei nostri figli è stata spazzata via.
Oggi, dicono unanimi i professionisti della cura psy, ansia, depressione, autolesionismo, abbandono scolastico, che già colpivano duro prima della pandemia, sono a livelli propriamente epidemici. Così, mentre molti psicoterapeuti non hanno più spazi per nuove richieste di aiuto, nelle neuropsichiatrie infantili i posti letto non bastano e gli accessi per tentato suicidio sono aumentati in modo preoccupante – al punto tale che, verso la fine del 2023, se n’era parlato perfino sulla stampa generalista.
È assai comune che, nel discorso pubblico, questi fenomeni vengano descritti come esito di malfunzionamenti individuali, ad esempio ipotizzando «geni difettosi» o «squilibri neurologici» che favorirebbero il diffondersi e il cronicizzare di condizioni quali l’ADHD, la depressione o l’autismo. Il linguaggio di cui queste spiegazioni si ammantano somiglia a quello scientifico, ma non bisogna farsi ingannare: si tratta, ancora una volta, del vecchio trucco che consiste nel far passare per naturale qualcosa che è di origine sociale e storica [4].
Ogni sofferenza, insopportazione o manchevolezza rispetto allo standard previsto viene così attribuita a un deficit del singolo, a una fragilità intrinseca che gli impedirebbe di funzionare a dovere e che può essere compensata e gestita tramite fix farmacologico o con il riconoscimento di un handicap. Difficilmente si ragiona sulla storia sociale, politica, culturale entro cui si dispiega la vita delle persone, sulle strutture di sentimento che le circostanze biografiche imprimono in noi, su quanto ciascuno incorpori, fin nelle cellule, il proprio mondo e il proprio tempo. Le pieghe imposte alla vita collettiva dalle convenienze del capitale e dei governi diventano malattia: come comprendere, altrimenti, i milioni di depressi o che a tentare il suicidio siano bambini di 9 anni?
«Non è ciò che hai vissuto a essere insopportabile, sei tu che sei debole». I soldati statunitensi di ritorno dal Vietnam, che non riuscivano a uscire dall’orrore di quel che avevano visto e di quel che erano stati costretti a fare, ottenevano una pensione e un minimo di sostegno terapeutico solo accettando un’etichetta – quella di PTSD: Post-Traumatic Stress Disorder – che ne stigmatizzava la debolezza psichica soggettiva. Qualcosa di analogo accade oggi: forse gli hikikomori di ogni età erano persone psichicamente fragili messe in crisi da un mondo complicato, ma si può anche ipotizzare che l’uso sconsiderato del terrore abbia lasciato segni psichici profondi.
Allo stesso modo, nel guardare al malessere adolescenziale che si esprime ormai anche in forme neurologiche, o alle difficoltà relazionali dei bambini, molti ancora insistono su bachi individuali o sulla disfunzionalità delle famiglie, come se l’improvvisa sparizione del mondo, decretata con uno schiocco di dita dal potente di turno, fosse un evento psichico di poco rilievo e come se le famiglie potessero davvero sopperire, da sole e sotto l’impero delle serie tv, al disastro generale.
La gestione pandemica ha tradotto in scelte politiche reali l’immaginario del pericolo pubblico, dell’apocalisse senza redenzione, che da anni attanaglia gli Stati Uniti e, di conseguenza, l’occidente globale. Alcuni analisti affermano che, dopo il covid, è cambiato il registro del disagio portato in psicoterapia, che si è spostato da questioni relazionali e di traiettoria biografica a problemi di impotenza soggettiva e perdita di senso di sé, della vita e del mondo.
Nella teoria antropologica per cui tifiamo, gli umani sono costruiti fin nelle cellule dall’ecologia relazionale complessa di cui fanno parte e alla quale contribuiscono. Nel momento in cui questa ecologia viene lacerata e riconfigurata con l’uso della forza, rendendo passivi e impotenti coloro che la abitano, gli esiti patogeni sono garantiti. E in effetti, come si fa ad abitare sensatamente un mondo in cui tutto, incluso il terriccio più fondamentale della vita – vicinanza, contatto, visite ai malati, saluti ai morti, solidarietà, affetto – può esserti tolto con un decreto d’emergenza?
5. Violenza strutturale #3. Bentornati al capitalismo di guerra!
Andiamo avanti: la violenza pandemica è ancora ben visibile in molti luoghi della vita ordinaria. A livello spicciolo, poche RSA sono tornate agli orari liberi di vista e molte hanno dismesso l’uso delle mascherine solo negli ultimi mesi, trasformandosi in un regime di tipo simil-detentivo.
Le università hanno integrato la DAD nell’offerta formativa, conformandosi di fatto alle telematiche. La scuola, già in affanno prima della pandemia, si è definitivamente piegata all’impostazione aziendalistica e alla pedagogia che essa richiede, promuovendo la competitività, la ragioneria infernale dei voti e delle medie, l’autoimprenditorialità: molti adolescenti la rifiutano in blocco mandando in angoscia le famiglie ma, nonostante le sperimentazioni dell’epoca Covid, non esistono alternative collettive plausibili.
Il fallimento – questo sì, cercato e voluto – della sanità pubblica si è trasformato nella sua dismissione, ormai unanimemente accettata come un fatto di natura contro cui nulla si può. La sostituzione del servizio pubblico, del protagonismo collettivo e perfino della miseranda politica citoyenne con la mentalità, le modalità organizzative e la filosofia corporate è un incubo quotidiano. Quasi tutti i cartelli pandemici – ingiunzioni sull’uso dell’ascensore, su come lavarsi le mani ecc. – sono rimasti al loro posto, una longue durée che rivela fino a che punto l’immaginario collettivo è stato segnato dal clima dell’epoca.
Arriviamo infine all’insieme più preoccupante di fenomeni che si trovano in continuità diretta con le politiche di gestione pandemica: quello relativo al controllo militare di popolazioni e territori. Poiché un simile livello di oppressione è giustificabile solo sbandierando un’esigenza superiore, negli ultimi anni si è perso il conto delle emergenze proclamate, con un intero zoo – peste suina africana, influenza aviaria, varianti del Covid, orsi killer, nutrie alluvionali e via dicendo – a fare da parafulmine e in una dinamica accelerata di streghizzazione della dissidenza.
Il regolamento di conti fra grandi bande capitaliste ha distrutto la piccola e media impresa che ancora resisteva a livello nazionale, rendendo inevitabile il servaggio collettivo verso le grandi piattaforme (ciò su cui battono molte delle analisi rossobrune) e, con ciò, una tracciabilità totale di preferenze, abitudini, ritmi, spostamenti e via dicendo, sulla cui utilità nello scontro geopolitico fra vecchie e nuove potenze non c’è alcun dubbio.
Nelle pieghe di questa dinamica, molte fra le università italiane che ancora gestivano le comunicazioni informatiche in autonomia hanno scelto, durante la pandemia, di incatenarsi a Microsoft o a Google, affidando loro i contenuti delle lezioni, delle riunioni, delle email e delle ricerche. Quando qualcuno prova a obiettare, arrivano le rassicurazioni di prammatica: non c’è pericolo, perché in Europa i servizi dei colossi informatici soggiacciono per contratto al GDPR – come se l’esproprio capitalista si fosse mai lasciato fermare da una firma su un pezzo di carta.
Più in generale, la delega ai tecnici di tutte le questioni che comportano una scelta, giustificata à la Burioni con l’adagio secondo cui bisogna fidarsi delle superiori competenze degli esperti, è un modo efficace di depoliticizzare tutto ciò che ci riguarda, e trasforma l’esistenza collettiva in un deserto tecnicamente attrezzato.
La green transition tanto magnificata fra 2021 e 2023, e che pareva radioso orizzonte del futuro prossimo, oltre a essere pura falsa coscienza capitalista, puntava dritta all’ennesimo esproprio di risorse – come dimostra, ad esempio, la lotta di Barroso in Portogallo – e, su più lunga gittata, alla reintroduzione del nucleare, infrastruttura infernale la cui via, in questi stessi giorni, la UE sta spianando. Cooptata in quest’inganno, larga parte dei verdi si trova oggi, a livello europeo, su posizioni assurdamente sviluppiste; i Fridays for Future sono implosi; e le ragioni prime del movimento ecologista, fino all’altro ieri ampiamente condivise a livello sociale, sono state messe nel sacco dell’«estremismo» e rese impresentabili.
In agricoltura, le nuove tecniche di manipolazione genetica digitalmente assistita hanno superato i vecchi OGM: le nuove Tecnologie di Evoluzione Assistita si trovano all’intersezione di quella che i francesi chiamano «convergenza NBIC», la coalescenza di nano- e bio-tecnologie con le scienze informatiche e quelle cognitive. La digitalizzazione dell’agricoltura permette di estrarre dati dall’attività agricola per gli scopi più vari (dalle assicurazioni alla possibilità – a fini bellici, di controllo o di estrattivismo – di affamare qualche territorio) e di usare i dati sulle sementi per ingegnerizzare e digitalizzare ulteriormente la manipolazione genetica. In questo modo vengono esautorati il sapere autonomo e la regolazione umana del rapporto con l’ambiente, il cibo, le specie non umane, cancellando definitivamente uno spazio fondamentale dell’autonomia delle comunità.
Implementate ovunque (imprese, enti territoriali, ricerca universitaria, scuola, sanità ecc.), le linee programmatiche del PNRR stanno spingendo verso una decisa trasformazione digitale della società nella sua interezza, resa desiderabile dallo shock del lockdown. Con questi soldi, tra l’altro, viene finanziata la telemedicina, ovvero la definitiva riduzione della malattia a guasto meccanico e del medico a tecnico della «materia umana»; già oggi, d’altro canto, il lavoro dei medici di base passa sempre più per l’interfaccia informatica. Il controllo preventivo dei flussi di popolazione, reso simpatico in epoca Covid con le app di tracciamento, non è mai stato così facile, diffuso ed efficace.
Il controllo poliziesco di città e territori all’epoca del lockdown e delle zone a colori ha dato i suoi frutti nell’impiego, ormai ordinario presso molti comuni, delle zone rosse, che con la pandemia hanno infine trovato modo di estendersi dalla Genova in stato d’eccezione del G8 all’intero territorio nazionale nella sua normalità. I tornelli che, tramite QRcode, determinano l’accesso agli spazi pubblici ripartendo la popolazione in gruppi dai diritti differenziali, sono diventati parte dell’arredo urbano standard, da quelli che controllano i flussi turistici a quelli che proibiscono gli ultimi baci al binario dei treni.
Le tecniche di mobilitazione e controllo dell’opinione pubblica, la cui sorprendente efficacia è stata verificata nei mesi pandemici, sono poi rimaste in funzione a tempo pieno. La violenza cognitiva è diventata strategia corrente, fra debunkers, fake news, algoritmi, accuse di complottismo e con il monopolio dell’informazione legittima da parte degli Stati e delle cordate industriali.
Oltre a richiamare la caccia alle streghe, il retrogusto di questo silenziamento rimanda a uno fra i fenomeni più inquietanti del Novecento: la propaganda. Legata a doppia mandata ai regimi totalitari e alle mobilitazioni belliche, uno dei caratteri distintivi della propaganda è il timbro morale della comunicazione. Non a caso si è parlato, durante il Covid, di «paternalismo di Stato» e perfino di «Stato etico». Legge ed etica, scienza e verità, Stato e popolazione sono una cosa sola: chi dissente, chi si trova su posizioni esistenziali differenti, non è solo un avversario o qualcuno che sbaglia, ma un soggetto intrinsecamente immorale e illogico, che chiama su di sé tutta la violenza necessaria a riportare nel mondo ordine e unanimità.
Se è vero, come sostengono ne L’alba di tutto David Graeber e David Wengrow, che le istanze liberatorie dell’Illuminismo europeo sono fiorite a partire dalla capacità scettica, critica e argomentativa dei nativi nordamericani, quella lezione è stata molte volte dimenticata lungo la storia dell’Europa. La democrazia politica richiede democrazia psichica, e questa vive solo nella molteplicità delle opinioni, delle scelte possibili, delle discussioni, dei confronti. Niente di tutto questo, oggi, è a nostra disposizione.
Concludiamo in modo volutamente telegrafico con il più inquietante fra tutti i fenomeni elencati: impiantata quando la metafora della guerra al virus si è tradotta nella realtà di un generale a capo della campagna vaccinale, la militarizzazione prosegue imperterrita sulle strade, nelle scuole e nelle università, e scandisce il passo di marcia verso un conflitto che pochi, oggi, pensano ancora evitabile. E infatti ora ci dicono che è bene prepararsi al peggio mettendo in borsetta una power bank e un mazzo di carte.
Lockdown, Ucraina, Gaza, Iran. La logica pandemica è stata il punto d’attacco di un rivolgimento complessivo di cui solo ora vediamo a figura intera la portata e la direzione: una direzione bellica, fin dall’inizio e senza flessioni, che comporta accaparramento delle risorse, controllo della popolazione, accentramento dell’informazione; che ogni volta traduce in pornografia il numero di morti e feriti; e che richiede dosi massicce di propaganda e di terrore.
In ciò, i rimasti pandemici ci hanno visto meglio fin dall’inizio.
_
* Stefania Consigliere è ricercatrice all’Università di Genova, dove insegna Antropologia e Antropologia dei sistemi di conoscenza, e dove coordina il Laboratorio Mondi Multipli, luogo di ricerca delle conseguenze ontologiche, epistemologiche, etiche, politiche ed esistenziali che derivano dal precetto antropologico di «prendere gli altri sul serio». Fra le ultime pubblicazioni Favole del reincanto, Antropologia di una pandemia e Materialismo magico.
Cristina Zavaroni, antropologa culturale ed etnologa africanista, ha una lunga esperienza di ricerca presso i Bakonzo del Rwenzori in Uganda. Specializzata in antropologia cognitiva ed etnopsichiatria, lavora da diversi anni come consulente e mediatrice etnoclinica per la Fondazione Mamre di Torino. Dal 2013 fa parte del Laboratorio Mondi Multipli.
Note
[1] A titolo d’esempio: lockdown per tutti e turni obbligatori per i lavoratori essenziali; positivi al virus invitati dai medici a non recarsi all’ospedale, per non rischiare di infettare altri pazienti, e costretti dal Prefetto al ricovero; da «Milano non si ferma» a «andrà tutto bene» nel giro di qualche giorno; depoliticizzazione integrale, nel discorso pubblico, dell’evento biopolitico più clamoroso della storia umana; uso delle mascherine sconsigliato dall’OMS nei primi decaloghi su come proteggersi dal virus e poi reso obbligatorio anche all’aperto; la fascia d’età a rischio in assoluto minore di malattia grave detenuta in casa, con la DAD, più a lungo delle altre; possibilità di frequentare congiunti fino al sesto grado, anche se ignoti, e divieto di vedere gli amici di sempre; possibilità di andare a correre ma non di passeggiare; possibilità per i non vaccinati di salire sui treni regionali, ma non sugli InterCity, e viceversa.
[2] Utrecht, marzo 2022 («Critical Perspectives on Pandemic Politics: Left-wing, Feminist and Anti-racist Critiques»): quattro gatti in sala e quattro online, alcuni relatori scelgono l’anonimato per timore di ritorsioni istituzionali. Napoli, aprile 2022 («Tutta Un’Altra Storia»): le scienze sociali accademiche disertano la chiamata alla discussione, il convegno si svolge in uno spazio occupato. Torino, novembre 2022 («Poli-Covid-22»): previsto al Politecnico, il convegno è censurato e costretto a svolgersi fuori dall’università. È solo a Pisa nel dicembre 2024 («Il governo della pandemia. Uno sguardo critico») che dentro un’aula universitaria si può azzardare un bilancio: qui tutti i relatori sottolineano la continuità fra il biennio pandemico e il presente.
[3] Ad esempio H.A. Baer, M. Singer & I. Susser (1997), Medical anthropology and the world system. A critical perspective, Bergin & Garvey, Westport (U.S.A.) and London; P. Coppo (2003), Tra psiche e culture. Elementi di etnopsichiatria, Bollati Boringhieri, Torino 2003; I. Quaranta I. ed. (2006), Antropologia medica. I testi fondamentali, Raffaello Cortina, Milano; M. Marmot (2004), The Status Syndrome. How Social Standing Affects Our Health and Longevity, Owl Books, New York
[4] Qui ci starebbe una lunga digressione sui modelli epistemologici nelle scienze della vita, ma andiamo per le spicce: negli ultimi trent’anni le ricerche in epigenetica, embriologia, ecologia, etologia e citologia hanno sostanzialmente sconfermato il modello meccanicista, riduzionista e “informatico” («un gene, un carattere») che regolava la ricerca nella seconda metà del Novecento. Per via della sua collusione con l’impianto concettuale del neoliberismo, tuttavia, il modello vecchio continua a essere proposto come orizzonte unico della spiegazione biologica anche fuori tempo massimo. Chi fosse interessato ad approfondire le questioni può cominciare da questi due testi: T. Ingold & G. Palsson (a cura di), 2013, Biosocial becomings. Integrating social and biological anthropology, Cambridge University Press, Cambridge 2013; J.-J. Kupiec, 2019, La concezione anarchica del vivente, Elèuthera, Milano 2021. (Il testo più divertente sulla naturalizzazione della storia resta ancora Miti d’oggi di Roland Barthes.)
Grazie a Nadia Breda, Wolf Bukowski, Maddalena Gretel Cammelli, Duccio Canestrini e Mimmo Perrotta per l’intransigenza, il calore e l’ironia dei lori commenti. Questo testo è cresciuto sull’humus degli incontri dei gruppi TUAS, Mondi Multipli e Innesco.
Postilla
di Wu Ming
Noi, senz’altro, ci sentiamo più lontani dai «disvedenti», perché su quel biennio tanto maledetto quanto fondante abbiamo continuato a riflettere, come abbiamo continuato a scriverne, anche nei nostri libri. Eppure non ci riconosciamo del tutto nell’identikit dei «rimasti», perché in questi anni ci siamo anche mossi, più volte attraversando la linea che divide i due campi.
Con le nostre parole e prassi, spesso ci rivolgiamo a chi, all’inverso rispetto a noi, si sente più lontano dai rimasti, eppure non è tra i disvedenti.
Il numero di costoro è maggiore di quanto si creda: persone che all’epoca ottemperarono, ma a cui da tempo le cose non quadrano.
Noi le incontriamo. Capita sovente che, nei nostri eventi pubblici, si parli del grande rimosso. E se durante il biennio 2020-2021, per le posizioni tenute qui su Giap, subimmo attacchi violentissimi, ingiurie, calunnie, oggi i nostri discorsi non incontrano ostilità. Non sappiamo quanti rimasti vengano alle presentazioni, ma ci sentiamo di dire che i disvedenti sono pochissimi.
Si è anche scoperto, col passare del tempo, che ai divieti più assurdi molti obbedirono per finta, o solo in parte. Affiorano testimonianze di pratiche di socialità clandestina, spesso pensate da piccole reti di genitori per dare un po’ di sollievo a ragazze e ragazzi. Pratiche variegate che, ne siamo certi, limitarono i danni psichici e in certi casi salvarono vite.
Per confrontarsi con chi non è «rimasto» ma nemmeno disvede, ci è stato utile consigliare letture come l’inchiesta citata sopra, apparsa su Le Monde diplomatique nel quinto anniversario dei confinamenti. Ne sono uscite anche altre. In Italia quell’anniversario è passato sotto silenzio, altrove no.
Il 21 maggio scorso ci ha scritto la persona che, nelle vorticose discussioni sul Covid, si firmava Swann Matassa.
«Forse potrà interessarvi questa visione retrospettiva sull’efficacia dei lockdown, che ri-suggerisce “a bocce ferme” quel che molti di noi tentavano di leggere nei fatti già allora: che i cosiddetti lockdown (e i loro figli) non erano né la panacea, né la soluzione ai mali, né l’unica strategia possibile […] L’inchiesta della BBC a cui vi porta il link qui sopra tratta la materia ridiscutendo tutte le controversie che l’attraversavano già nel 2020, e cita correttamente tutte le fonti, rimandando agli studi recentemente pubblicati che indagano la problematica da prospettive sia epidemiologiche che economiche. Insomma, non è che la questione sia “risolta” (non lo sarà mai), ma forse finalmente se ne può parlare come si sarebbe dovuto fare sempre, come voi avete cercato di fare anche durante: con raziocinio.»
Chris Baraniuk, autore dell’inchiesta, cita vari studi, mettendo a confronto gli eccessi di mortalità in due categorie di paesi: quelli dove le autorità ordinarono ai cittadini di chiudersi in casa; e quelli – come l’allora vituperatissima Svezia – dove si scelsero altre strade. Ebbene, chi cercasse differenze significative non le troverebbe.
Correttamente, come fa notare Swann, Baraniuk non trae conclusioni nette, perché non è possibile. Tuttavia fa una panoramica dei danni causati dallo stare-in-casa coatto. Rispetto alla ricostruzione di Consigliere e Zavaroni, questa può sembrare felpata, ma per il sito della BBC è piuttosto radicale.
«Innumerevoli studi dimostrano che durante la pandemia migliaia di persone hanno sofferto isolamento sociale e solitudine, un problema particolarmente acuto durante i lockdown nazionali. Ci sono stati impatti negativi sui genitori single, che hanno avuto più difficoltà a procacciarsi un reddito mentre si prendevano cura dei figli. Si teme che l’improvvisa perdita delle interazioni sociali e dell’accesso all’istruzione abbiano condizionato lo sviluppo dei bimbi, con alcune evidenze di un impatto sulle loro abilità linguistiche. Più di un miliardo di bambini e studenti si sono ritrovati separati dai loro abituali metodi di apprendimento. Stando a ricerche pubblicate di recente, basate su dati provenienti da 72 paesi, la chiusura delle scuole durante la pandemia potrebbe aver causato un calo [nelle competenze matematiche] equivalente a sette mesi di apprendimento.
In paesi come il Regno Unito, al confinamento è corrisposto un aumento delle violenze domestiche. Ancor più preoccupante, i lockdown hanno avuto un enorme impatto sull’accesso alla sanità. Ad esempio, molti esami e trattamenti oncologici sono stati annullati o rinviati.
Per quanto riguarda i potenziali benefici dei lockdown non legati alla trasmissione del virus, si è molto parlato del calo temporaneo dell’inquinamento e delle emissioni climalteranti a causa delle restrizioni imposte nelle prime fasi della pandemia. Si è rivelata una piccola variazione temporanea: le emissioni di gas serra sono di nuovo aumentate e la qualità dell’aria è diminuita non appena le persone sono uscite dal confinamento.»
Riguardo a quest’ultimo aspetto, il quadro è peggiore di come lo dipinge Baraniuk. Emissioni e inquinamento non sono risaliti a dispetto della pausa dei lockdown, ma a causa di essa. Il capitalismo nella fase della «ripartenza post-Covid» emette, inquina e depreda risorse molto più di prima. È la «ripartenza» stessa a imporlo, con la violenza sistemica che Consigliere e Zavaroni ben inquadrano. È stata la «ripartenza» a riportare in grande auge il carbone. Con buona pace di chi descrisse le politiche pandemiche come foriere di un mondo migliore, più solidale, più green.
Ma torniamo all’inchiesta della BBC. Baraniuk conclude:
«Cinque anni dopo, ci è più chiaro quanto siano stati duri i lockdown e che conseguenze abbiano avuto su milioni, se non miliardi, di persone. Anche ricercatori secondo cui i lockdown salvarono vite, per il futuro mettono in guardia dall’adottare frettolosamente tale misura. Gli effetti a lungo termine sull’infanzia, sull’istruzione e sulle economie si stanno ancora manifestando e probabilmente saranno compresi del tutto solo tra molti anni.»
Insomma, sì, non è possibile trarre conclusioni nette… Ma una cosa l’inchiesta la fa capire bene – anzi, due: rinchiudere la gente in casa non era l’unica via, e ha avuto conseguenze catastrofiche.
Estendere questa consapevolezza, diffonderla tra quanti non sono «rimasti» né disvedono, è la precondizione per avviare finalmente il dibattito, dissipare parte dei miasmi che viziano l’aria, far uscire i rimasti dai loro loop di disillusione, incredulità, solitudine.
E i disvedenti incalliti?
Continueranno a disvedere, per «tenere la parte» interpretata nel 2020-21. Ma saranno un po’ meno maggioranza, e il loro recedere allargherà il margine della discussione.



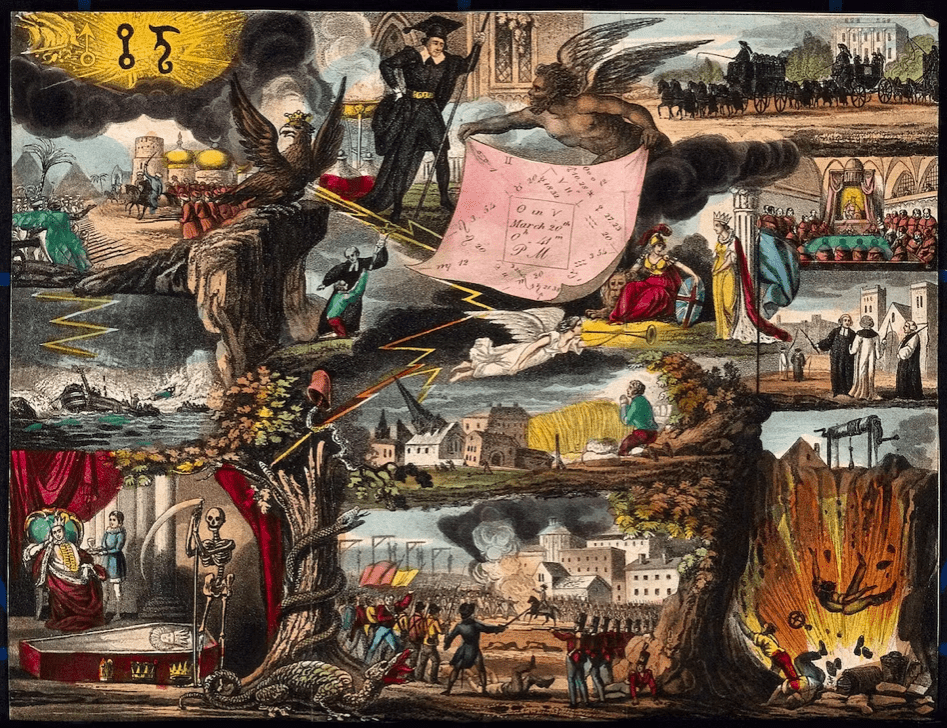
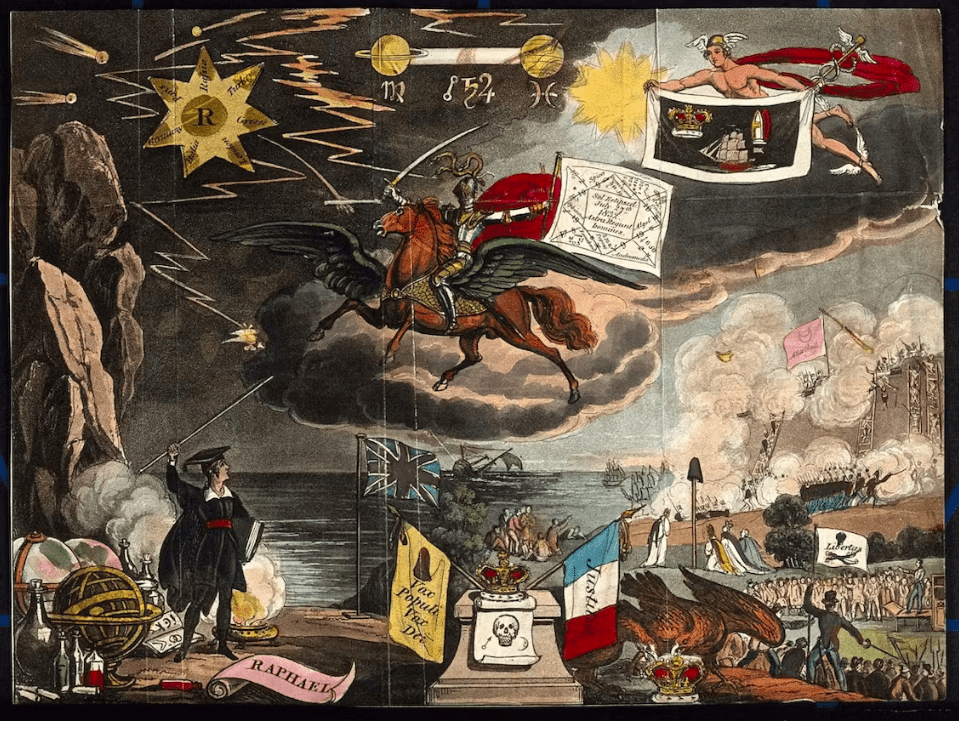

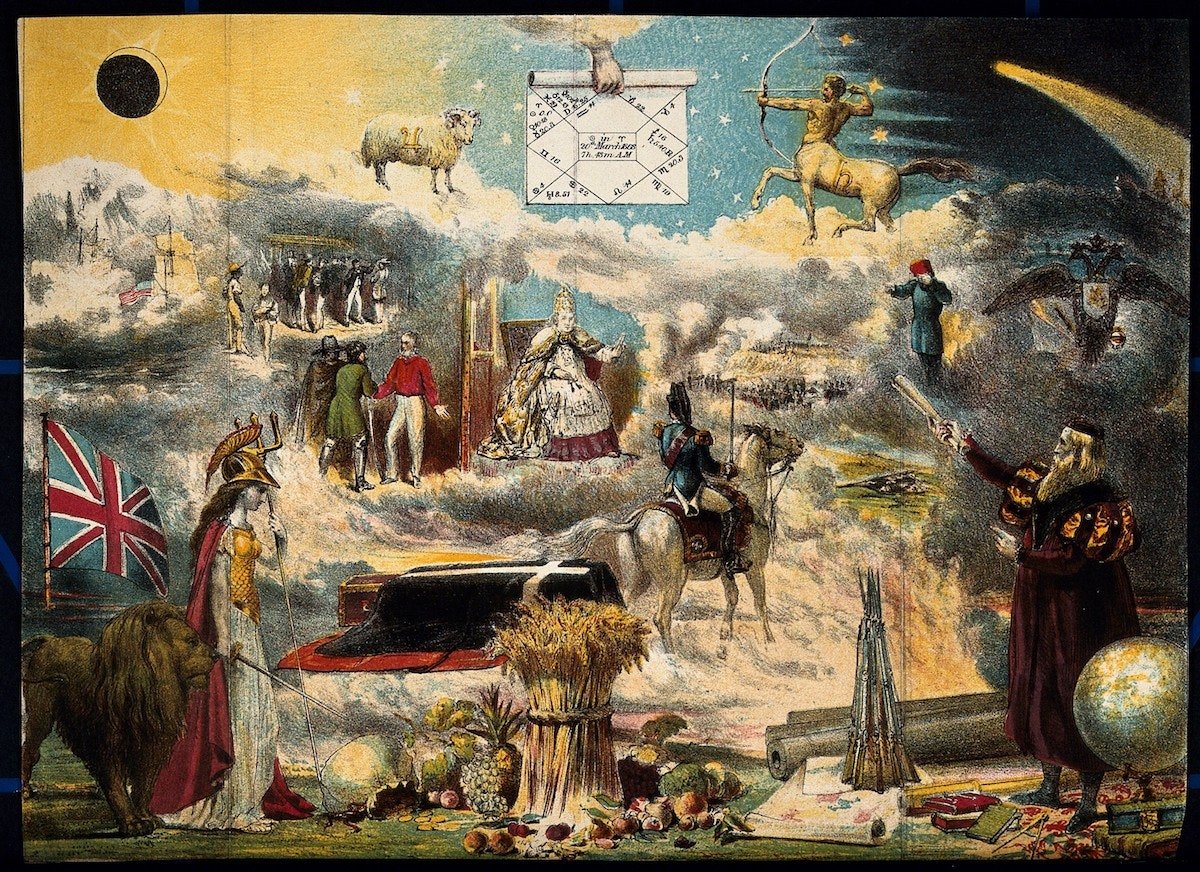


 Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)
Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)
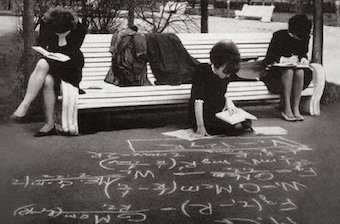

Questo è un post molto importante e necessario, grazie di cuore alle autrici. C’è il bisogno ormai ineludibile di cominciare a tracciare le linee di flusso che dall’emergenza pandemica portano alla fase attuale, in cui è diventato normale parlare di guerra nucleare, di cancellazione di Gaza dalle carte geografiche, di deportazioni di massa, di viaggi su Marte, di intelligenza artificiale a cui affidare la gestione delle nostre vite.
L’unica cosa su cui ho delle perplessità è la divisione tra “rimasti” e “disvedenti”, perché secondo me lascia troppe cose fuori dall’inquadratura. La trovo sghemba, nel senso che anche tra i cultori del lockdown e del green pass c’è chi continua a rimuginare sulla pandemia, alcuni col rancore allucinato che ben conosciamo contro i “no vax” (concetto omnibus che per loro compendia qualunque posizione critica sullo stato d’emergenza pandemico), ma altri con dolore reale per i lutti patiti e sensi di colpa per i morti che non hanno potuto salutare; per contro, tra chi ha contestato lo stato d’emergenza c’è anche chi disvede la repressione quando questa si accanisce contro altri, ad esempio contro i migranti, e accetta senza problemi la digitalizzazione delle nostre vite quando viene imposta dai tecnocapitalisti “giusti”. Ma soprattutto, più passa il tempo, più si dipana la nebbia, più mi rendo conto che la maggior parte delle persone difficilmente rientrano in una griglia costruita su polarità quali rimasti/disvedenti, pro emergenza/anti emergenza. Una cosa che mi è sempre più chiara e che mi sembra importante è che molte persone in quei due anni avevano elaborato in modo istintivo strategie per vivere qualche forma di socialità reale e corporea sotto il radar, in incognito, stealth. Insomma: c’erano tante persone come il capo indiano di “Qualcuno volò sul nido del cuculo”, che faceva finta di essere idiota per proteggersi dalla violenza psicologica dell’infermiera. Quasi nessuno è riuscito a sollevare la fontana per sfondare la vetrata, questo è vero. Ma anche quella era una forma di resistenza, l’unica possibile per molti, di fronte alla violenza dell’apparato repressivo dello stato d’emergenza pandemico.
Aggiungo che poi ci sono quelli che all’epoca hanno visto subito la violenza sistemica dello stato d’emergenza e la hanno denunciata pubblicamente, e non hanno dimenticato niente, ma oggi sono già oltre, molto avanti rispetto a quella fase. Ad esempio, “Gli uomini pesce” di Wu Ming 1 parla (anche) di questa possibilità di apertura verso il futuro.
N.B. Il link all’inchiesta uscita a febbraio su Le Monde diplomatique era sbagliato, abbiamo inserito quello giusto e lo riportiamo anche qui:
https://drive.proton.me/urls/SSGRA02MER#dxwnBaF0j38m
Dopo qualche secondo per decrittare il file, si visualizza tutto perfettamente.
Loredana Lipperini legge da «Rimozione forzata» durante Pagina Tre, la rassegna stampa culturale di Radio 3.
https://www.raiplaysound.it/audio/2025/07/Pagina-3-del-11072025-6aa6158a-d9a7-41e1-80e5-2ca905cffef9.html?sfnsn=scwspmo
Grazie per questo articolo, che anch’io trovo (sebbene siano aggettivi un po’ usurati) importante e necessario, e grazie anche per la postilla, perché anch’io ritengo che sia altrettanto importante non disvedere quanto ci fosse (ci sia) nella ‘terra di mezzo’ tra disvedenti e rimasti.
Chiaramente la dicotomia è una semplificazione necessaria per l’analisi proposta nell’articolo, e soprattutto per esplorare i nessi con le emergenze attuali, alla esasperazione delle quali la polarizzazione è ancillare, però proprio Wu Ming 1, fin da ‘La Q di Qomplotto’, ha saputo osservare quelle alternative alla narrazione dominante che andavano proprio in una direzione (più resistente che – per carità! – resiliente) che il buon Mariano Tomatis definirebbe *smark*. Direzione – per inciso – che porta a forme di *reincanto* intermedie, interstiziali rispetto a debunking e complottismo.
A margine, coincidenza significativa: durante una lunga notte in pronto soccorso, pochi giorni fa, mi ero portato da leggere proprio ‘Cose di fantasmi’ di Avery Gordon e mi sono proprio chiesto – nell’affollatissima sala d’attesa – come mai solo una ragazza tenesse la mascherina (riflettendo sulla permanenza *fantasmatica* del rimosso del Covid).
Altro PS sulla *resilienza*: vale la pena osservare come il termine stia cadendo in disuso, per essere sempre più sostituito da *antifragilità* (Taleb è un ottimo candidato ad aedo di questa nuova fase del capitalismo).
Premetto che sono un gen z (all’epoca della DAD facevo il liceo), ma un drogato forte di schermi. Non mi sono mai relazionato con gli altri giovani nel mio paesino, tanto che quando colpì il virus, la mia vita non cambiò quasi per nulla, ero già più informatizzato allora che la media di oggi. C’è da dire che ottemperai nel senso che entrai in conflitto con quello che allora era il mio unico amico (oggi non ne ho neanche uno), che invece era ribelle contro l’assurdità pandemica. Detto questo, era un rossobruno fascista, che quest’assurdità la combatteva con altra, ancor più reazionaria assurdità, quindi per fortuna non mi sento in colpa più di tanto. Passata l'”emergenza” (che per me non ha significato nulla), mi misi a pensare ed informarmi meglio su cosa era effettivamente successo, particolarmente mi chiedevo se esistesse una critica da sinistra della gestione dell’epidemia. Eccome se esiste, ovviamente, però nella vita reale non ho mai conosciuta una singola persona di sinistra che avesse mosso tali critiche, solamente fascisti e reazionari vari. In questo senso leggendo l’articolo mi sono sentito leggermente spaesato: è ovvio a livello teorico che ci sia stato l’utilizzo dello spauracchio del “no vax”, ma a fare critiche al sistema nel mio vissuto sono solo state persone grottescamente simili a tale spauracchio. Considerando la mia partecipazione minima alla vita sociale, non è un gran problema, ma fa non poca paura pensare che se fossi una persona più semplice ed estroversa, avrei visto confermata la narrazione ufficiale sulla critica al governo, senza dubbio adottandola acriticamente e diventando quello che l’articolo chiama “disvedente”. Sarà un’idiosincrasia delle città e dei paesi più piccoli, dove la sinistra fa fatica anche solo ad esistere, soprattutto qui al Sud, però rimane inquietante. Forse questa stessa possibilità di “creare scenari” a incastro è stata la vera arma impugnata dal potere in quel periodo, giacché non ho avuto neanche la possibilità di incontrare una critica come la vostra in quei tempi. Se fosse successo, forse oggi sarei molto diverso… forse sarei in carne ed ossa.
La possibilità di incontrare questo tipo di critica, come scrivi tu, in quel periodo era anche (non solo, ma anche) questione di culo. Lo pensavo allora, lo penso se possibile ancora più forte adesso. Spiace molto per te che tu non abbia avuto questa fortuna.
Dipendeva anzitutto dagli amici che uno aveva, oppure dal fatto di conoscere già la Wu Ming Foundation e Giap. Anche se furono forse migliaia quelli che ci arrivarono proprio in quel periodo, proprio a causa di quelle posizioni critiche e soprattutto *uniche*.
La ricaduta di quella consapevolezza, però, non ti avrebbe necessariamente isolato meno di quanto racconti. Nel mondo reale, “in carne e ossa”, quelle posizioni creavano più distanze che alleanze. Distante da quelli che pensavi affini e nonostante le cinque dosi in corpo ti guardavano come se fossi un no vax. Distante (e meno male) dai no vax quelli veri, rossobruni, complottisti, fascistoidi magari a loro insaputa, e varia biomassa del genere.
Distante magari da gente a cui si voleva bene, e il fatto di non essersi accaniti a vicenda in quel momento e di evitare il discorso oggi, permette di continuare a “volersi bene nonostante”. Ma non è la regola, anche quello se vogliamo è culo. La regola è, umanamente e affettivamente parlando, aver lasciato in giro, anche noi che Giap ce lo avevamo, pezzi di carne e di ossa.
Effettivamente hai ragione, in quel momento l’argomento era davvero esplosivo, tale da rendere difficilissima l’adesione e comunità in blocco (anche per la confusione ideologica che realmente poteva crearsi, come accade in quella scena/ricordo ne Gli Uomini Pesce). Questa risposta mi ha anche fatto notare come anche i frame, i luoghi comuni, e le frasi fatte più comuni e radicati in Italia si spengano così velocemente non appena diventano davvero scomodi. Nel periodo Covid vennero socialmente banditi i soliti riempi-conversazione come l’inefficienza dello Stato, la burocrazia che schiaccia tutti, ecc.; se non talvolta capovolte per intendere che qualunque clemenza verso gli untori sarebbe stata “farla all’italiana” e quindi reprensibile. Queste banali constatazioni di fatto (e non) sono spesso strumentalizzate dalla destra (per esempio mettendole a contrasto con “Mussolini che faceva arrivare i treni in orario”), però sono anche parte integrante di come l’italiano medio si relaziona con gli altri a prescindere dalle proprie differenze. Nel clima militaresco dell’epidemia, invece, equivalevano al disfattismo, e così anche le più semplici forme di espressione pseudopolitica diventavano controverse, diventavano carburante per una polarizzazione ancora più ampia ed isolante.
Se posso, da rossobruno complottista terrapiattista e chi più ne ha più ne metta (ah già, anche novax, che questo è pure vero giacchè alla fine tenni duro e non mi vaccinai), penso che questa frattura denunciata dal post non sia una novità portata dal Covid ma il punto di arrivo di un processo storico partito da lontano.
La paura che sento qui di essere identificati con i “novax” (orrore!) ne è solo uno dei sintomi. Purtroppo (o per fortuna) i processi storici non sono mai così lineari ed evidenti con i fascisti di qua e i democratici di là, i buoni da una parte e i cattivi dall’altra. Ne è prova la gestione pandemica, il periodo storico repubblicano forse più simile al ventennio, che vide la forza politica accreditata come erede di quel periodo ricoprire il ruolo di oppositore e i cd “eredi della resistenza e della Costituzione antifascista” quello di ferventi sostenitori delle politiche sanitario-securitarie. E più millantavano antifascismo più strettamente aderivano alla narrazione pandemica.
Il mio accomiatarmi dalla sinistra, un percorso iniziato quando mi resi conto del rifiuto di questa parte politica di guardare in faccia la realtà del costrutto europeista che sotto una facciata di buone intenzioni cosmopolite travestite da internazionalismo per babbei nasconde un feroce classismo ispirato a quegli stessi pensatori che servirono a legittimare Pinochet, è arrivato a definitivo compimento con il Covid.
Non per questo sono passato tra le fila dei destrorsi. Sono convinto che oggi più che mai sia necessario “mollare gli ormeggi” dei porti sicuri lasciatici dalla tradizione del XX secolo per navigare in mare aperto senza preclusioni verso nessuno. I riferimenti delle attuali destre e sinistre a livello mondiale, sulle questioni fondamentali, sono gli stessi: merda neoliberale che spesso (per quanto riguarda la sinistra) bercia antifascismo fino a che la loro agenda di togliere ai poveri per dare ai ricchi può essere portata avanti con il guanto di velluto, ma quando serve il pugno di ferro allora si fanno andare bene anche il battaglione Azov e i sionisti di ogni latitudine. Perchè mai quindi dovrebbero scandalizzarsi per un greenpass?
E se si vuole andare incontro ai marosi bisogna prima di tutto evitare di passare troppo tempo sui social che fanno sempre in modo che tu non esca dal porto e poi provare a non evitare tutti quei critici fascistoidi rossobruni novax che potrebbero non essere quello che la nostra formazione di sinistra ci fa sembrare: quasi sempre lo sono, ma quel QUASI è decisivo.
Ho apprezzato l’articolo, lo trovo utile per descrivere la difficoltà di molti a relazionarsi con gli altri sui temi di cosa è successo durante la pandemia. Ma non ci sono solo rimasti e disvedenti. Vorrei parlare di quelle persone che per educazione e cultura si fidarono di quello che le autorità medico scientifiche dissero all’inizio della pandemia; accettarono il lockdown anche se con qualche perplessità perchè era applicato a giovani che sarebbero stati interessati solo marginalmente. Si volle addirittura colpevolizzare i giovani che avrebbero messo la salute dei loro nonni a repentaglio.
L’idea che qualcosa di veramente grave stava succedendo è stato quando è stato imposto il nome “vaccino” ai prodotti mRNA, che come tecnologia ed obiettivo iniziale erano assai diversi. Se la fiducia sui vaccini è andata scemando la responsabilità primaria è delle autorità sanitarie che hanno voluto usare quel nome fino ad allora rispettato. La velocità con cui il prodotto fu sviluppato non permise di valutare l’aspetto della sicurezza del prodotto a medio-lungo termine e nemmeno la sua efficacia (è bene leggere alcuni articoli di questi ultimi anni che hanno riesaminato i dati prodotti dalla Pfizer e le conclusioni degli stessi).
Il prodotto mRNA fu distribuito anche a persone relativamente giovani, addirittura a bambini ed adolescenti, con un sistema immunitario in grado di ridurre la gravità dei sintomi.
Verso la fine di marzo 2022, in piena era “vaccinale” si scoprì che la variante Omicron era più virulenta, ma provocava sintomi meno importanti. Era arrivato il momento di ammalarsi tutti e lasciare fare al sistema immunitario di ciascuno, che possiede armi molto più differenziate e potenti dei “vaccini” sviluppati. Invece si continuò a parlare di shots a ripetizione.
Mi pare evidente che i governi ed il potere politico si sono lasciati guidare da istituzioni sanitarie finanziate dalle industrie farmaceutiche per una parte maggioritaria del loro budget e tali organismi sono interessati a curare le nostre malattie, non a mantenere e migliorare il nostro stato di salute.
Ciao, rispetto a qulle persone che per educazione e cultura si fidarono delle autorità medico scientifiche, il tema è che ormai (a questo stadio del sistema capitalistico) non esistono autorità scientifiche indipendenti (anche se i lettori del dott. Semmelwels potrebbero dire che non è una novità). Tu stesso correttamente rilevi che il potere politico e le istituzioni sanitarie si sono fatti guidare da privati finanziari, e credo che valga per qualsiasi ambito ormai. In questo contesto chi si è fidato sarà persona di buoni sentimenti ma non si è accorto, o non si vuole accorgere (è dura ammettere che il sistema che credevi che in qualche modo qualche valore lo avesse, magari anche grazie al tuo intervento nei movimenti, in realtà non ne ha nessuno) che il mondo è da tempo cambiato.
Cosa deve fare un vaccino? Deve addestrare il sistema immunitario stimolando una reazione a un agente infettivo in assenza di infezione. Se lo fa – e questi l’hanno fatto – allora è un vaccino. Chi ha smesso di rispettare il nome per il cambio di tecnologia, quel nome non l’aveva capito.
Quanto alla tecnologia in sé, dire che avesse scopi iniziali diversi non ha senso. La tecnologia a mRNA serve a veicolare informazioni alle cellule, al fine di indurle a produrre proteine specifiche. A cambiare a seconda dei casi è la funzione di queste proteine, ma la tecnologia sempre allo stesso modo funziona. Usarla per produrre vaccini era una possibilità tra le tante fin dall’inizio, anche se l’applicazione principale a cui sembra orientata la ricerca è la cura dei tumori.
Quanto alla variante Omicron, by the way, quello che secondo te era auspicabile è esattamente ciò che è avvenuto. L’infezione ha galoppato come mai prima, trovando una popolazione già ampiamente protetta dai vaccini, facendo meno danni anche tra i non vaccinati e lasciando dietro di sé un’immunità ibrida di massa che è stata decisiva per uscire dalla pandemia.
Voglio rispondere alle sue tre affermazioni che mi vedono in disaccordo.
Il vaccino deve fare quello che lei dice, ma tutti i vaccini sviluppati in precedenza non erano a tecnologia mRNA. Tale tecnologia è genica e sviluppata inizialmente per cercare metodi per curare alcune tipologia di cancro. Se gli enti preposti (FDA e CDC in primis, ma poi EMA ed AIMA) avessero riconosciuto la tecnologia genica, essa sarebbe stata sottoposta a leggi estremamente più stringenti di quelle applicate, al fine di valutare sopratutto la sicurezza ed anche la efficacia. E probabilmente non si sarebbe usato il termine vaccino, ma, ad esempio “genivac” proprio per distinguere un prodotto con caratteristiche molto avanzate e molto poco note. Un prodotto sperimentale per la cura di un tipo di cancro altrimenti incurabile viene accettato dal paziente anche in presenza di effetti collaterali importanti. Ben altra è la situazione per un vaccino destinato ad essere inoculato su molte centinaia di milioni di persone. Gli enti preposti hanno accettato una percentuale di eventi collaterali seri che avrebbe bloccato la commercializzazione di qualsiasi vaccino precedente. Gli stessi enti hanno anche accettato che il prodotto da commercializzare avesse caratteristiche diverse, e non documentate, rispetto al prodotto utilizzato nei trial clinici. Non capisco come si possa pensare che tutto ciò sia senza senso, come lei dice.
Sulla gestione della pandemia da omicron in poi di nuovo sono in disaccordo. La campagna vaccinale non è stata interrotta, non si è voluto accettare il ruolo primario del sistema immunitario di ciascuno di noi. Sono stati ignorati i numerosi casi di malattie che colpivano persone appena vaccinate, che non esistono solo perchè la medicina ufficiale non riconosce questi danni. Si è parlato di Long Covid, ma riferendosi solo a sintomi legati alla malattia covid-19, e non anche agli effetti delle vaccinazioni.
Se la risposta alla malattia adottata dei nostri sistemi sanitari ha avuto effetti sopratutto positivi, come lei sostiene, si vedrà con sempre maggiore chiarezza in futuro, perchè stanno già emergendo nella letteratura scientifica risultati che sono in ampio disaccordo con le versioni ufficiali.
Concludo dicendo che non sono un medico, ma uno scienziato fisico abituato per mestiere a porsi delle domande ed a riconoscere i punti deboli di ragionmenti anche complessi. E nella vicenda covid ne ho trovati parecchi.
Dobbiamo fare uno sforzo e smettere di parlare di virus e vaccini. Il focus dell’articolo è sull’emergenza pandemica come laboratorio di controllo sociale, come prova generale di militarizzazione dell’immaginario, come scuola di obbedienza. Le autrici lo dicono esplicitamente: tutto ciò è diventato chiaro alla luce del presente, un presente fatto di confini chiusi, di accettazione di guerre e genocidi, di accelerazionisti drogati di anfetamine e di intelligenza artificiale, di longtermisti invasati che straparlano di trasferire l’umanità su Marte, come se volessero emulare Nethanyahu e Trump che progettano di deportare i palestinesi in Etiopia. Secondo me è di questo che bisogna parlare, e dei fili (non più) invisibili che collegano questo presente alla lockdown culture del biennio 2020/22.
Premesso che lessi ed apprezzai molto “Favole del reincanto” di una delle due autrici, trovo questo articolo eccessivamente semplificatorio.
Certo, c’è la ristrettezza dovuta agli spazi, ma su tante questioni trovo che si sia voluto tenere in luce soltanto la versione “ideologicamente” affine.
Che il nucleare sia uguale a Hiroshima mi sembra ad esempio un tantinello restrittivo. Siamo davvero così esperti di nucleare da poter indicare con certezza che tutti gli scienziati a favore del nucleare siano “servi del sistema”? Di letteratura scientifica in tal senso ce n’è tantissima. E quello che dico, sarebbe più onesto menzionarla. Poi, come dire, ognuno deciderà che opinione farsi.
Ma vorrei soffermarmi su un esempio che conosco meglio, occupandomene per lavoro.
La vicenda scolastica dell’aumento dei casi di autismo. A leggere l’articolo sembra che tutto il male sia capitato adesso. Intanto va fatto notare che è solo negli ultimissimi decenni (di distruzione a quanto viene narrato) che si è posta attenzione ai bambini, prima assolutamente dimenticati. E soltanto dal 1975 i bambini con autismo hanno cominciato ad entrare nelle classi “normali”, proprio qui nella vituperata Italia e grazie alla DC. Prima non esisteva minimamente il problema.
Se si parla con un NPI serio, la faccenda qui liquidata in poche righe verrebbe amplificata e si spiegherebbe che si tratta di una condizione multifattoriale. Dipende quindi da molti aspetti, solo in parte legati all’emergenza covid, e che vengono da prima. Senza dimenticare che l’autismo ha cause genetiche in primis.
Poi, per me è fastidioso l’etichettamento. Per cui se pensi questo, allora di conseguenza pensi questo, questo e quest’altro e non puoi essere identificato tra i buoni. L’idea che soltanto oggi ci sia una maggioranza “indifferente”, disposta a lasciarsi manipolare, a concedere parte dei propri diritti perché della libertà non gliene frega niente e preferisce farsi il bidet (per citare uno splendido monologo di Ascanio Celestini), mi pare sovrastimi le maggioranze “indifferenti” del passato.
Possiamo convincerci, anche legittimamente, che questo sia il peggiore dei mondi possibili, ma non vedo sinceramente come ciò possa migliorare per noi e le generazioni future l’esistenza, né come possa indicare strade e strategie per mutare la realtà.
Tra le varie linee di flusso che collegano il primo lockdown alla fase attuale ce n’è una che è visibile in modo particolarmente nitido, almeno da dove vivo io: la chiusura dei confini. Chi legge abitualmente giap sa che scrivo da Trieste e che sono nato a Gorizia, a pochi metri dal confine. Nel 2004 la Slovenia è entrata nell’UE e quel confine è caduto. Va detto che già a partire dalla morte di Stalin nel 1953 il confine si era progressivamente sgretolato da solo, eroso dalla vita stessa, che non aveva mai smesso di pullulare da ambo le parti di quella linea, immaginaria e concreta allo stesso tempo. Nella mia memoria di bambino degli anni settanta e di ragazzo degli anni ottanta, quel confine significava guardie svogliate che chiudevano entrambi gli occhi sul contrabbando di carne, benzina e sigarette. Nemmeno le guerre jugoslave degli anni novanta avevano portato a un irrigidimento della routine confinaria. Nel 2004 la circolazione era diventata finalmente libera a tutti gli effetti. Poi nel febbraio del 2020, da un giorno all’altro, sul confine sono comparsi i jersey, i soldati armati, i lince dell’esercito, per tenere il virus fuori dai confini della Nazione. Primo ministro era Conte, e ministro dell’Interno Lamorgese, col suo luogotenente sul confine orientale Piantedosi. Col pretesto della lotta al virus avevano militarizzato il confine, rendendo impossibile la vita di chi a cavallo del confine ci vive. Il tutto, in realtà, in funzione puramente anti-immigrazione. La presunta lotta al virus aveva reso digeribile, anzi proprio appetibile, anche ai liberalprogressisti ciò che fino a quel momento nemmeno i governi fascioleghisti avevano osato proporre. Quei jersey e quei soldati armati fino ai denti non se ne sono più andati. Dopo il covid è arrivata la guerra in Ucraina, e poi c’è stato il 7 ottobre, e ogni emergenza è stata buona per prorogare la chiusura del confine. Sono passati 5 anni e ora, nel 2025, ogni confine interno della UE si è riempito di guardie armate fino ai denti, e ogni paese è diventato un clone dell’Ungheria di Orban.
Ciao a tutti e tutte e grazie Stefania e Cristina per questo volo a planare, me lo sono veramente goduto. Volevo provare ad aggiungere un piccolo contributo.
Uno dei byproducts o strascichi della faglia pandemica è l’aver spinto i rimasti dritto dritto tra le braccia delle destre neofasciste.
Era già sotto i nostri occhi a pandemia in corso – e difatti veniva ampiamente discusso qui su Giap – il profitto per così dire politico che i proto-rimasti stavano ogni giorno di più concedendo a mestatori e pifferai vari. Vi ricorderete sicuramente il centratissimo filone dei nuclei di verità, delle sofferenze sociali alla base di certe reazioni scomposte, l’accontentarsi di qualsiasi racconto alternativo che in qualche modo potesse fornire riparo dalle vibrazioni della violenza con cui veniva sospinto il racconto ufficiale.
Ecco, la faglia che si stava aprendo allora è diventata oggi una frattura vera e propria. Molti dei rimasti, se non tutti, considerano quella dei tempi pandemici una ferita che arriva fin dentro la psiche individuale, una voce inascoltata che ancora cerca di uscire. Gli unici ad aver ascoltato sono i fascisti, che, come sempre succede, fanno cassa a ruspa, garantiscono soluzioni semplici e facilmente comprensibili a problemi complessi.
Basti pensare al governo Trump e come l’anti-vaccinismo più bieco sia innestato a pettine nella totalità della sua compagine, ma anche la mondezza a noi più vicina, ancorché sommersa dalla piena dell’europeismo di guerra, ha fatto incetta di esponenti anti-vaccinisti pronti a strizzare l’occhio a una certa classe di opinione per capitalizzare quanto più possibile gli echi delle vicende pandemiche.
Concludo ringraziando Tuco: secondo me ha colto nel segno. Il ritrovato amore per il filo spinato è stato ri-abilitato e ri-ammesso proprio durante la pandemia. Ricordo con simpatia i suoi piccoli reportage della bicicletta in giro per il nordest, nei quali segnalava proprio l’ispessirsi di confini e posti di blocco.
N.B. Ricordiamo che tutti i nostri interventi di critica alla gestione politica della pandemia, alla “logica” dei provvedimenti, alla creazione continua di capri espiatori, alle fallacie logiche del green pass ecc. – interventi che vanno dal febbraio 2020 a oggi – si trovano qui.
[…] Se sei una/un tipa/o nervosetta/o non riuscirai a leggere l’articolo dal sito di Wu Ming Foundation, scritto da 2 studiose e ricercatrici universitarie Stefania Consigliere e Cristina Zavaroni (loro CV di studio e lavoro, al piede dell’articolo sul sito di Wu Ming Foundation) e, in questo contesto, valuta l’ipotesi di essere tu in errore. Se non sei le precedenti cose, hai qualche possibilità di arricchire il tuo patrimonio conoscitivo. Ovviamente non si tratta di un articoletto breve né elementare, oltretutto bisognerebbe accordarsi sulle premesse, quindi ti avviso che serviranno parecchi minuti di buona concentrazione per seguire, capire e pensare MA se rientri nell’altissima percentuale di italiane/i che non sanno tenere l’attenzione su un testo per più di una manciata di secondi, ahimè, l’articolo delle 2 ricercatrici, non fa per te, nemmeno per finta. E con questo spero di averti irritata/o così tanto da indurti, per ripicca, a leggere TUTTO il testo delle 2 studiose, comprese le NOTE di Wu Ming alla fine, perché ne vale proprio la pena. https://www.wumingfoundation.com/giap/2025/07/rimozione-forzata-cinque-anni-post-covid/ […]
ciao,
vado in leggera controtendenza con quanto raccontato nell’articolo, segnalando che proprio laddove le chiusure del covid hanno colpito più duro, ho visto risposte e ricerca di analisi e dialogo: le scuole superiori.
Porto un paio di esempi: la bellissima mostra ” Respir-arti ” del liceo artistico di Bologna, esposta al Parco della Chiusa di Casalecchio nell’estate del 2021 ed un lavoro di approfondimento extracurriculare al Liceo da Vinci sempre di Casalecchio ( https://www.liceovinci.edu.it/pagine/dopo-la-pandemia-i-giovani-a-scuola-tra-disagio-social-media-e-tecnologie-digitali )
Li ho notati come cittadino non utente (non ho figli al liceo ancora) quindi magari me ne sono persi molti altri di approfondimenti simili. Però mi sembra importante che proprio i giovani, colpevolizzati e le prime vittime delle scelte di allora, affrontino la problematica e non se ne dimentichino.
Un grosso grazie per questo articolo importante e necessario. Sono sostanzialmente una “rimasta”, ma di sicuro sono stata anche in parte “disvedente”, almeno agli inizi. La pandemia e la sua gestione hanno lasciato un segno profondo, mi viene da dire avanti covid e dopo covid, perché certe cose sono cambiate e non torneranno più come prima. A livello personale posso dire che quel poco di fiducia che avevo nelle istituzioni si è completamente sgretolato. I vari lockdown prima e il famigerato green pass poi hanno rappresentato un punto di non ritorno. Non voglio dilungarmi, ma credo che non dimenticherò mai quello che è successo a Trieste, una pagina vergognosa per questo paese, e non dimentico chi sedeva al governo in quei giorni. Ultima considerazione: credo che per la prima volta nella mia vita mi sia capitato, se non di autocensurarmi, comunque di essere molto guardinga nelle mie esternazioni, anche con amici. Mai avrei immaginato di vivere una cosa del genere. Interessante quello che ha notato massimo-zanetti, è un segno che c’è ancora speranza. P.S.: ho scoperto Giap nel periodo della pandemia e leggervi è stato un conforto e un’opportunità di riordinare idee ed emozioni.
Ora anche in castigliano:
Eliminación forzada. Cinco años del confinamiento y (fingir) no sentirlos
https://aesteladodelmediterraneo.wordpress.com/2025/07/19/eliminacion-forzada-cinco-anos-del-confinamiento-y-fingir-no-sentirlos/
La settimana scorsa ha fatto discutere lo spot pubblicitario di un’azienda israeliana che produce droni ad uso bellico. Lo spot consiste in una soggettiva dal drone che inquadra un uomo disarmato e poi lo uccide. Lo spot mi ha immediatamente catapultato, per associazione di idee istantanea, nell’aprile del 2020, quando l’allora sindaco di Messina Cateno De Luca mostrava orgoglioso ai giornalisti i droni che aveva sguinzgliato per la città per far rispettareil lockdown, con la sua voce registrata che intimava ai “furbetti della passeggiata”: “Torna a casa! Dove cazzo vai! È Cateno De Luca che ti parla! Torna a casa! Dove cazzo vai! È Cateno De Luca che ti parla!” E così via. Anche in quel caso il video (pubblicato sul sito di Repubblica) mostrava la soggettiva dal drone che puntava due passanti. Ora, lo so benissimo che i droni di Cateno de Luca non sparavano (ma conosco alcune persone che non lo avrebbero trovato sbagliato…). Il punto però è che c’è una evidente linea di flusso che collega l’accettazione dei droni di Messina all’accettazione dei droni di Gaza.
Eccomi, sono un rimasto pandemico! Ma non entro nel milione di cose che sta vicenda sempre attizza. Ne aggiungo una, non bastasse il milione: a scrivere sono due antropologhe. Quanti antropologi, psicologi, pedagoghi, non parliamo di epistemologi, abbiamo visto nei talk-show? La scienza era quella dei virologi, dei biologi molecolari, degli infettologi. La “scienza”. Sarà un mio personale pallino ma una delle cose che proprio non digerii fu quel “non credi nella scienza”, che avrebbe dovuto primeggiare nell’elenco delle “contraddizioni logiche”. Dalla critica allo scientismo fino alla veneranda ghigliottina di Hume, tutto risucchiato dalla nuova fede nella coppia lockdown/vaccino. Se “Il focus dell’articolo è sull’emergenza pandemica come laboratorio di controllo sociale”, beh, non credo che questa cosa la focalizziamo pienamente smettendo di parlare di virus e vaccini. La costruzione della scienza-totem, virus e vaccini, è stato mi pare il passaggio fondamentale per mettere in riga. Insomma, parliamone de sta scienza…
La società fu “messa in riga” ben prima, a partire dal 9 marzo 2020.
È in quel frangente, nel tardo inverno del 2020, che l’approccio virocentrico, ratiosuprematista, scientista – in realtà una narrazione di copertura di fallacie logiche, provvedimenti infondati sotto l’aspetto epidemiologico, ricerche ossessive di capri espiatori – si fece prevaricante. Il passaggio fondamentale fu l’imposizione, anche mobilitando VIP che mandavano videomessaggi dalle loro residenze enormi, dello stare chiusi in casa a prescindere.
Il primo vaccino anti-Covid, il Comirnaty (Pfizer-BioNTech), fu autorizzato in UE solo nel dicembre 2020. La prima vaccinata in Italia fu un’infermiera dello Spallanzani di Roma, il 27 dicembre 2020. Il vaccino arrivò al resto della popolazione solo nei primi mesi del 2021.
Lo stare-in-casa, la “lockdown culture”, il coprifuoco, la repressione, gli abusi duravano – e noi li criticavamo – già da un anno.
Non fu dunque la campagna vaccinale a imporre tutto ciò che ho appena elencato, né fu necessario attenderla per sviluppare un pensiero critico su quanto stava accadendo.
Io continuo a pensare che i discorsi “vaccinocentrici”, il vero e proprio feticismo della questione vaccini che si continua a riscontrare in molti “rimasti”, abbia imposto una visione angusta, concentrando tutta l’attenzione su un solo aspetto di una vicenda gigantesca, facendo sprecare tempo ed energie, e spingendo a dichiarare inimicizie lungo linee di frattura sbagliate, una su tutte: vaccinati contro non-vaccinati. Un diversivo che ha fatto il gioco di Draghi & Co.
Noi seguimmo da molto vicino la mobilitazione No Green Pass di Trieste per la sua composizione prevalentemente operaia e, soprattutto, perché tra le parole d’ordine c’era questa, chiarissima: «Vaccinati e non-vaccinati insieme contro il Green Pass». Era la linea giusta, ma purtroppo fu adottata in pochissimi posti, perché prevalse la linea «vaccinati = covidioti», «se ti vaccini muori», «siringato = zombi» ecc.
Una piega che, in giro per l’Italia, rese le manifestazioni sempre più escludenti, respingenti, rivolte solo alla minoranza che non voleva vaccinarsi e precluse all’enorme maggioranza che aveva deciso di farlo, o non poteva permettersi di non farlo. Dentro quella maggioranza molte persone percepivano comunque l’assurdità e ingiustizia del GP e ne vivevano i disagi, ma le manifestazioni erano anche contro di loro. Manifestazioni che dunque si condannarono da sole a non potere crescere, all’inconcludenza, allo sfogo e nient’altro.
Onestamente, io non credo abbia la minima utilità seguire ancora oggi un simile andazzo. Credo che Tuco volesse dire questo, e sono d’accordo con lui.
Esatto. Prima del “vaccinati e non rompere i coglioni” c’è stato il “chiuditi in casa e non rompere i coglioni”. Ci sono stati i droni di Cateno De Luca e i lince di Fedriga, la caccia al runner sulla spiaggia di Pescara e quella ai raccoglitori di asparagi sul Carso, il rendering dei cubicoli in plexiglas per salvare la stagione balneare a Riccione, i banchi a rotelle nelle scuole, il proclama del comandante alpha, le navi lazzaretto per i vecchietti delle case di riposo…. E si potrebbe continuare per ore e ore. Siccome questo virus non è ontologicamente diverso dagli altri virus, e questo vaccino non è ontologicamente diverso dagli altri vaccini, evidentemente c’è dell’altro, se la linea del tempo è deragliata così malamente; ed è questo altro che va smontato, analizzato e contrastato, perché continua ad agire nel pesente.
Il dibattito è interessante anche perché mostra lo “schiacciamento” temporale che si produce come conseguenza di essenzialmente ogni evento storico particolarmente traumatico, su cui spesso i potenti fanno affidamento per evadere le proprie responsabilità e far sembrare il fatto storico una sorta di fatalità. Forse è proprio grazie all’attenzione costante e ai post in continua evoluzione “dal vivo” che Giap ci dà una visione d’insieme che è soprattutto ora, dopo il fatto, utile, disegnando quella parte diacronica che per la maggior parte delle persone in generale è ormai completamente sfumata, irriconoscibile nella sua sequenza.
Infatti. L’archivio a disposizione di chi consulta Giap permette di ricostruire la sequenza, anche se bisogna avere enormi quantità di tempo e pazienza (sono circa una settantina di post e migliaia di commenti). Sarà utile a storiche e storici, perché per tutto il periodo dell’emergenza pandemica, senza pause, discutemmo gli eventi giorno per giorno, si va veramente dal presunto “paziente zero” al ritiro degli ultimi provvedimenti. Noi e la comunità che si era creata non smettemmo mai di interrogare la situazione, di esercitare la critica. Critica non solo di com’era gestita politicamente l’emergenza e delle narrazioni tossiche mainstream: anche di contro-narrazioni minoritarie ma non meno tossiche, che da allora si sono incancrenite.
Ecco, uno dei problemi di una dicotomia troppo rigida tra “disvedenti” e “rimasti” è che ingenera un equivoco di fondo, si ha l’impressione che i “disvedenti” non ricordino più niente mentre i “rimasti” ricorderebbero tutto. Invece non è così, anche molti “rimasti” hanno esercitato una memoria fortemente selettiva e al posto della linea del tempo hanno ormai un garbuglio. Molti collocano la questione dei vaccini già all’inizio dell’emergenza pandemica, mentre arrivò a metà. Oppure, e in certi casi i due errori coincidono, collocano la loro ribellione già all’inizio, quando invece cominciò con l’arrivo del vaccino, o addirittura con l’imposizione del green pass.
Tutto quello che accadde nel primo anno di pandemia è oggi nebuloso, ed è quasi cancellata la memoria delle poche e meritorie lotte e manifestazioni che ci furono prima che arrivassero i vaccini, anche quelle seguite passo passo – quando non direttamente organizzate – qui su Giap, e speriamo che un giorno qualcuno lo usi bene, quest’archivio, per ricostruire quella stagione.
La storia del proclama del comandante Alfa merita di essere riportata alla luce. Qua si può trovare il testo completo.
Era il 23 marzo del 2020, e no, non si tratta di folklore, si tratta di un segnale fuoriuscito per sbaglio dal buco nero degli apparati. C’è stato un momento in cui la destra più pura e feroce era entusiasta del lockdown, invocava il coprifuoco, chiedeva l’esercito nelle strade, ed era lontanissima dall’idea di mettersi a cavalcare il malcontento popolare per il confinamento di massa. Questa storia manda in frantumi tutte le narrazioni codificate sull’emergenza covid, quella del centrosinistra, quella del centrodestra, quella dei compagni per la reclusione, quella dei fascisti, quella dei “cinesi”, quella dei complottisti che sarebbero comparsi sulla scena nei mesi successivi… Per capire veramente cosa è successo nel biennio pandemico bisogna tornare alla rivolta carceraria del 9 marzo 2020, al tintinnar di sciabole, al rumore secco degli scarponi dei militari sul selciato delle strade deserte, ai carabinieri di Piacenza che durante il lockdown torturavano piccoli spacciatori al dettaglio per rubargli la roba. Per trovare lo stesso senso di onnipotenza, la stessa euforia che inebriava le forze dell’ordine durante il primo lockdown, bisogna tornare con la memoria al G8 di Genova.
La cosa che dà più amarezza è che molti compagni non si accorsero di nulla, anzi, accettarono tutto con convinzione, buttando merda addosso a chi fin da subito aveva denunciato quel che stava accadendo. Il 1 maggio 2020 a Trieste scendemmo in piazza in un centinaio, per festeggiare la liberazione della città dal nazifascismo, coi nostri corpi e le nostre voci, dal vivo. Alcuni di noi si beccarono anche una denuncia dalla digos. Ricordo certi “compagni” che ci accusarono di essere nazisti eugenetici. Dove siano posizionati ora questi “compagni” è facile da immaginare.
Mi permetto di insistere. I danni che poteva fare questo virus, purtroppo li abbiamo visti. Le condizioni che ha trovato, non le ha certo create il virus e spero che nessuno, almeno qui su Giap, creda siano state create ad arte per imporre questi vaccini (né nient’altro). Vaccini che per fortuna e purtroppo sono l’unico strumento innovativo che ci ha lasciato in eredità la pandemia. Per il resto, poteva tranquillamente essere il 1420 anziché il 2020. Stracci davanti alla bocca, isolamento, preghiera e (soprattutto) penitenza.
Questo non significa che non si possa discutere nel merito di vaccini, politiche vaccinali e di industria farmaceutica privata finanziata con soldi pubblici. A parte che tutto ciò che di utile si può dire, è tranquillamente riassumibile nella critica del capitalismo. Ma il fatto che la vaccinazione sia stata uno snodo significativo della messa in riga della società, non si può certo comprendere partendo dai vaccini.
Come hanno detto molto meglio di me Wu Ming 1 e Tuco, c’è un anno di nefandezze precedenti a dimostrarlo. Si potrebbe partire già dal troppo presto dimenticato “popolo dei balconi”, nato dalla spontanea voglia di leggerezza (e di aria) della gente, ma subito (auto)irreggimentato in happenings un tantino in stile sabato fascista. Io in quei balconi pieni di simulacri umani che battevano le mani e urlavano slogan insulsi in un surrogato reazionario di socialità e partecipazione, vedevo la moglie di Montag, il protagonista di Fahrenheit 451 di Bradbury.
D’altra parte il passaggio dalla balconizzazione alla balcanizzazione è stato un lampo. I balconi sono diventati il luogo da cui si sorvegliava il vicino di casa e magari lo si denunciava – o quantomeno lo si sputtanava su Facebook – se usciva di casa senza una ragione. In alternativa, si esaminava la borsa della spesa del vicino di fila al supermercato, in cerca di beni voluttuari che inchiodassero il farfallone incapace di adeguarsi allo spirito del momento, tipo dolciumi o peggio ancora alcolici. Sia mai preservativi.
Da lì è stato un precipitare verso l’abisso. Perfino in questo blog abbiamo letto interventi di persone che ritenevano giusto far pagare le spese mediche ai malati non vaccinati, come se ci fosse bisogno anche di una spinta dal basso (e da sinistra) per abbattere il principio di un sistema sanitario gratuito e universalistico.
Quelli eravamo noi, dio boia. Da prima dei vaccini. Ce n’è di roba da dis-disvedere, anche allo specchio, altroché…
«Ma il fatto che la vaccinazione sia stata uno snodo significativo della messa in riga della società, non si può certo comprendere partendo dai vaccini.»
Rimane il fatto che la narrazione ufficiale si è focalizzata su quella linea di separazione all’interno della società; per molte ragioni ma non credo sia accaduto per caso. E comunque ha funzionato benissimo. Si è effettivamente occultato il fatto che vaccinarsi era (ed è) un privilegio riservato a chi se lo può permettere.
Cooptata da destra e abbandonata da sinistra molta/troppa gente ne ha fatto una questione di libertà alimentando complottismo e confusione.
Il virus invece stava rendendo palese una caratteristica della sovrastruttura. La salute è ormai una condizione alla quale siamo indotti dal sistema stesso ad aspirare; si è sani soltanto nella misura in cui ci si può permettere di esserlo.
Non solo, ma con il Green Pass questo occultamento si risolveva implicitamente anche nella punizione sociale. In altre parole, chi non poteva permettersi di vaccinarsi doveva subire la mortificazione suprema, nella quale il vaccino era una scusa e la condizione sociale l’obiettivo effettivo. È un angolo interessante, però avrà avuto variazioni da paese a paese, a seconda della qualità dello stato sociale (forse negli Stati Uniti questo particolare effetto si è sentito ancora di più, ma lì se non sbaglio non hanno mai avuto nulla come il green pass). Non proprio on-topic, ma la frase sulla salute come qualcosa a cui aspirare mi sembra trovare conferma nella cultura neolib dell’autoaiuto et similia, dove ci si concentra molto nello sforzo e sulla diligenza individuale per raggiungere un benessere anch’esso puramente individuale. Insomma la massima potenza dell’idea della salute (soprattutto mentale) come bel traguardo da raggiungere, che tra l’altro, e credo non a caso, circola principalmente nella classe imprenditoriale. Questa stessa filosofia (se così la si può chiamare) ha avuto una spinta enorme durante e dopo il covid, probabilmente perché i rinchiusi in casa per il lockdown ebbero bisogno di una forma di psicologia consona alle aspettative liberiste, con tante, ma proprio tante app dedicate a monitorarti(!) e a seguire passo passo i tuoi progressi atomizzati.
«[…] chi non poteva permettersi di vaccinarsi doveva subire la mortificazione suprema, nella quale il vaccino era una scusa e la condizione sociale l’obiettivo effettivo.»
Siamo sempre li. Parliamo del “Global North” dove quella del vaccinarsi o meno è una decisione che al soggetto è concesso valutare e prendere o meno. Ad altre latitudini e per altri ceti sociali no.
Milioni di esseri umani letteralmente non possono permettersi di prendere questa decisione; per semplici ragioni economiche. Giovani e anziani in condizioni di salute precarie, donne uomini e bambini afflitti da malattie croniche, carceratx, milioni di persone che sopravvivono al di sotto della soglia di povertà.
Basterebbe buttare un occhio alle statistiche ufficiali in India, per esempio.
Inquadrando in primissimo piano il green pass, il “caso italiano”, significa abbandonare la prospettiva, il campo lungo che è invece imprescindibile per un’analisi ragionata e ragionevole di ciò che è accaduto a causa Covid 19.
Cristina e Stefania hanno scritto: «Sanare nel singolo una ferita che si riapre continuamente perché ciò che la provoca è collettivo.»
Che è verissimo. Il processo però deve necessariamente avere inizio nel singolo, da un lavoro del/nel personale. As a matter of urgency.
«Rimane il fatto che la narrazione ufficiale si è focalizzata su quella linea di separazione all’interno della società; per molte ragioni ma non credo sia accaduto per caso.»
No, non per caso. Ma certo neppure per le peculiarità di questi vaccini o per la vaccinazione in sé. E’ evidente che, almeno in tempo di pace, nulla possa produrre una separazione così netta all’interno della popolazione come la scelta di vaccinarsi o meno durante una pandemia. La narrazione colpevolizzante (e autoassolutoria) non poteva che andare a parare lì. Ma a un certo punto, in assenza di vaccini, temo sarebbe bastato che per contenere il virus si rendesse necessario sopprimere tutti i gatti domestici, per assistere a una versione tragicomica di quello che abbiamo visto. E chissà quanti ultras della strategia zero-Covid si sarebbero trovati all’improvviso dall’altra parte della barricata, per non dover sacrificare il proprio amico felino.
Per giunta, oggi che del tuo status vaccinale non interessa più nulla a nessuno – com’è giusto che sia – non siamo stati forse divisi altre mille volte nei modi più fantasiosi dalle narrazioni del potere? E’ vero che nessuna di queste narrazioni fa presa allo stesso modo, ma solo perché nessuno qui ha davvero paura di morire. E dove hanno giustamente paura di morire, su questo sono assolutamente d’accordo, non c’è alcun diritto di scelta.
Ho provato un po’ di conforto nel vedere questo spazio di discussione: sono circondato da persone che considerano parlare della pandemia come un rivangare inutilmente il passato.
Io ho cercato, in maniera al limite del marziale, di seguire le procedure. Sono arrivato al punto di essermi incazzato con mio padre perché, durante il funerale di mia nonna, morta per il covid, ha abbracciato la bara, contro le direttive sanitarie di quei tempi. Ripensandoci, provo un forte senso di vuoto: dov’ero io in quel momento, questo io che adesso sa che chiedere una cosa del genere è gesto atroce? Dove sono stato in quegli anni? Ma soprattutto: chi c’era al posto mio?
E d’altronde, più io mi impegnavo nel rispetto delle direttive e dei regolamenti, più mi accorgevo di quanto io fossi fragile, anzi, proprio debole, di fronte alla pandemia. Il divario tra il richiamo all’ordine, costantemente urlato e contornato da minacce, e quello che effettivamente io ero (un giovane che, a causa del confinamento, sconfinava sempre più nell’obesità) e riuscivo a fare mi ha lasciato una ferita: ancora oggi, è come se mi percepissi sempre mancante di fronte alla Legge. Come se io fossi strutturalmente incapace di poterla rispettare al 100%. Non perché ribelle o rivoluzionario: ma proprio perché disabile nel farlo.
E, in alcuni giorni, lotto contro la paura di venire perseguitato da chissà quale funzionario, per chissà quale infrazione commessa in passato.
Tuttavia, una volta fuori dalla pandemia, ho cercato di reagire: mettendomi in forma e abbandonando qualsiasi forma di interazione basata sulla competizione o sul rigore. Ho cercato di coltivare amicizie fondate sul mutuo soccorso emotivo, al fine di poter vedere nell’Altro non qualcuno che possa denunciarmi, ma qualcuno che possa almeno comprendere – cioè prendere un po’ con sé – la mia debolezza.
Però, tutto ciò si infrange contro la diffusione di un retorica eroica: siamo usciti dalla pandemia, quindi siamo più forti di prima. E mi spaventa chi ha deciso di adottare un atteggiamento sbracciante, trasformandosi in un carro armato emotivo che ironizza su chi, ancora, sta lì a parlare della pandemia, roba successa già “5 anni fa”.
Grazie a chiunque ha la forza mentale per poter scrivere con tale lucidità su queste questioni. Perché permette anche a persone come me di trovare le giuste parole per capire il proprio disagio.
Caro Gerardo, parto da tuo intervento e racconto qualcosa dal territorio dei rimasti, dove vivo da allora. Ricordo bene il 26 febbraio 2020, quando lessi l’articolo di Agamben sul Manifesto: pensai che esagerasse e che presto tutto sarebbe tornato come prima. Il giorno dopo partì il fuoco di fila di intellettuali e della sinistra contro di lui, non per discutere, ma per delegittimarlo. Mi colpì quella ferocia: qualcosa non mi tornava.
Da allora disposizioni a raffica: mascherine, green pass, vaccini che da una dose divennero cinque. I ricordi, come hanno scritto Stefania Consigliere e Cristina Zavaroni, sono confusi, ma restano alcuni episodi nitidi: la fuga con il cane oltre i 200 metri alla vista della volante, l’amica che perse il padre senza poterlo salutare, il cliente che raccontò di una cecità improvvisa dopo il vaccino, gli aperitivi clandestini coi vicini che ci ridavano vita, le chat che bollivano: amicizie frantumate dagli insulti.
Ho scoperto così che il territorio dove ero entrato, quello dei rimasti, era tutt’altro che deserto: vi abitavano tante persone, accomunate dal sentire che qualcosa non tornava in quello che stava accadendo e, per motivi anche molto diversi, dal rifiuto della vaccinazione.
Non era un luogo semplice: ci trovavi di tutto, ma proprio per questo eri costretto a non escludere nessuno in base a cosa pensava.
In questo territorio la destra ci è entrata subito con grande spregiudicatezza; la sinistra invece lo ha negato bollando gli abitanti come novax, complottisti, negazionisti (insopportabile: fascisti), mettendosi a guardia dei confini, per impedire che la gente uscisse e prendesse la parola ma anche per impedire che ci entrassero i suoi elettori. Eppure molti, come me, venivano proprio dalla sinistra.
Ho trovato sostegno nei libri, nel blog dei Wu Ming e soprattutto in un gruppo reale fatto da insegnanti, operai, professionisti, infermieri, disoccupati. Ci siamo dati una mano concreta: orto comune, biblioteca, incontri culturali, mutuo aiuto. Nessun capo, solo persone che si prendono cura le une delle altre. Un gruppo attivo, l’ultimo incontro pubblico che abbiamo organizzato, affollatissimo, con Giorgio Stern che ha vissuto in Palestina e nelle comunità native degli USA.
Forse un varco possibile si è aperto con la Palestina: l’orrore per quanto accade là è trasversale, ci ha uniti subito. Un varco che alla destra sicuramente non piace.
Un abbraccio Gerardo e un saluto a tutti.
Scusate se aggiungo una seconda riflessione.
Oggi ci siamo incontrati, nel nostro gruppo di rimasti, una sessantina di persone, per la riunione mensile. Contatti con la l’Istituto Ramazzini di BO per degli incontri pubblici sull’inquinamento elettromagnetico, ma anche cose terra terra, come un’uscita in bici. Un corso sui fermentati. Cose che possono sembrare poca cosa, ma tengono unite le persone. Una amica di cui ho molta stima, vicino a me, chiede se so qualcosa
dei recenti problemi informatici degli aeroporti. Mi parla di qanon e delle forze maligne che lo avversano. Con grande sincerità conclude: ho bisogno di credere un qualcosa di positivo di buono, in tutto questo disastro.
Che devo dirle? È una professionista laureata, una persona acculturata. È una persona buona. Ripeto, che devo dirle? Le sorrido e le dico che nn ne so nulla.
Ringrazio Dio che siamo un gruppo reale di persone, usiamo le chat solo per comunicare richieste, offerte, necessità, non per prenderci a sberle.
Mantenere relazioni e non spezzarle. Aprire canali di comunicazione. Oggi la quantità di persone in difficoltà economica ma anche psichica, è enorme, mi ci metto anch’io. Si capisce che la destra cerchi di rompere qualsiasi prospettiva unitaria, ma, e questa è la novità, con la complicità della sinistra. O almeno questa è la mia impressione.