di Stefania Consigliere e Cristina Zavaroni*
 1.Cronache di una primavera e di un autunno
1.Cronache di una primavera e di un autunno
Nei primi giorni di maggio, sul finire della cosiddetta fase 1, in un lungo post intitolato Ammalarsi di paura, analizzavamo l’inaudita gravità della situazione lombarda con gli strumenti dell’antropologia medica e dell’etnopsichiatria e proponevamo di includere fra le concause di quel disastro anche l’effetto nocebo indotto dal «terrore a mezzo stampa». Come molti testi nati in quei mesi, anche quello, in qualche modo, si era scritto da sé in tempi rapidissimi, in una sorta di stato non ordinario di coscienza indotto dal trattenimento casalingo.
Subito dopo, la fase 2 ha portato nuove questioni, nuove angosce, un’enorme stanchezza e un diverso registro di visibilità. Lungo l’estate il moto emotivo collettivo è andato nella direzione di un certo oblio: sperando che tanto la pandemia quanto il governo fossero in remissione, non abbiamo avuto voglia di fare i conti con ciò che avevamo appena vissuto. Troppo faticoso da elaborare e poi il virus non c’è quasi più, pensiamo a ripartire…
Quando la storia attraversata è traumatica e carica di angoscia, può capitare, sia ai singoli che a intere collettività, di aver voglia di pensare ad altro e “guardare avanti”, nel tentativo ambiguo di alleviare il carico emotivo senza fare i conti con le responsabilità. Luca Casarotti ha descritto questo processo, per un tutt’altro momento storico, nel suo discorso per il 25 aprile 2018. Dal punto di vista psicologico si capisce bene il perché di questa strategia, che però, alla lunga, è fallimentare e collusiva. E infatti ora, in mezzo alla seconda ondata autunnale, ci ritroviamo con una società profondamente trasformata, con le piazze presidiate da Forza Nuova, con regolamenti più assurdi di quelli primaverili, con una sinistra più polverizzata e residuale che mai, con il malessere psichico alle stelle e con una miriade di schegge tossiche infilzate nell’immaginario – a partire da quelle emesse dalla «bomba a frammentazione psichica» detta QAnon.
Bisogna riprendere il filo. Con dieci mesi di emergenza alle (e sulle) spalle, ma, anche, con l’aiuto di una letteratura critica che comincia a sedimentare, proviamo a portare innanzi il discorso cominciato a maggio e a trarre alcune delle conclusioni che, a primavera, non sapevamo articolare – prima che nuove fasi-due/tre/quattro, o il dolce oblio che già i giornali vanno orchestrando, ci distraggano.
2. Sull’utilità della storia per la vita
O forse i fili da riprendere sono due. Uno, più specificamente italiano (e tuttavia estendibile ad altre situazioni), è immediatamente politico e riguarda i modi paternalistici, terrorizzanti e polizieschi con cui la crisi è stata gestita, la violenza istituzionale di cui un’emergenza sanitaria è stata caricata. Il secondo filo, molto più generale ma anche meno visibile, riguarda l’assetto antropologico dell’Occidente contemporaneo, la sua strutturazione materiale e simbolica, il modo in cui dà forma agli umani che lo abitano. I due fili s’intersecano e, per molti aspetti, la terra dell’eterna emergenza è un osservatorio privilegiato. Ma mentre il primo è già ampiamente analizzato (soprattutto in questa sede), il secondo è molto meno visibile, più elusivo e scivoloso. È possibile, però, che sia proprio questo filo a permettere di spiegare alcuni dei fenomeni più inquietanti di questo periodo e, in particolare, l’appiattimento degli ambienti della sinistra critica su posizioni filogovernative.

La prima domanda da farsi è dunque: come siamo arrivati fin qui? Cos’è dovuto succedere, prima del virus, perché potessimo così prontamente rinunciare alle libertà fondamentali, allontanarci da amori e affetti, sospendere istituti sociali primari (il saluto ai morti e quello ai nuovi nati, ad esempio), prendercela con il vicino, percepire la presenza del prossimo come minaccia letale, accettare ogni invasione dell’intimità e lanciare volontariamente i nostri figli in pasto al drago telematico? Che tipo di addestramento cognitivo ed emotivo è necessario perché una storia dell’orrore come quella di QAnon risulti diffusamente credibile? Che idea di corpo, di salute, di malattia, di benessere bisogna avere per pensare che i colpevoli di un evento pandemico possano essere i bambini o chi va a correre in spiaggia? Si tratta, insomma, di capire come è stata costruita la soggettività contemporanea, lungo quali assi pulsionali, affettivi e cognitivi; quali sono i suoi presupposti; quale il suo “regime di veridizione” e i valori che la costituiscono.
Richiamiamo telegraficamente il quadro concettuale nel quale ci muoviamo, che il post di maggio articolava in modo più approfondito. Quando in antropologia si dice che un fenomeno è sociale, non s’intende affatto che esso sia di minor rilievo rispetto a un qualsiasi fenomeno di natura, perché non esiste fatto di natura – neanche il funzionamento del nostro genoma – che non sia preso fin dall’inizio in un intrico di relazioni e scambi, in un certo tempo, in una storia collettiva. Detto altrimenti: gli umani sono storici fin dall’inizio e fin nel profondo, vivono e muoiono delle verità messe a disposizione dal loro mondo e a esso, in larga parte e inconsapevolmente, si conformano. Se non lo facessero, non potrebbero abitarlo. Anche ciò che sembra più intimo e intangibile – la soggettività, il fatto di percepirsi come persone fatte così-e-così – è storica: dipende dagli assetti ontologici, culturali, economici, simbolici di un mondo umano; dalla distribuzione del potere che vi si pratica; dal tipo di rapporti ammessi e non ammessi. Solo conoscendo almeno un po’ questi presupposti si può prender parte e provare a modificare l’assetto: i tentativi di agire su un mondo culturale, e su se stessi in quanto elementi di quell’orizzonte, non possono che partire da un’apprensione critica dell’acqua in cui si nuota – apprensione faticosa, perché rivela le proprie collusioni e richiede una certa disponibilità alla trasformazione.
È dunque proprio nella storia recente e nei suoi presupposti che dobbiamo cercare le cause della trappola emotiva, concettuale, etica e politica nella quale, oggi, siamo presi. Se siamo così malmessi, non è per via di un destino ineludibile o di immutabili leggi di natura, ma a causa di ciò che è successo ai singoli e ai collettivi, dell’organizzazione delle nostre vite, dell’insieme di convinzioni e costrizioni che regolano i nostri giorni. Per via di un insieme di fattori che, se conosciuti, si può almeno provare a controeffettuare. In questo post ci concentreremo sull’idea di individuo e di salute di cui tutti, in quanto occidentali contemporanei, siamo in qualche misura portatori. Ancora una volta, chiediamo a chi legge una certa pazienza.
3. Esproprio
Nella sua forma egemone, la modernità è il mondo umano che ha preso forma in Europa, fra Cinquecento e Settecento, nella coalescenza di tre giganteschi processi storici: colonialismo, capitalismo e scienza. Senza l’oro, la manodopera e le sperimentazioni schiavistico-industriali delle colonie non ci sarebbe stata l’accumulazione primitiva. Senza la piega antropologica del protestantesimo, l’accumulazione primitiva non avrebbe innescato il circuito del plusvalore e la transizione al capitalismo. Senza la Scienza – intesa qui, al singolare e con la maiuscola, come «unico regime legittimo di veridizione» e poi come deriva scientista – non sarebbero state possibili l’oggettivazione del mondo, la giustificazione delle nuove gerarchie globali e il mito del progresso. Il convenire di questi tre fenomeni ha dato origine al potente dispositivo di centralizzazione e omogeneizzazione necessario al suo funzionamento (lo Stato nazione) e al tipo di soggettività richiesta dalla nuova configurazione (l’individuo).
Utopia del progresso e violenza del dominio vanno osservati insieme. Se da un lato la modernità si presenta come la realtà radiosa di un mondo di conoscenza, ricchezza, democrazia, libertà, salute e comodità tecnicamente assistita, dall’altro è costretta a occultare continuamente la violenza del plusvalore e di ciò che lo fa girare, e cioè l’esproprio. Marx ha descritto in pagine celebri l’esproprio dei produttori dai mezzi di produzione, battezzando questo processo «accumulazione originaria»: la sua violenza ha distrutto ogni modo altro di organizzazione, separando i soggetti fra loro e dall’insieme ecologico del loro mondo.
A partire da questa operazione di disvelamento, altri espropri sono diventati osservabili: quello coloniale, con l’appropriazione delle terre e l’ecatombe delle popolazioni; quello dei saperi autonomi dei collettivi umani, con i roghi delle streghe e l’instaurazione di un regime di “verità accademica”; quello delle conoscenze agricole con le piantagioni; quello del tempo di vita e delle capacità produttive con la disciplina di fabbrica; quello dei corpi, con la riduzione di quello maschile a macchina produttiva e di quello femminile a macchina da riproduzione e ricreazione; quello delle viscere del pianeta con l’estrattivismo; quello di apprendimento e invenzione tramite disciplinazione istituzionale; quello degli affetti tramite un patriarcato particolarmente crudele; e quello della qualità politica dell’esistenza umana con il totalitarismo e i campi. L’insieme di questi processi mira alla riduzione, e poi alla sparizione, dell’autonomia dei soggetti e dei collettivi in vista della traduzione di tutto ciò che costituisce la vita umana in merci o servizi acquistabili – e cioè, raggiungibili solo tramite la mediazione del denaro. La stessa esistenza soggettiva diventa un bene espropriabile.
4. Il soggetto monadico della modernità
Quest’immane processo di immiserimento ha avuto ripercussioni profonde sulla soggettività, sul modo in cui dev’essere costruita per risultare conforme alle mutate condizioni sociali. Il soggetto della modernità occidentale è l’individuo autonomo che tutti quanti, da quattro secoli, siamo tenuti a essere, il personaggio ideale ipotizzato dal diritto, dall’economia e dal grande romanzo dell’età borghese: auto-centrato, autosufficiente, nel pieno possesso delle sue capacità razionali, in stato di veglia, identico a sé; che trova in sé – e non nelle relazioni, nel cosmo, negli antenati – la propria ragion d’essere; che non considera le relazioni come parte fondante della propria identità e idealizza la sua interiorità come unico luogo dell’intenzione e della civiltà, squalificando sistematicamente tutti coloro che non la possiedono nelle sue stesse forme (gli animali “privi di anima”, le donne “istintive e poco razionali”, i bambini “umani dimidiati”, i non-europei “selvaggi e incivili”, i dormienti “pigri”, gli psiconauti “criminali”).
 Come ha argomentato David Graeber, l’individuo moderno eredita dalla sovranità dei re un certo grado di privilegio utopico: gode del benessere prodotto da condizioni strutturali che obbligano altri a lavorare per lui; dispone di un altissimo potere di accesso alle forze che governano la vita sulla terra – soldi, passaporto, medicinali, gadget tecnologici – e non è legato da vincoli di reciprocità. Il primo punto richiede forse un chiarimento: come notato dai femminismi, l’individuo teorizzato dalla modernità è, in primo luogo, maschio, bianco e benestante; gode quindi dei privilegi che derivano dalla strutturazione patriarcale, coloniale e di classe. Le lotte sociali hanno democratizzato alcuni di questi vantaggi a una fascia più ampia dei cittadini dell’occidente, ma senza eliminare del tutto la violenza che li sottende – una violenza globale che sarebbe ipocrita non osservare: se possiamo far benzina ai nostri mezzi a motore, è perché le comunità amazzoniche pagano il prezzo ecologico dell’estrazione di petrolio; se a Natale possiamo comprare ai nostri figli, per pochi euro, grossi giocattoli di plastica, è perché le operaie uccise nelle maquilladoras messicane ne hanno già pagato il prezzo; e via dicendo.
Come ha argomentato David Graeber, l’individuo moderno eredita dalla sovranità dei re un certo grado di privilegio utopico: gode del benessere prodotto da condizioni strutturali che obbligano altri a lavorare per lui; dispone di un altissimo potere di accesso alle forze che governano la vita sulla terra – soldi, passaporto, medicinali, gadget tecnologici – e non è legato da vincoli di reciprocità. Il primo punto richiede forse un chiarimento: come notato dai femminismi, l’individuo teorizzato dalla modernità è, in primo luogo, maschio, bianco e benestante; gode quindi dei privilegi che derivano dalla strutturazione patriarcale, coloniale e di classe. Le lotte sociali hanno democratizzato alcuni di questi vantaggi a una fascia più ampia dei cittadini dell’occidente, ma senza eliminare del tutto la violenza che li sottende – una violenza globale che sarebbe ipocrita non osservare: se possiamo far benzina ai nostri mezzi a motore, è perché le comunità amazzoniche pagano il prezzo ecologico dell’estrazione di petrolio; se a Natale possiamo comprare ai nostri figli, per pochi euro, grossi giocattoli di plastica, è perché le operaie uccise nelle maquilladoras messicane ne hanno già pagato il prezzo; e via dicendo.
C’è però un lato in ombra: se il sovrano è, per definizione, un uomo solo, soli saranno anche tutti i “sovrani di stessi”. In-dividuo significa “ciò che non può essere ulteriormente diviso”: i soggetti moderni sono tenuti a essere monadi, a vivere quanto più possibile in assenza di relazioni orizzontali, godendo di ciò che riescono ad accaparrare per sé in un mondo descritto, e quindi costruito, come inospitale, lotta di tutti contro tutti sullo sfondo di una natura matrigna che non dà mai a sufficienza. A verifica di questo mito fondante si possono rileggere le pagine iniziali di un qualunque manuale di economia. Fra gli umani si crea il vuoto: lo Stato e il mercato organizzano gli individui in quanto già separati, strappati dalla tessitura relazionale della vita; dal mondo scompaiono i fili che uniscono ciò che esiste in trame ecologiche di senso, rimpiazzati da un unico, invisibile cavo d’acciaio che vincola ciascuno al denaro e al mercato. La ricchezza di un individuo è l’insieme di tutte le cose che può fare senza negoziarle con altri; quest’assenza di legami è detta libertà.
 Per questo soggetto, l’isolamento dal mondo è al contempo protezione dai pericoli e legittimazione all’indifferenza. Sicuro del proprio prestigio (ben esemplificato da quello dei cittadini civilizzati rispetto ai barbari e ai selvaggi) e tecnicamente potenziato, forte della sua relazione con il denaro, depositario unico della coscienza, della conoscenza, dell’intenzione e del senso, l’individuo moderno è solipsistico. La regolazione dei rapporti fra soggetti non è pensata come un’interconnessione ma nei termini del diritto, e il diritto è solo dell’individuo (come dimostra la difficoltà di garantire protezione alle «persone non umane», la sordità dei giuristi al diritto delle comunità e lo stallo, individuale e istituzionale, che sperimentiamo di fronte a soggetti costruiti in modo diverso da noi).
Per questo soggetto, l’isolamento dal mondo è al contempo protezione dai pericoli e legittimazione all’indifferenza. Sicuro del proprio prestigio (ben esemplificato da quello dei cittadini civilizzati rispetto ai barbari e ai selvaggi) e tecnicamente potenziato, forte della sua relazione con il denaro, depositario unico della coscienza, della conoscenza, dell’intenzione e del senso, l’individuo moderno è solipsistico. La regolazione dei rapporti fra soggetti non è pensata come un’interconnessione ma nei termini del diritto, e il diritto è solo dell’individuo (come dimostra la difficoltà di garantire protezione alle «persone non umane», la sordità dei giuristi al diritto delle comunità e lo stallo, individuale e istituzionale, che sperimentiamo di fronte a soggetti costruiti in modo diverso da noi).
Si comprende meglio la logica del soggetto-individuo mettendola a confronto con quella del soggetto-dividuo descritto dall’antropologia, che si pensa a partire dalle relazioni che lo costituiscono, snodo di fili che originano altrove e che sono intrinseci e definitori di sé. Individualità e dividualità non esistono da nessuna parte in forma pura, sono poli ideali di un variegato campo di possibilità: perfino da noi, dove la strutturazione individuale è arrivata al grado più estremo, parti cruciali dell’esperienza sono meglio descritte come dividuali. Èil caso della parentela, persone «fatte della stessa sostanza».
Sta di fatto che lo sforzo per produrre individui è stato titanico: ci sono voluti secoli di potere disciplinare e di alienazione per separare gli umani fra loro e dai legami che danno senso alla vita, fino a ottenere soggetti abbastanza induriti da raggiungere gli altri solo tramite la mediazione invisibile del mercato; di raggiungerli, cioè, come merci o tutt’al più come partner d’impresa. In primo luogo, come visto, li si deve isolare; poi occorre mantenerli separati, impedendo che i legami si ricostituiscano. Applicata dapprima per disarticolare i mondi esistenti, la violenza viene poi impiegata per evitare la ricomposizione degli umani in collettivi che abbiano la pretesa di autodeterminarsi (le fasi di crisi del lavoro sono, da questo punto di vista, esemplari). E poiché gli umani tendono comunque a stabilire fra loro relazioni e vincoli di reciprocità che li muovono verso piste imprevedibili, bisogna intercettare e flettere questo movimento prima che prenda forma, fornendo a compenso i benefici che vengono dell’organizzazione coloniale dello sfruttamento e l’utopia di una vita senza dolore.
5. La salute come prestazione tecnica
La separazione dei produttori dai mezzi di produzione e l’erosione dell’autonomia di singoli e collettivi riguarda anche la salute. Nelle società a organizzazione non moderno-statale le conoscenze relative alla salute di base appartengono di solito alla collettività nel suo insieme. Le pratiche igieniche per non ammalarsi, il trattamento delle affezioni più comuni, l’impiego delle erbe medicinali e un certo “sapere del corpo” sono competenze diffuse, così come la capacità di prendersi cura dei neonati, dei bambini, degli infermi, degli anziani e dei morenti. Questo significa che la maggior parte della vita si svolge entro margini ampi di competenza e senza bisogno di delegarla a prestatori d’opera professionali. In questi contesti i terapeuti sensu strictu – e cioè coloro che detengono conoscenze più approfondite e competenze tecniche specifiche sulle malattie e sulle cure – vengono mobilitati soprattutto per le crisi che non si riesce a risolvere a livello di presa in carico comunitaria.
 A scanso di equivoci, non stiamo argomentando in favore di forme di primitivismo: il punto non sono i mezzi, più o meno sofisticati, di cura, ma la distribuzione delle competenze. Non a caso, nel fermento sociale, culturale e istituzionale degli anni Settanta, la qualità comunitaria della salute e il suo controllo democratico erano al centro della riflessione di molti movimenti antagonisti rivoluzionari, fra cui le Black Panthers; allo stesso modo, la più epocale dichiarazione programmatica dell’ONU – quella di Alma Ata del 1978, che al punto 4 recita «le persone hanno il diritto e il dovere di partecipare individualmente e collettivamente alla progettazione e alla realizzazione dell’assistenza sanitaria di cui hanno bisogno» – prendeva a modello l’esperienza cinese dei medici scalzi per promuovere la salute comunitaria.
A scanso di equivoci, non stiamo argomentando in favore di forme di primitivismo: il punto non sono i mezzi, più o meno sofisticati, di cura, ma la distribuzione delle competenze. Non a caso, nel fermento sociale, culturale e istituzionale degli anni Settanta, la qualità comunitaria della salute e il suo controllo democratico erano al centro della riflessione di molti movimenti antagonisti rivoluzionari, fra cui le Black Panthers; allo stesso modo, la più epocale dichiarazione programmatica dell’ONU – quella di Alma Ata del 1978, che al punto 4 recita «le persone hanno il diritto e il dovere di partecipare individualmente e collettivamente alla progettazione e alla realizzazione dell’assistenza sanitaria di cui hanno bisogno» – prendeva a modello l’esperienza cinese dei medici scalzi per promuovere la salute comunitaria.
A questa prima lezione antropologica su come le risorse di salute possano essere diversamente distribuite, se ne deve aggiungere una seconda, cruciale, sull’ecologia della salute. Ogni collettivo umano vive in profonda simbiosi, e in un rapporto di co-produzione reciproca, con ciò che chiamiamo “ambiente”: arie, acque, terre, viventi non-umani, ma anche milieu psichico, affettivo, cognitivo, miti, sogni e via dicendo. L’ambiente non è qualcosa di esterno, uno sfondo ostile o accogliente, un parco da colonizzare, ma l’esito di un modo di vivere e di stare in relazione fra umani e non-umani. L’autonomia e le risorse di salute dei collettivi si misurano anche sulla possibilità di intervenire sul proprio ambiente quando questo diventa patogeno – ovvero, di modificare le proprie pratiche e il proprio assetto di vita per mantenere o ripristinare la salute.
Tutto ciò viene profondamente minato dall’avvento della modernità, a partire dall’esproprio “originario” della terra, che distrugge un termine ecologico fondamentale, passando per l’imposizione del medico accademico come sola figura legittimata al gesto terapeutico, fino alla medicalizzazione integrale della vita (si pensi, ad esempio, al parto ospedaliero, alla delega al pediatra delle competenze genitoriali, alla morte in strutture dedicate, alla patologizzazione della devianza e dell’improduttività). Espropriati soggetti e comunità della possibilità di agire sull’ambiente, delle basilari competenze di salute primaria e della presa sui diversi momenti dell’esistenza, l’unica risorsa di salute disponibile è quella professionale e statale. La “via tecnica” alla salute diventa parte integrante del pacchetto del progresso e delle battaglie per la ridistribuzione sociale delle ricchezze.
«Una società industriale avanzata genera malattia perché rende gli uomini incapaci di controllare il proprio ambiente e, quando essi crollano, sostituisce una protesi «clinica» alle relazioni spezzate. Contro un simile ambiente gli uomini si ribellerebbero se la medicina non spiegasse il loro scombussolamento biologico come un difetto della loro salute, invece che come un difetto del modo di vivere che viene loro imposto (…). L’assicurazione di personale innocenza politica che la diagnosi offre al paziente serve come una mascherina igienica che giustifica un ulteriore asservimento alla produzione e al consumo.» (Ivan Illich, Nemesi medica, p. 174-175)
In parallelo ai processi di esproprio dei mezzi di salute e di statalizzazione e tecnicizzazione della medicina, l’origine della malattia si sposta sempre più verso l’interno dell’individuo: da esito di una certa configurazione ecologica e sociale (e parte ineludibile dell’umana finitudine), la malattia diventa un disfunzionamento privato, una falla nel funzionamento interno – meccanico, chimico, psichico – del soggetto, da affidare alle competenze certificate di un professionista e alla mano provvidenziale dello Stato. La morte stessa si fa impensabile: il soggetto della modernità ne è terrorizzato perché essa annulla il solo senso esistenziale possibile, quella della sopravvivenza individuale, del dominio sulle cose e del godimento; anch’essa, dunque, è stata progressivamente sottratta alla lavorazione culturale collettiva e affidata alle cure degli specialisti.
6. Capitale-salute
 Iniziati con la coppia Thatcher/Reagan e con la sconfitta del “decennio Sessantotto”, gli ultimi quarant’anni hanno portato la desertificazione relazionale e la guerra di tutti contro tutti fino a ciò che oggi chiamiamo “antropocene”. A partire dagli anni Ottanta la riconfigurazione neoliberista delle società occidentali ha comportato un’ulteriore stretta sulla soggettività. All’individuo razionale, autocentrato, competitivo e libero di muoversi nel mercato, richiesto dalla modernità capitalista, la governance neoliberista ha aggiunto capacità di auto-imprenditoria, trasparenza rispetto ai meccanismi di controllo, completa interiorizzazione delle leggi del mercato e disponibilità totale alla messa a profitto della propria vita (tramite lavoro salariato, consumo, soggezione burocratica, pubblicizzazione del privato e via dicendo). In tal modo, ha creato nuovi territori vergini da mettere a valore: dopo la colonizzazione delle terre, del tempo e dei viventi, ha trasformato anche l’interiorità dei soggetti in terra nullius passibile di appropriazione e sfruttamento, esattamente come i commons sui quali vivevano i contadini britannici o le ore della giornata lavorativa.
Iniziati con la coppia Thatcher/Reagan e con la sconfitta del “decennio Sessantotto”, gli ultimi quarant’anni hanno portato la desertificazione relazionale e la guerra di tutti contro tutti fino a ciò che oggi chiamiamo “antropocene”. A partire dagli anni Ottanta la riconfigurazione neoliberista delle società occidentali ha comportato un’ulteriore stretta sulla soggettività. All’individuo razionale, autocentrato, competitivo e libero di muoversi nel mercato, richiesto dalla modernità capitalista, la governance neoliberista ha aggiunto capacità di auto-imprenditoria, trasparenza rispetto ai meccanismi di controllo, completa interiorizzazione delle leggi del mercato e disponibilità totale alla messa a profitto della propria vita (tramite lavoro salariato, consumo, soggezione burocratica, pubblicizzazione del privato e via dicendo). In tal modo, ha creato nuovi territori vergini da mettere a valore: dopo la colonizzazione delle terre, del tempo e dei viventi, ha trasformato anche l’interiorità dei soggetti in terra nullius passibile di appropriazione e sfruttamento, esattamente come i commons sui quali vivevano i contadini britannici o le ore della giornata lavorativa.
Anche questo processo è noto e ormai ben descritto nei suoi effetti: dall’erosione del sonno all’aumento esponenziale di bullshit jobs, dal ruolo dei big data nel controllo alla diffusione a tappeto di sostanze, legali e illegali, che adattano i soggetti alla continua richiesta di prestazione (a scuola, sul lavoro, nello sport, nel gaming, sui social, a letto). L’esito scontato è l’innalzamento del malessere psichico e un livello ormai epidemico di disturbi depressivi e di ansia.
L’idea di salute si è ulteriormente ristretta: da qualcosa che lo Stato, bene o male, è tenuto a garantire ai cittadini, a un capitale individuale da far fruttare. Come il conto in banca, il raziocinio e l’autonomia, anche il benessere dei soggetti non è più questione politica ma pertinenza del singolo, un bene ontologicamente individuale che dipende esclusivamente dal proprio buon funzionamento interno. Se sei fortunato, nasci con una solida proprietà che potrai far fruttare in una lunga vita di salute e produttività; se sei uno come molti, hai in dotazione un piccolo patrimonio che ti conviene non sprecare; se nasci con un capitale-salute scarso… beh, peccato! Buttarti giù dal Taigeto ormai pare brutto e quindi, con gli ultimi residui di stato sociale, ti assisteremo in quanto categoria svantaggiata – ma sia ben chiaro che il problema è intrinsecamente tuo e nulla ha a che fare con l’organizzazione del mondo.
La salute diventa – come tutto, del resto – un gruzzoletto, un valore di scambio che partecipa alla solvibilità individuale (v., ad esempio, il modo in cui assicurazioni sanitarie possono accettare o rifiutare i possibili assicurati) e, quindi, ad assegnare una posizione nella gerarchia sociale. E poiché, per un individuo siffatto, null’altro dà senso al mondo se non il mero fatto di restare in vita per godere dei propri privilegi di consumatore e di cittadino del primo mondo, è chiaro che qualsiasi cosa metta a rischio questa condizione viene vissuto come una grave minaccia personale.
Qui eravamo quando, nel mese di febbraio dell’anno duemilaeventi, la diffusione di un agente patogeno di pericolosità media, unita al terrorismo mediatico e a misure contenitive di tipo poliziesco, ha mostrato con chiarezza esemplare l’esito politico, sociale e antropologico di questi processi. È qui che ora dobbiamo addentrarci.
7. Quod erat demostrandum
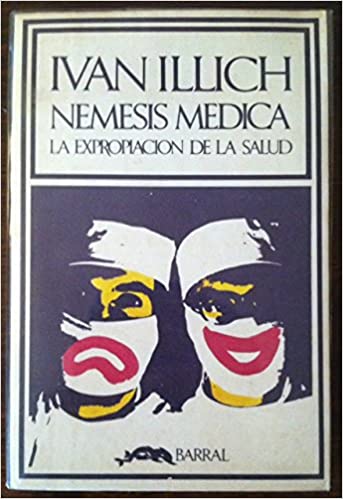 Riletto oggi, Nemesi medica di Ivan Illich fa l’effetto di una doccia scozzese: dapprima sollievo («finalmente qualcuno che mette in fila le cose!»); poi una serie di grattate dolorose alla sensibilità corrente (ad esempio le notazioni sulla patogenicità del sistema medico); e infine una sorta di vertigine quando ci si accorge che, a metà degli anni Settanta, concetti che oggi suscitano scandalo erano moneta corrente. La sua lezione più importante si può forse riassumere così: nessun punto della “macchina”, per quanto marginale, può essere cambiato senza modificare il sistema nel suo complesso. Da quanto tempo non si sentiva niente del genere…
Riletto oggi, Nemesi medica di Ivan Illich fa l’effetto di una doccia scozzese: dapprima sollievo («finalmente qualcuno che mette in fila le cose!»); poi una serie di grattate dolorose alla sensibilità corrente (ad esempio le notazioni sulla patogenicità del sistema medico); e infine una sorta di vertigine quando ci si accorge che, a metà degli anni Settanta, concetti che oggi suscitano scandalo erano moneta corrente. La sua lezione più importante si può forse riassumere così: nessun punto della “macchina”, per quanto marginale, può essere cambiato senza modificare il sistema nel suo complesso. Da quanto tempo non si sentiva niente del genere…
Il neoliberismo ha portato un’eclissi durevole dei guadagni teorici dei due decenni precedenti e reso quasi inascoltabili le parole di quell’epoca. E, soprattutto, ha parcellizzato e individualizzato processi e relazioni fino a polverizzare gli sguardi e le possibilità critiche: anche presso i soggetti più attenti, capaci di cogliere le storture e disposti a lottare per questa o quella causa, il quadro d’insieme risultava spesso inafferrabile.
Ora l’«evento-covid» arriva a sollevare il velo e rimette sotto gli occhi di tutti la profonda discrasia sistemica in cui viviamo – discrasia che non è stata causata dal virus: era già lì, ma non riuscivamo più a coglierla. La si può descrivere come la distanza che intercorre fra le esigenze del capitale e quelle degli umani (e degli altri viventi, e della terra). Il nostro mondo è ben organizzato secondo una logica di massimizzazione del profitto che mette tutto a servizio del plusvalore e si traveste, in circostanze ordinarie, da migliore dei mondi possibili. Finché le cose più o meno funzionano come ci aspettiamo, è difficile rendersi conto della qualità non-umana del suo assetto. È in circostanze non ordinarie, quando la logica umana di cura e solidarietà non può più essere aggirata, che ci si accorge di essere intrappolati nel letto di Procuste della logica del profitto, vincolati a una macchina che, dal punto di vista dell’umana esistenza, è completamente illogica. La logicità del sistema rispetto al profitto, e la sua illogicità rispetto alla vita, spiega la contraddittorietà del panorama che abbiamo di fronte ed è ciò che dobbiamo portare a tema in tutte le circostanze possibili.
Proviamo allora, in primo luogo, a tirar fuori dalla cantina i vecchi strumenti della teoria critica e a usarli per analizzare la pandemia in corso.
L’impostazione totalizzante e “oggettificante” della medicina high tech ha cominciato a essere percepita con inquietudine dai suoi stessi beneficiari: questo spiega, in parte, il fatturato delle medicine cosiddette «complementari e alternative». Sarebbe erroneo, però, tanto ridurre le perplessità dei pazienti a mistica new age, quanto non avvedersi che, su entrambi i fronti, gli operatori che davvero promuovono la salute e le capacità soggettive e comunitarie di prevenzione, cura e guarigione, non sono molti. Interessi corporativi, schiacciamento burocratico, pressioni industriali e puro e semplice profitto spesso hanno la meglio.
La concentrazione delle risorse di salute in macrostrutture dotate di tutti i macchinari di ultima generazione, a scapito della loro diffusione, è dannosa: non a caso, la centratura sugli ospedali, a detrimento dei presidi sanitari territoriali, è stata identificata fin dall’inizio della crisi come una delle cause principali del fallimento della sanità lombarda. Allo stesso modo, la produzione di plusvalore tramite la capitalizzazione dei bisogni di salute – nota anche come «privatizzazione della sanità» – ha rivelato durante l’epidemia tutta la sua inefficienza e il suo tasso di “perversione strutturale”. (In relazione alla Lombardia si veda, ad esempio, quest’intervista a un insider; ancora a scanso di equivoci, poiché la salute è sempre una faccenda collettiva, in discussione qui non è la sanità pubblica in quanto tale, ma la sua organizzazione, la sua catena di comando e la sua collusione con interessi economici contrari a quelli della salute globale.)

L’impossibilità di controllare il nostro ambiente giustifica il bisogno di tecnologie sofisticate per mettere una pezza sui mali derivanti dalla sua tossicità. A Taranto, dove la diffusione e la gravità delle malattie respiratorie dipende in modo palese dalle ciminiere dell’Ilva, è impossibile praticare l’arte medica senza prendere una posizione politica – senza agire in modo che i propri interventi terapeutici diventino, il prima possibile, superflui. Lo stesso vale oggi, mutatis mutandis, per lo stress che i territori più inquinati impongono al sistema respiratorio di chi li abita, come anche per la fragilità metabolica di popolazioni esposte a decenni di zucchero e junk food. Chi, in veste di terapeuta, voglia davvero curare i suoi pazienti, oggi non può fare a meno di interrogarsi politicamente sulle cause ambientali che precludono la guarigione e trasformano la terapia in mero controllo dei sintomi.
Se poi consideriamo la salute come un’ecologia di relazioni e ricchezza sociale a disposizione di una collettività (abitazioni decenti, ambiente non tossico, autonomia alimentare, socialità diffusa e affidabile, possibilità di agire positivamente sulla propria vita e su quella dei prossimi), allora lo stare in casa è, fra tutte, la misura più patogena che si potesse immaginare.
Quanto alla sottrazione della morte e del senso stesso della mortalità dalla presa dei soggetti, se essa non fosse già stata pressoché integrale prima della pandemia, immagini come quelle delle camionette dell’esercito che trasportano altrove le bare di Bergamo, o il divieto, decretato per legge, di assistere i propri anziani e i propri malati, sarebbero stati presi per quel che erano: violenze intenzionali, attacco ai legami fondamentali dell’umano vivere. La società contro lo Stato, scriveva Pierre Clastres – e viceversa.
8. Divide et impera
Fin qui le questioni sono di scelta politica e quindi, sia pure a fatica, articolabili. Messe sul tavolo, produrrebbero gruppi discordi, più o meno identificabili con una posizione sullo scacchiere, i quali, nel fronteggiarsi, si riconoscerebbero comunque come avversari legittimi. Altre partizioni sono più difficili da descrivere. Al contempo intime, meno legate all’appartenenza politica e più feroci negli effetti, hanno a che fare con gli effetti del neoliberismo sulla parte più profonda di noi, con la plasmazione inconsapevole a cui questi anni ci hanno esposti e con il nostro grado, consapevole e inconsapevole, di adesione.
Ligia ai dettami dell’individuo-monade, la stragrande maggioranza della nazione – inclusi molti di coloro che si atteggiano a critici del sistema – si è rivelata disposta a rinunciare alle proprie relazioni e a lasciarsi intrattenere entro le mura di casa; incline alla paranoia e alla difesa oltranzista del proprio gruzzoletto di salute; e nevrotica fino a prendere ogni perplessità come attacco personale e a raccogliersi minacciosa intorno a un nemico immaginario tacciato di “negazionismo”. La configurazione antropologica del neoliberismo è penetrata talmente a fondo da rendere uno stato sanitario di polizia più desiderabile del mondo nella sua interezza e della vita nella sua complessità.
Ancora una volta, si tratta di esproprio – e questa volta di tipo davvero particolare.
In linea con la necessità di creare sempre nuovi territori da mettere a valore, ciò a cui abbiamo assistito è un’innovativa applicazione dell’antico divide et impera. Oggi però la linea di divisione non è più solo quella che separa i soggetti e li isola, ma anche quella che divide i soggetti al loro interno. La paura, come la violenza, è una forza produttiva: perché possa agire, bisogna costringere i soggetti a ignorare i segnali in arrivo e a non concettualizzare quello che, pure, sentono chiaramente. I nostri corpi sanno benissimo che l’assenza di relazioni atrofizza il cuore e il cervello; che gli odori portati dai venti minacciano malattia; che l’insensatezza dei bullshit jobs diventa depressione; che d’estate non si può fare il bagno se il mare è cimitero – ma i nostri cervelli sono tenuti (e ben allenati) a rimuovere, razionalizzare, ignorare e disvedere. Se quel che sappiamo nelle cellule arrivasse a consapevolezza, l’impianto del dominio capitalista sarebbe in pericolo.
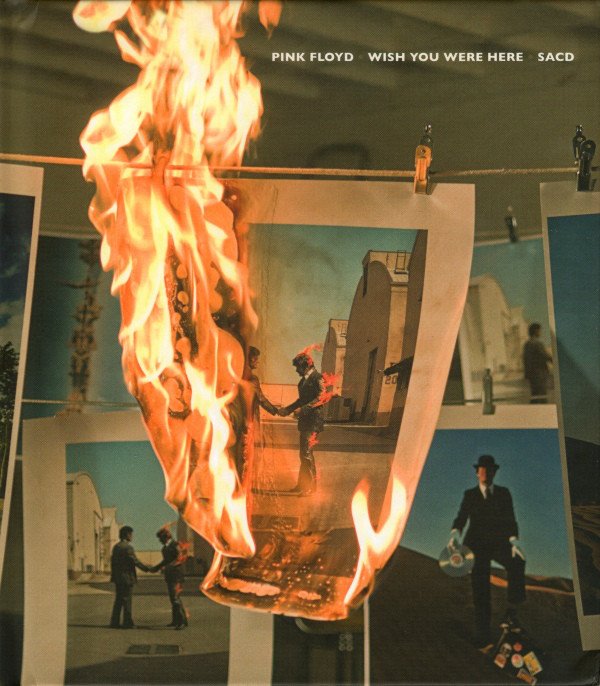 Di questa dissociazione coatta l’evento-covid ha dato la prova più piena e terribile che si potesse immaginare. Con il vecchio vocabolario marxista: ha mostrato che la sussunzione della vita e delle soggettività alle esigenze del capitale è (quasi) totale. A quarant’anni dall’inizio dell’offensiva neoliberista, la capacità collettiva di fare mondo e fare umanità, indispensabile nell’affrontare eventi eccezionali, è arrivata al suo minimo e pare integralmente delegata agli apparati dello Stato e dell’economia. Il cordone che ci lega a quel che resta della nostra traiettoria esistenziale (un tetto sopra la testa, la cittadinanza in una nazione europea, consumo e godimenti eterodiretti) ci impedisce di accorgerci che stiamo barattando la vita in cambio di una sopravvivenza neppure più “aumentata”; la gioia in cambio di godimenti tossici; la salute in cambio di uno stato di non-infezione. Soo-oo-oo, so you think you can tell… cantavano i Pink Floyd in un brano che, riascoltato oggi, fa male.
Di questa dissociazione coatta l’evento-covid ha dato la prova più piena e terribile che si potesse immaginare. Con il vecchio vocabolario marxista: ha mostrato che la sussunzione della vita e delle soggettività alle esigenze del capitale è (quasi) totale. A quarant’anni dall’inizio dell’offensiva neoliberista, la capacità collettiva di fare mondo e fare umanità, indispensabile nell’affrontare eventi eccezionali, è arrivata al suo minimo e pare integralmente delegata agli apparati dello Stato e dell’economia. Il cordone che ci lega a quel che resta della nostra traiettoria esistenziale (un tetto sopra la testa, la cittadinanza in una nazione europea, consumo e godimenti eterodiretti) ci impedisce di accorgerci che stiamo barattando la vita in cambio di una sopravvivenza neppure più “aumentata”; la gioia in cambio di godimenti tossici; la salute in cambio di uno stato di non-infezione. Soo-oo-oo, so you think you can tell… cantavano i Pink Floyd in un brano che, riascoltato oggi, fa male.
Il terrore del virus ha colpito molto al di sotto della zona cosciente delle nostre scelte e delle nostre opinioni; ha imperversato nella twilight zone dell’immaginario e dell’inconscio sociale, dove i tempi, la struttura sociale, la cosmovisione condivisa e gli eventi storici ci plasmano ben al di là della nostra consapevolezza. La questione cognitiva (chi vede il pericolo del virus non vede il pericolo politico, e viceversa) ha origine dalle diverse maniere in cui di ciascuno di noi è stato toccato, dal modo in cui abbiamo reagito “di pancia” alle paure indotte, da quanto ci siamo sentiti capaci di autonomia decisionale, dalla tenuta (o, viceversa, dalla fragilità) delle nostre relazioni, dall’affidabilità dei terapeuti di riferimento, dalla coerenza fra quel che pensiamo e come viviamo. Ha a che fare, quindi, con i fondamenti antropologici sui quali poggiamo i piedi, con le posizioni esistenziali più profonde, che non sempre corrispondono o sono armoniche con quelle dichiarate.
Impossibile sapere a priori dove ciascuno cadrà, come sentirà gli eventi, quali adesioni, collusioni e resistenze l’attraverseranno, così come non si può sapere a priori come i diversi soggetti si comporteranno nel pericolo o quale resistenza avranno al dolore. Per questo, come nella stasis (la guerra civile) greca, tutte le precedenti alleanze sono state annullate e messe alla prova degli eventi; per questo, anche, le fratture sono state così drastiche e dolorose: non avevano a che fare con le alleanze politiche, ma con qualcosa di molto più cruciale, con un’alleanza “esistenziale” che a volte, dove ci aspettavamo di trovarla, non c’era più. Spesso la reazione è stata di rabbia. È però possibile che, come suggeriscono le femministe statunitensi, la reazione appropriata sia piuttosto il lamento, il pianto di cordoglio: ancora un* altr* compagn* è stat* catturat*, un* altr* dei nostri reso impotente, un altro umano asservito a una logica non-umana.
9. Prender parte
Non c’è alcun bisogno di ipotizzare che quanto sta succedendo risponda a un piano qualchessia, dal momento che da sempre il capitalismo impiega le crisi – poco importa se piovute dal cielo o indotte – come volano. (E ad ogni modo, nell’orizzonte degli eventi detto “antropocene”, è ben difficile stabilire in che misura le epidemie siano esito di ricorrente sfortuna o effetto collaterale della distruzione ecologica.) Ma certo la risposta collettiva agli eventi ha dato preziose indicazioni a tutte le forze in campo che possono trarre vantaggio da un controllo ancor più stretto della popolazione. Bisogna muovere altrove con cortese urgenza.
Ci sono, per cominciare, una miriade di questioni politiche immediate su cui si sono mobilitati i diversi gruppi dell’attivismo nazionale, che da mesi discutono, si confrontano e avanzano proposte perfettamente sensate per intervenire sulla crisi in maniera meno raffazzonata, più equa e più efficace – per intervenire sulla scuola, sulla mobilità, sulle categorie professionali, sulla vita pubblica, sui territori e la distribuzione della ricchezza, in modo da ridurre collettivamente il rischio del virus senza trasformarci individualmente in zombie terrorizzati e terrorizzanti.
E poi c’è l’altro livello, quello del paradigma antropologico all’origine di questo disastro. Le ragioni per uscirne sono molte e di certo non sono nate quest’anno. La distruttività della moderna impresa capitalista, lo svuotamento di senso che essa induce, la violenza che infligge e l’infelicità che causa hanno cominciato a essere descritte fin dall’epoca del primo romanticismo; da Marx in poi, si può fare a meno di vederle solo accettando un certo grado di dissociazione. Oggi la dissociazione sembra un sine qua non per vivere nelle metropoli. E tuttavia, l’adozione intellettuale di posizioni critiche non basta: quanti raffinati decostruttivisti, quanti infervorati foucaultiani, quanti sublimi analisti delle “condizioni sociali” abbiamo visto, in questi mesi, ritirarsi spaventati sotto le gonne dello scientismo più becero all’insegna del “lasciamo che decidano gli esperti”, come se le epistemologie e le critiche sociali su cui hanno costruito le loro carriere fossero, in fondo, solo passatempi per gli anni di vacche grasse. È qui che, nei mesi scorsi, si è consumata la frattura fra posizione politica e posizione esistenziale. Certe posizioni politiche richiedono oggi una migliore tenuta dei fondamenti antropologici; altrimenti si finisce per cadere in quella che, negli anni Settanta, chiamavano critica-critica: un raffinato e sussiegoso ragionare al riparo dei propri privilegi di classe.
Non c’è stato solo questo, comunque – e per fortuna. A fronte dell’isteria maggioritaria, gli altri, quelli che sentivano il mondo in un’altra maniera, dapprima si sono sentiti pazzi. Poi hanno cominciato, ciascuno a suo modo, a reagire. C’è chi ha organizzato reti semiclandestine di preparazione e distribuzione di pasti; chi ha analizzato dati ed eventi in base alle proprie competenze; chi ha messo su gruppi di auto-aiuto; chi ha fatto vivere Giap. Molti oggi stanno pensando di andarsene dalle città e, fra i più giovani, la terra comincia a chiamare. Gruppi di lavoratori della sanità hanno veicolato analisi critiche e controproposte. La scuola è tornata a farsi sentire.

E poi bisognerebbe riflettere su quelli che, incapaci (a loro merito) di stare nell’ossessivo discorso maggioritario, ma drasticamente privi di strumenti critici, sono caduti (a loro rischio) in alter-narrazioni tossiche. Non sorprende, d’altronde, che dopo decenni di banalizzazione della lingua, di colonizzazione dell’immaginario e di guerra alla complessità, le più sciape storie dell’orrore possano suonare credibili. Da un certo punto di vista, questi nuovi “credenti” rappresentano una catastrofe e una fatica di Sisifo per chi, oltre a non stare nella narrazione maggioritaria, deve poi anche smarcarsi da questa galassia. Ma c’è qualcosa che va osservato e, se possibile, contattato: la qualità umana di chi trova così atroce quel che va accadendo, da ipotizzare che possa esser giustificato solo da qualcosa di altrettanto atroce.
Si tratta, ora, di prender parte: accettare il dolore che viene dal percepire il nostro mondo in tutto il suo disastro e la sua follia, osservare i punti in cui ha presa su di noi e organizzarsi con altri per immaginare (e fare esistere) modi diversi di stare al mondo. È qui che oggi è possibile costruire alternative al mondo-così-com’è con una radicalità che sembrava persa e a partire da una posizione del tutto marginale: quella di chi, nonostante tutto, continua a sentire il mondo in modo diverso da quello previsto; a non considerare il prossimo come una minaccia; a trovare che l’idea stessa di “salute individuale” sia un controsenso; a sentirsi attraversato e modificato da relazioni profonde con altri e altro; a non trovare la propria pienezza nel consumo o nell’accumulo; a provare sdegno di fronte alla violenza istituzionale e sistemica. Ne consegue la necessità di uscire consapevolmente dalla trappola dell’individuo atomico, del capitale-salute, della “sopravvivenza aumentata” e della dissociazione fra quel che sentiamo e quel che pensiamo. Di uscire, come ha scritto Avery Gordon in Ghostly matters, dalle ontologie della dissociazione e dalle epistemologie della cecità – impresa in cui cambiare il mondo e cambiare se stessi sono una sola e unica cosa.
_
* Stefania Consigliere è ricercatrice all’università di Genova, dove insegna Antropologia e Antropologia dei sistemi di conoscenza, e dove coordina il Laboratorio Mondi Multipli, luogo di ricerca e di sperimentazione delle conseguenze ontologiche, epistemologiche, etiche, politiche ed esistenziali che derivano dal precetto antropologico di «prendere gli altri sul serio». Altre informazioni e articoli su: www.stefaniaconsigliere.it.
Cristina Zavaroni, antropologa culturale ed etnologa africanista, ha una lunga esperienza di ricerca presso i Bakonzo del Rwenzori in Uganda. Specializzata in antropologia cognitiva ed etnopsichiatria, lavora da diversi anni come consulente per l’Associazione Mamre Onlus di Torino. Dal 2013 fa parte del Laboratorio Mondi Multipli.

 Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)
Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)


Volevo ringraziarvi per questo meraviglioso secondo contributo qui su Giap, da inizio pandemia, trovo che il vostro “approccio olistico” e le vostre riflessioni siano tra le più stimolanti pubblicate sinora. Perfino, e soprattutto, quando il nocciolo di alcune affermazioni, come nel primo intervento, era il frutto di intuizioni. Ci sono moltissimi spunti che aiutano ad inquadrare, in un momento così difficile, le origini di questa angosciosa catastrofe dei rapporti umani. L’atomizzazione di cui parlate serve anche a confinare qualunque forma di dissenso in una sorta di delirio/ pazzia. La totale distruzione di un tessuto sociale “antagonista” ha portato all’ esplosione di due fenomeni: estemporanee e massive dimostrazioni di rabbia e gesti di individuale ribellione. Gli ultimi facilmente classificabili e stigmatizzabili in patologia medica, i primi frequentemente ridotti a fenomeni criminali. in entrambi i casi si sceglie la strada della mostrificazione/ colpevolizzazione del “dissenziente”, anche quando si tratta di torme di adolescenti che si ritrovano sulla scalinata del Pincio purtroppo, anche qui, si sono sprecate le definizioni spregiative. Questa forma di isolamento è estremamente frustrante per tutti noi che non ci siamo pacificamente rassegnati a vivere secondo i dettami di un’esistenza regolata e regolamentata dai profitti, come unica moneta di scambio. La totale incapacità della sinistra di accogliere i sentimenti più popolari, adottando una forma di snobistico distacco, è anche il risultato della dissociazione di cui parlate fra pensare ed agire. Questa incapacità di comprendere si trasforma inoltre anche in giudizio, creando così una frattura insanabile. Comprendere e giudicare si situano su poli opposti e chi si sente giudicato, e non compreso, si allontanerà sempre di più. Chiunque si rifiuti di condurre un’esistenza appiattita su valori neoliberali può trovarsi di fronte ad un bivio, se non vuole rimanere intrappolato nell’ idea di “uno”: può imparare faticosamente a pensarsi collettivamente, con uno sforzo di “solidarietà coatta”.
Molti spunti di riflessione interessanti però è molto dubbio che la colpevolizzazione dell’altro visto come untore sia un prodotto della cultura neoliberista: esiste ed è esistita in tutte le culture e in tutti i tempi, di fatto anzi in misura maggiore nelle culture più antiche e meno tecnologicamente avanzate. La situazione attuale da questo punto di vista somiglia piuttosto ad un ritorno a forme di pensiero magico-medioevali o addirittura precedenti. Probabilmente la paura genera questa ricerca del colpevole per ragioni più legate alla psicologia della persona che alla sua cultura o al contesto sociale: forse chi ha paura trova più rassicurante credere che esista un nemico da cui difendersi piuttosto che accettare l’esistenza di un rischio statistico di contagio da cui non è facile proteggersi.
Questo accettando due presupposti che invece, per noi, sono fortemente dubbi:
1) che esista una linea univoca del progresso, incarnata dalla modernità occidentale, e che, quindi, tutto quello che viene prima o accanto a essa sia privo di valore (da questo di vista, la squalificazione del Medioevo è esemplare – al punto che, ancora adesso, un fenomeno moderno come i processi alle streghe viene proiettato restrospettivamente sui presunti “secoli bui”);
2) che la “psicologia della persona” non dipenda in via diretta dall’assetto sociale.
Ma, appunto, questione di assunti di partenza.
Sono d’accordo sul fatto che non sia possibile tracciare una linea univoca di progresso, il cui apice sarebbe la nostra cultura occidentale: il progresso, ammesso che il termine abbia un senso, procede per strade parallele, a volte, ma non sempre, convergenti. Esistono però dei momenti e delle acquisizioni che segnano un prima e un dopo, non soltanto in senso temporale. La teoria dell’untore può apparire plausibile prima delle scoperte di Koch e Pasteur, diventa obsoleta dopo. Infatti io parlavo di culture più avanzate “tecnologicamente” proprio per evitare attribuzioni di valore etico. Ed è tecnologicamente precedente a Koch e Pasteur, ad esempio, anche il kuru dei Fore della Nuova Guinea sebbene la tribù si sia praticamente estinta verso il 1970, un secolo dopo Pasteur, per la malattia e per la conseguente caccia alle streghe messa in atto a scopo “protettivo”. Se oggi ritorna plausibile la caccia all’untore, identificato nei runners, vuol dire che si ripropone una idea pre-pasteuriana, seppure apparentemente modernizzata. L’untore non unge, perché è malato lui stesso o lo si presume tale, ma viene accusato per un comportamento, come se il possibile contagio fosse intenzionale. Io vedo qui soprattutto l’incapacità di accettare il concetto di rischio statistico inintenzionale che necessariamente consegue alle scoperte della microbiologia e ho forti dubbi che interpretare questo in relazione al neoliberismo colga l’essenza del dato sociale; mi sembra invece che lo allontani da comportamenti simili messi in atto in momenti storico sociali diversi.
Ciao Belleli, io l’ ho intesa così: la fine delle antiche tradizioni mediche soppiantate da un sapere scientifico più ” uniforme” non necessariamente coincide con la fine di credenze magiche o ” superstiziose” ma probabilmente coincide con la fine di un sapere diffuso e condiviso da una comunità come corpo “unico”. La violenza è insita nel fattore disgregante di un collante che tiene insieme le persone. Inoltre non credo fosse intenzione delle autrici affermare che la metafora dell’untore fosse una creazione originale del sistema neoliberale, perché ovviamente non è così. Ma, se così si può dire, l'”originalità” consiste nella violenza subdola attraverso cui questa realtà ci viene spacciata per vera. Una violenza che si è infiltrata a tutti i livelli nella nostra società e che, senza un’ adeguata consapevolezza, non si riesce a rispedire al mittente, a respingere, a rifiutare. Come se ce l’ avessero trasfusa e fosse diventata una componente ” fissa”, accettata, accettabile e come se fosse scandaloso reputarla inaccettabile. Certo la violenza dei sistemi autoritari è sempre esistita ma è il modo in cui si esprime ad essere cambiato.
Poi a Nene volevo invece dire che, in fondo, non è necessario capire tutto razionalmente, come se si trattasse di un compito. Quando ci avviciniamo ad una materia così complessa dobbiamo provare ad assorbirla anche emozionalmente, estrapolare il senso del discorso dal contesto e dalle esplicite intenzioni e non da ogni singola parola. Tutti possono e devono accedere a tutto senza sentirsi in soggezione di fronte ad una parola nuova e difficile. È sempre una fantastica occasione per imparare cose nuove.
In questo testo per esempio mi ha molto colpita l’ utilizzo della parola “veridizione” al posto di verità. È una sostituzione che ha una sua importanza fondamentale visto che ci siamo abituati ad attribuire alla scienza il potere assoluto di stabilire la verità e non quello di certificare una veridizione, cioè la relazione tra termini in un campo relativo e definito. Grazie ancora autrici, e scusate per l’ approssimazione frettolosa con cui ho rilevato questa che per me è una bellissima novità illuminante.
Salvo, però, che per come usiamo e intendiamo la parola “tecnologia”, il suo significato viene a coincidere con quello di “occidente moderno”. Altrimenti detto, intendiamo per tecnica solo ciò che è stato reso possibile dalla manipolazione industriale o semi-industriale della materia. Due fenomeni restano fuori campo: le precondizioni sociali di questa manipolazione (non c’è industria moderna senza estrattivismo, e non c’è estrattivismo senza le condizioni atroci in cui lavorano i minatori – il che, oggi, ci pone davanti alla gravità della questione ecologica e dei lavori semi-schiavistici); e l’esistenza di una miriade di tecniche non industriali, che sistematicamente dismettiamo come arretrate (ad esempio, l’uso raffinatissimo delle piante maestro nella selva amazzonica).
La narrazione squalificante dell'”evento-kuru” fra i Fore, poi, è oggi fuori corso (qui un articolo “pacato”, come si direbbe nel giornalismo: https://royalsocietypublishing.org/doi/pdf/10.1098/rstb.2008.0072): un po’ perché la complessità delle loro pratiche culturali richiede rispetto, un altro po’ perché, nel frattempo, noi stessi “occidentali tecnologici” abbiamo fatto esperienza della diffusione delle malattie da prioni – e non ne siamo usciti benissimo…
(NB per FiloAPiombo: sollevi una questione enorme in antropologia e cruciale, in questo momento, anche per noi, quella delle credenze “ancora magiche”. Forse ci torneremo in un post futuro, in cui peseremo tutte le parole con una bilancia a scansione elettronica. Per adesso basti dire che nella lettura empatica di un testo – quella che tu raccomandi, e che anche noi cerchiamo di praticare – di magia ce n’è tantissima…)
Non mi pare che le autrici leggano la colpevolizzazione dell’untore come prodotto specifico del neoliberismo. D’altra parte, non credo si possa affermare che essa esiste “in tutte le culture e in tutti i tempi, di fatto anzi in misura maggiore nelle culture più antiche e meno tecnologicamente avanzate”. Mi guarderei dall’enunciare principi universali come questo. E se poi anche se ne trovassero di validi – posto che delle “culture più antiche” sappiamo pochissimo – credo che l’interesse vero non stia tanto nell’invarianza di certi atteggiamenti attraverso le culture – cioè una supposta “natura umana”, – quanto nel modo, differente, in cui ciascun gruppo sociale declina quell’invarianza. Il fatto che in una società neoliberista si sia perseguito l’untore come in alcune società pre-moderne, dimostra piuttosto che il neoliberismo è una forma di “pensiero magico” – il che potrebbe anche essere la sua caratteristica migliore, se non fosse che i suoi sortilegi assoggettano, isolano, fanno ammalare. La pandemia ha messo in evidenza, una volta di più, quanta magia nera ci sia nel capitalismo – non a caso, per descriverne il funzionamento, Marx ha usato in lungo e in largo il concetto di “feticismo”, che in origine si riferisce ad amuleti magici. Ma come dicevo, quando si notano somiglianze diacroniche tra epoche diverse, l’aspetto più interessante consiste nel cercare, nella somiglianza, le differenza tipiche. Il modo in cui sono stati trattati gli untori in questa pandemia, in questo tempo, ha aspetti tipici dell’idea di “salute individuale” delineata da Stefania e Cristina: non tanto quindi come “pericoli pubblici”, ma come “nemici privati”. Sorprendere il runner sotto casa e additarlo, era più simile a sorprendere un ladro, o un pericolo per la proprietà, che non l’autore di un comportamento riprovevole e socialmente stigmatizzato. Contro i runner si sono usati profili Facebook “di quartiere” di solito attivati per sorvegliare il territorio ed evitare furti di auto, intrusioni domestiche, ecc.
Più sotto scrivi: “forse chi ha paura trova più rassicurante credere che esista un nemico da cui difendersi piuttosto che accettare l’esistenza di un rischio statistico di contagio da cui non è facile proteggersi.”. In realtà, il nemico da cui difendersi sarebbe anche facile da individuare: un virus. Il problema è che non si vede. Stringe alleanze segrete (contagio) con altri individui che poi si infiltrano nelle schiere degli amici, come sicari o attentatori suicidi. Potrebbe essere ovunque. Si nasconde. Fa proseliti. Uno dei lasciti della pandemia sarà infatti una sempre maggiore ingiunzione alla visibilità, al mostrarsi, all’evitare l’anonimato, a rinunciare al privato in favore del tracciamento. Questo alla lunga è il nemico che resterà, al di là delle singole categorie di untori via via additate dalle pagine dei quotidiani.
Beh, grazie di questo articolo, per me particolarmente necessario dopo aver letto in questi giorni editoriali vari sull’ultimo rapporto del Censis e sul “meglio sudditi che morti”.
Un grazie anche per quel «Ma c’è qualcosa che va osservato e, se possibile, contattato: la qualità umana di chi trova così atroce quel che va accadendo, da ipotizzare che possa esser giustificato solo da qualcosa di altrettanto atroce. » che vi viene da quella parte meno razionale e più complottista del mio essere che in quella frase si riconosce :)
Concordo in linea di massima su tutto e vorrei commentare, ma forse è troppo presto, dovrei rileggere un bel po’ di volte con calma per mettere giù qualcosa con un minimo di senso e di utilità alla discussione. Faccio quindi qualche riflessione fra quelle che mi sono venute “di cuore” alla prima lettura del pezzo con cui, ripeto, ho empatizzato molto, cercando di mantenere un filo logico e di capire “dove voglio andare a parare” prima della fine dei 2300 caratteri (niente, non ce la faccio).
La prima cosa che mi ha toccato emotivamente è quel «La configurazione antropologica del neoliberismo è penetrata talmente a fondo da rendere uno stato sanitario di polizia più desiderabile del mondo nella sua interezza e della vita nella sua complessità. » che è drammaticamente vero. Meglio sudditi che morti, appunto.
Quello su cui mi vorrei soffermare è il “perché” la posizione di chi «nonostante tutto, continua a sentire il mondo in modo diverso da quello previsto; a non considerare il prossimo come una minaccia; a trovare che l’idea stessa di “salute individuale” sia un controsenso; a sentirsi attraversato e modificato da relazioni profonde con altri e altro; a non trovare la propria pienezza nel consumo o nell’accumulo; […]» etc. sia ormai non solo minoritaria, ma anche più o meno trasversale rispetto al normale panorama politico.
E quel perché secondo me è ben spiegato dalla vostra frase «Il terrore del virus ha colpito molto al di sotto della zona cosciente delle nostre scelte e delle nostre opinioni ».
La cito perché è una cosa che condivido e che ho scritto e ripetuto senza saperla argomentare molte volte: se tu sei abituato a discutere e a ragionare e anche ad autoanalizzarti esclusivamente su un piano razionale come quell'”individuo autonomo ” di cui parlate al capitolo 4, ben difficilmente saprai gestire un cazzottone emotivo “sotto la cintura” come quello scatenato da questa pandemia e dalla sua gestione.
Sono altri i meccanismi e le reazioni che scattano.
Sono le persone che hanno fatto maggiormente “pace” con le proprie emozioni quelle che hanno meglio saputo incassare il cazzotto e paradossalmente meglio razionalizzare il tutto. E’ qui la trasversalità. Questo “requisito” di aver fatto pace con le proprie emozioni non deriva dall’appartenenza politica, ma dal proprio percorso di vita.
Il pericolo, che a sinistra chi ha entrambi i requisiti (percorso di vita e formazione politica) dovrebbe vedere (e in effetti vede, ma è in minoranza), è che chi risponde a quella posizione citata sopra se vi arriva da percorsi e contesti di scarsa cultura politica venga cooptato dalla destra o disperso in fantasie di complotto oppure atomizzato nella solitudine di chi si vergogna persino di avere idee “diverse” da quelle socialmente accettate (posizione “del tutto marginale” quindi solitaria e senza altri con cui farsi forza).
Un’ultima chiosa: «Molti oggi stanno pensando di andarsene dalle città e, fra i più giovani, la terra comincia a chiamare » : vero. Dal mio osservatorio limitato l’ho notato anch’io.
Per me a livello di “sensazione” è un gran bene. La riflessione razionale su questo però la intravedo, so che c’è, ma è al di là delle mie capacità esternarla e darle un senso compiuto.
So che ci sono moltissime criticità su questo “ritorno alla terra”: la terra è un bene limitato (il vero bene “infungibile”) e nel mondo siamo tanti. Ma la sensazione è che comunità ed ecovillaggi, per quanto utopistiche e piene di problemi teorici, siano un buon primo passo per cominciare a “provare” un nuovo sistema di vita e a correggerlo strada facendo.
Stefania & Cristina definiscono “marginale” la posizione di chi “nonostante tutto, continua a sentire il mondo in modo diverso da quello previsto.”. Tu, citando la frase, la definisci “minoritaria”. Non voglio inchiodarti a una parola, ma c’è una bella differenza ed è importante sottolinearla. “Minoritaria” è un termine quantitativo: dice che quelle persone non rappresentano la maggioranza. Sono meno del 50% – e spesso, in realtà, “minoritario” si dice di uno schieramento che è molto al di sotto del 50%. “Marginale” invece indica una collocazione: lo è chi si trova lontano dal centro, escluso – a prescindere dal numero. In una società capitalista, i marginali sono legione… Ebbene, sottolineo questo aspetto perché confondere le due cose è esiziale: chi si trova in una posizione “marginale”, ritenendo per questo di essere “minoranza”, penserà che le sue posizioni non potranno mai ottenere risultati concreti, e quindi le edulcora, vi rinuncia, le considera “impossibili”, pur di entrare invece a far parte di una “maggioranza” che gli permettera di ottenere, di conquistare, di praticare il possibile. Per dire, in altro contesto: uno pensa che l’ideologia del decoro sia una schifezza, ma intorno vede fiorire comitati di quartiere contro il degrado, a tutto spiano. Allora si convince che non c’è niente da fare, che tutto sommato c’è anche un degrado che va combattuto, che in fondo le ronde possono anche essere una buona cosa, che se vuoi agire sul territorio non puoi sottrarti a una certa retorica. Ed ecco che si lascia catturare dall’ideologia che gli faceva schifo, per non condannarsi ad essere minoranza e a non essere “efficace”.
Hai ragione. Da parte mia non c’era nessun giudizio di merito (cosciente?) nel definire “minoritaria” una posizione che condivido, né il tentativo più o meno consapevole di delegittimarla, sminuirla o chiamarsene fuori.
Ho usato i 2 termini come sinonimi, prigioniero di un modo di vedere le cose “di sistema”, dall’interno.
Invece è proprio come dici tu: marginale è una cosa, minoritaria un’altra. Non necessariamente e non sempre sono sovrapponibili.
E in effetti se tutti i “marginali” si mettono insieme sono molti di più di quelli “posizionati al centro” («In una società capitalista, i marginali sono legione »), specie se mettendosi insieme guardano più a ciò che li unisce che a ciò che li divide.
Mi mancano ancora dei caratteri, quindi dico anche la mia sulla “discontinuità” di cui parlano SteCon e StefanoR.
Concordo in parte con StefanoR che negli ultimi 40 anni (facciamo 60?) nel mondo occidentale ci sia stata una discontinuità abbastanza netta. Che certo non è paragonabile «con la “fine del mondo” subita dalle popolazioni colonizzate », ma che per alcune parti del mondo occidentale (alcuni “mondi”?) è stata comunque significativa, tanto da creare sconcerto in quelli abbastanza vecchi per aver vissuto tutti i cambiamenti.
Penso ad esempio alla civiltà rurale, al “mondo dei vinti” di Revelli (in senso lato). In 60 anni si è passati dalla fame, all’industrializzazione con lo spopolamento delle campagne e la “migrazione” in città, alla fine di moltissimi riti e consuetudini, alla fine di un certo tipo di famiglia dove più generazioni condividevano lo stesso tetto (con il brutto e il bello che portava con sé), di stili di vita, etc.
Marginale vs. maggioritario: non possiamo che ringraziarvi di questo scambio, ci aiuta a fare una distinzione che non avevamo chiara e che, di qui in avaanti, sarà data per acquisita anche da noi. Mike Singleton, “grande vecchio” dell’antropologia e una fra le menti critiche più lucide e ironiche, è solito dire che, nella storia dell’umanità, le novità più dirompenti arrivano sempre da coloro che stanno ai margini della struttura, alla periferia dell’impero – da quelli, cioè, che non sono troppo impegnati nella tronfia (e spesso violenta) prosecuzione dell’esistente.
ringrazio anch’io le autrici e Giap per questo articolo ricchissimo di spunti su cui riflettere.
Cedo alla tentazione di intervenire perché il tema della marginalità mi risuona troppo da vicino. Infatti sono sempre stata attratta dalle situazioni marginali, dalle visioni decentrate, dalle soglie, dai confini, ne intuivo le potenzialità e ora mi avete spiegato il perché!
Se mi è permessa un’autocitazione (in caso contrario cassate pure il commento, non mi offendo) alcuni anni fa mi imbattei in una storia “marginale” di una tale forza che decisi di farne un fumetto. La storia è quella di Calum McLeod (https://en.wikipedia.org/wiki/Calum_MacLeod_(of_Raasay ) , l’ultimo abitante di un villaggio su una remota isola scozzese, che nei tardi anni ‘60 – da solo, a spopolamento avvenuto – decide di costruire con piccone e carriola la strada che per un secolo e mezzo tutti i governi centrali e regionali avevano negato alla sua comunità, in quanto troppo … marginale. Il suo gesto in effetti cambierà la storia dell’isola, anche se solo dopo la morte del protagonista. La storia di Calum e della sua isola è ricostruita molto bene in questo libro: https://birlinn.co.uk/product/calums-road/ e mi aveva colpito proprio per la capacità del protagonista di ribaltare la visione dominante grazie alla sua collocazione marginale e all’ancoraggio alla sua comunità, ormai esistente solo nella sua memoria ma ugualmente forte.
Nel trasformarla in un fumetto, l’ho collegata ad altre due storie (vere) di resistenza dai margini, una collocata in un villaggio del Marocco e l’altra in Calabria. Il legame che le accomuna è appunto la capacità di sottrarsi alla visione dominante e il senso della comunità, dunque il rifiuto dell’atomizzazione. Non a caso il titolo è Cronache dalle periferie dell’impero – e, non so, mi sembra utile che le storie di piccole resistenze di successo siano diffuse e conosciute per aiutarci a guardare oltre TINA. Il libro è questo: http://www.ilgirovago.com/selva-cronache-impero/
Grazie del secondo articolo. Ultimamente soffro di una “grave patologia”: ogni cosa che leggo mi sembra che trovi la sua migliore spiegazione in uno degli ultimi libri che ho letto, “Cose” di Felice Cimatti. Letto a giugno, sono ora alla seconda rilettura, perché per me è un libro tanti interessante, quanto difficile. Tratta dell’uomo e del mondo, di relazioni di campo e di ontologia; di soggetti e oggetti. Può aiutare a conoscere dove trova alimento e forza questo produrre discrasia sistemica, individui e non dividui ecc ecc. Io non so dibattere e mi piacerebbe usare quello che sto imparando leggendo quel libro per aiutare tutti noi a trovare una via concreta per rafforzare “le ontologie della relazione e le epistemologie della visione”.
«Quanti raffinati decostruttivisti, quanti infervorati foucaultiani, quanti sublimi analisti delle “condizioni sociali” abbiamo visto, in questi mesi, ritirarsi spaventati sotto le gonne dello scientismo più becero all’insegna del “lasciamo che decidano gli esperti””, come se le epistemologie e le critiche sociali su cui hanno costruito le loro carriere fossero, in fondo, solo passatempi per gli anni di vacche grasse.»
Esatto. Io ne traggo la conclusione che tutto quel pensiero critico sia stato a lungo in cattive, pessime mani, quindi reso innocuo e inerte, ridotto a pose e giochini verbali. Se ci attende un compito, al quale voi già vi dedicate nello splendido pezzo qui sopra, è quello di recuperare quegli attrezzi da dove gli ex-hobbisti, in preda al panico, li hanno gettati a febbraio-marzo, e tornare a chiederci come usarli nel contesto di quanto sta accadendo, contro ogni virocentrismo.
C’è un punto importante del discorso che forse bisognerebbe approfondire.
Il concetto moderno di “salute” è sì un prodotto della trasformazione della società europea in chiave capitalistica, ma forse la sua origine non andrebbe rintracciata proprio nella reazione agli effetti distruttivi del capitalismo sugli esseri umani e sul loro ambiente naturale?
Certo, quel concetto è stato poi inglobato abbastanza rapidamente nei dispositivi di gestione della società capitalistica, alla pari di altri elementi che hanno un’origine analoga (penso al diritto all’istruzione, utilizzato anche come forma di disciplinamento di massa). Ma leggerlo solo come parte costitutiva della rottura con le formazioni sociali preesistenti, e non, anche, come parte della *reazione* della società a quella rottura rischia di produrre dei fraintendimenti molto scivolosi, che lasciano spazio (anche se involontariamente) all’idea della scienza, e di qualsiasi dispositivo basato su di essa, come invariabilmente “nemici” della gente comune.
Un altro punto critico, secondo me, è la tendenza a leggere il neoliberismo (e le tendenze storiche che lo hanno alimentato) in continuità con lo sviluppo precedente della società capitalistica.
Quello che è successo a partire dalla fine degli anni ‘70 secondo me ha rappresentato una rottura, e non da poco, con l’ordine sociale post-dopoguerra.
Nell’arco dei 40 anni che ci separano dall’inizio di quel processo si è vista una trasformazione della società che forse è paragonabile a quella causata dalla rivoluzione industriale. Il neoliberismo è stato il primo “sistema di governo” di questo nuovo assetto della società in fase di costruzione, ed è abbastanza improbabile che sarà l’ultimo.
La trasformazione ha rivoluzionato completamente il nostro ambiente materiale, cognitivo ed emotivo, e il processo è ben lontano dall’essere compiuto. Per cui la “vita” a cui stiamo rinunciando (forzatamente o volontariamente) o a cui non vogliamo rinunciare (inconsciamente o consapevolmente) è già, in parte, frutto di quella ridefinizione. Volenti o nolenti, la crisi del Covid ci impone un ripensamento drastico anche su questi aspetti.
Preciso un attimo meglio il primo punto. Lo sviluppo della conoscenza scientifica e delle sue possibilità di applicazione pratica richiede inevitabilmente la specializzazione. Peggio ancora: le conseguenze concrete di questa proliferazione di conoscenza sollevano poi a loro volta una tale quantità di problemi e rischi (e quindi una quantità enorme di ulteriori conoscenze e applicazioni) che è quasi inevitabile che molte sfumature di questo processo sfuggano all’attenzione pubblica… e questo sia in un sistema basato sul profitto, sia in un sistema costruito su basi differenti che non voglia rinunciare al contributo di quella conoscenza per migliorare l’esistenza degli esseri umani.
Gli “esperti” che adesso dominano il palcoscenico (soprattutto in Italia, a quanto pare in altri paesi la situazione è un po’ diversa) mi sembra che però siano un’altra cosa. Che si parli di vedette mediatiche o di consulenti governativi, sono meno il prodotto del normale sviluppo delle conoscenze nelle rispettive comunità di riferimento (quello sviluppo è sempre un’impresa collettiva, in fondo), e più o il sottoprodotto di un “libero mercato delle idee” pompato da un’infosfera fuori controllo, oppure il necessario complemento di un potere pubblico ridotto a precaria governance dell’esistente. In entrambi i casi, il frutto del fallimento della “tecnostruttura”, più che del suo trionfo…
Grazie del secondo post di chiarimento.
Sul disastro neoliberista, se sia o meno in continuità con quello capitalista, si è discusso moltissimo – a partire dalla definizione stessa dell’epoca (postmodernità, ipermodernità, modernità liquida, turbocapitalismo ecc.). Per me è rilevante (1) il fatto che, qualunque sia il prefisso o il suffisso, il nome di fondo resta il medesimo, e (2) a confronto con la “fine del mondo” subita dalle popolazioni colonizzate, quel che sta capitando a noi non pare così estremo; e tendo quindi a privilegiare la continuità. Capisco bene, però, le ragioni di chi vede negli ultimi quarant’anni una discontinuità inquietante.
Sulla moderna idea di salute, invece, concordo sul fatto che scienza e tecnica, e tutto quel che ne deriva, fanno intrinsecamente parte della “costituzione del mondo moderno”, e quindi concorrono tanto al dominio quanto alle possibilità di risposta (per mia parte, considero la scienza un campo cruciale, vasto e appassionante, nel quale – come sanno coloro che la praticano, anche se spesso fanno finta di niente – è necessario prender parte). Ed è possibile che, in certi momenti, anche il concetto di salute come “bene individuale” sia servito alle lotte per la ridistribuzione delle risorse e per il benessere. In generale, però, è un’idea troppo angusta, uno strumento spuntato da cambiare appena se ne presenta l’occasione. (Aggiungo un pezzo, che forse non c’entra molto con il tuo ragionamento. Ci sono momenti in cui, per farsi capire senza perder troppo tempo a spiegare, bisogna usare il vocabolario della controparte. Ma non è bene indugiare troppo in quell’orizzonte, perché si rischia di farci l’abitudine.)
Ma la discontinuità infatti c’è stata anche (e forse soprattutto) per i popoli post-coloniali… quando poi parlo di discontinuità penso non solo all’erosione degli standard di vita, ma proprio al cambiamento profondo delle condizioni sociali complessive, che anche in quello che chiamiamo “occidente” si è visto eccome. Anche se non siamo sprofondati improvvisamente nel caos e nella miseria più nera, la società è cambiata radicalmente e siamo profondamente cambiati anche noi.
Che poi nel modo in cui viene chiamata quest’era ci sia ancora il termine “modernità” secondo me è sintomo proprio della difficoltà a pensare fino in fondo la discontinuità… non prenderei questa circostanza come argomento a favore della continuità.
In generale, penso sia difficile cogliere le discontinuità nel momento in cui si producono, soprattutto quando gli strumenti analitici sulla base dei quali si analizza la realtà sono il prodotto di un’epoca precedente, rispetto alla quale magari quegli stessi strumenti hanno dato prova di una certa efficacia e affidabilità.
Per quanto riguarda la salute come “bene individuale”. Forse questo è un po’ un azzardo, ma penso che anche questa idea sia un prodotto della trasformazione che stiamo attraversando, più che il semplice retaggio dell’assetto sociale precedente. In quella fase storica, dominata dalle vaccinazioni di massa, dalla creazione dei Sistemi Sanitari Nazionali, dalla fondazione di un’organizzazione come l’OMS in seno all’ONU ecc. mi sembra che prevalesse invece un concetto di “salute pubblica” mediato dall’intervento statale o addirittura sovranazionale, mentre la concezione transazionale della salute (che lega individuo, sistema sanitario e sistema economico in una configurazione completamente differente) sia più un prodotto degli ultimi decenni… ma su questo ammetto di non avere abbastanza conoscenze.
Sulla maggiore o minore discontinuità degli ultimi 40 anni rispetto all’epoca precedente, non insisto: è questione di sensibilità personale e ci sono ottime ragioni su entrambi i versanti.
Sull’idea di salute dell’epoca immediatamente precedente alla nostra, invece, una nota: l’enfasi sulla salute pubblica dell’OMS degli Stati, negli anni Sessanta e Settanta, veniva anche (e forse soprattutto) dalle lotte operaie e sindacali sul reddito e sull’accesso alle risorse per una “vita degna”, nonché dal loro braccio di ferro con gli Stati, che miravano alla statalizzazione delle vecchie “mutue assistenze” in un’ottica di gestione centrale di tutte le risorse. Lasciato a se stesso, il capitalismo di allora, come quello di adesso, se ne sarebbe infischiato della salute dei più – e se oggi ci troviamo con il concetto di salute più meschino di sempre, è anche perché le lotte collettive (e le riflessioni collettive su com’è fatto un mondo vivibile) hanno perso forza.
Su questo non c’è dubbio! Certo, va poi anche detto che le lotte hanno giocato di concerto con tanti altri fattori “contestuali” che hanno reso possibile ottenere quei risultati, dando forza alle rivendicazioni e consentendo il loro inglobamento in un processo di governance complessiva della società che andava comunque in quella direzione. Dire che il capitalismo di allora, lasciato a se stesso, se ne sarebbe infischiato della salute dei più è un’affermazione controfattuale che secondo me non tiene conto del contesto di allora: era precisamente nell’interesse delle formazioni capitalistiche del tempo cedere un po’ di terreno all’approccio dirigista del potere pubblico. Terreno che si sono riprese (con gli interessi) non appena il contesto è cambiato.
Il punto centrale, invece, è proprio la riflessione collettiva su cosa intendiamo per “mondo vivibile” e “vita degna”. E’ lì che si arena la discussione. La polarizzazione sull’interpretazione dei dati e delle misure politiche e sanitarie, purtroppo, non agevola granché quella riflessione e ci tiene vincolati ad un frame che è e rimane strettamente virocentrico.
Voi nell’articolo la mettete in termini di “antropologia” (quando parlate del modo in cui la situazione incide sulle inclinazioni dei singoli ad interpretare le cose in un modo piuttosto che in un altro, intendo). Io tendo più a vederlo come un punto etico: a cosa siamo disposti a rinunciare (perché anche mettere in discussione il frame neoliberale implica delle rinunce) e, soprattutto, in vista di che cosa.
Raga, vi voglio un casino di bene. Per capire gli scritti che pubblicate però io regolarmente ho bisogno del dizionario nonché di fare alcune ricerche online perché mi mancano dei pezzi di storia e non solo. Mi chiedo: quanto è importante che un linguaggio sia inclusivo? Quanto è importante che la parola inclusivo rimandi alla possibilità per tante persone di capire di cosa si parla? Che potere trasformativo ha uno scritto che può essere compreso da poche persone? Le persone che hanno studiato hanno idea di che dispendio di energia sia la “traduzione” di un testo di contenuto e linguaggio accademico? Quanto è importante per le persone che ambiscono al cambiamento della società porsi come obiettivo l’uso di un linguaggio inclusivo? È reale questo obiettivo, è sentito come necessario? In che misura una persona che ha un percorso accademico può condividere le consapevolezze che ha acquisito con chi non ha mai studiato? Che cosa significa quindi condividere un “capitale”? Non può essere solo condividere gli spiccioli, sono convinta che sia altro. Un qualche tipo di capitale “relazionale” ce l’abbiamo proprio tuttx. Con mal di testa e affetto, Nene
Nene, anche a me capita di leggere roba che non capisco al primo colpo, eppure ho studiato un sacco – inutilmente, a quanto pare! Quando però mi imbatto in un testo che mi spinge a guardare il dizionario e a fare ricerche ulteriori, sono proprio contento. E poi: perché a un poeta non chiederemmo mai di usare un linguaggio più semplice, dando per scontato che se usa quelle parole è perché sono quelle che gli servono per creare una certa immagine, mentre di un testo saggistico pensiamo che sarebbe sempre traducibile in un linguaggio più semplice? Io mi sono formato sulla filosofia anglosassone, che spesso è di un nitore esemplare, eppure non pretendo che Heidegger scriva nello stesso modo.
Detto questo, capisco la tua critica e la recepisco, noi ci sforziamo di essere inclusivi e l’obiettivo di includere ce lo diamo sempre. E’ importante che un linguaggio sia comprensibile anche da chi non è un esperto del settore. Ma è anche importante che sia preciso. Se un epidemiologo ti parla di mortalità e letalità, tu vai a studiarti quei concetti, non pretendi che usi un sinonimo, perché sono concetti che vogliono dire quella roba lì. Ebbene, a molti sembra strano, ma questo succede anche in altri campi del sapere, come l’antropologia, e non solo nella fisica delle particelle.
Ciao Nene, se – come immagino dal fatto che hai scritto sotto il nostro post – il mal di testa te l’abbiamo causato noi, mi dispiace davvero molto. In parte, come ha scritto Wu Ming 2, me lo spiego con l’effetto “scostante” del vocabolario specialistico. Per un’altra parte, invece, mi chiedo come fare per rendere meno indigesti questi argomenti, soprattutto quando vengono mediati da una scrittura che dev’essere il meno ambigua possibile (lo scan critico che viene fatto su Giap è tanto temibile di quello delle riviste specializzate…). A voce è tutto più facile. E siccome, nonostante tutto, sei arrivata fino in fondo, restiamo così: che ti siamo debitrici di un’aspirina, di un caffè, e di una chiacchierata.
Salve, intanto grazie per questi articoli che cercano di rispondere alla tragedia che stiamo vivendo (e non mi riferisco alla “pandemia”). Ma quello che mi chiedo è: serve a qualcosa cercare una spiegazione a quello che sta succedendo? A chi serve? Io condivido pienamente la vostra visione (anche se sinceramente molti passaggi sul come ci siamo arrivati mi sono oscuri, devo studiare di più), ma chi pensa che dobbiamo difenderci dal virus ad ogni costo, chi pensa che i nipoti uccidono i nonni, cosa gliene frega? Loro hanno già capito… Non hanno domande… Non cercano risposte… Sono pronti a sacrificare tutto pur di essere lasciati tranquilli ma quello che non capiscono, secondo me, è che non finirà mai se non si svegliano.
Vi faccio un esempio. Io vivo in Francia seguo alcuni medici qui che dicono che non serve il confinamento, le maschere grande pubblico non servono, bisogna curare le persone non lasciarle sole… Beh per farla breve ho girato a degli amici un grafico della “seconda ondata” a Marsiglia in cui la curva dei contagi aumenta al momento dell’imposizione delle maschere, della chiusura dei ristoranti e comincia a diminuire ancora prima del confinamento. Per me era stata una folgorazione, cavolo tutti i nostri sforzi non servono a nulla, tanto vale vivere normalmente no?!
Uno mi ha risposto così:
“Primo: i francesi me sta sui cojoni
Secondo: ti voglio molto bene
Terzo: se neghi la mortalità del virus si vede che non hai avuto amici / parenti / conoscenti SANISSIMI in ospedale intubati
4: mejo che stago sito”
Non c’è dialogo… Per queste persone (e sono tantissime) la crisi sanitaria è un evento isolato non è un percorso. La cosa più assurda è che non c’è destra o sinistra, povero o ricco, giovane o vecchio. Non si ragiona più… Forse sono solo un pazzo ma credo che bisogna trovare un modo per far rimettere in moto il cervello e collegarlo al cuore. La cosa che mi fa più paura è quello che vivono i nostri bambini (io ne ho due di 8 e 10 anni), imbavagliati anche se poco contagiosi, responsabili della morte dei loro nonni, come cresceranno??
E anche questi nonni, prima li proteggiamo sacrificando tutto e poi li usiamo per testare un vaccino di cui non sappiamo nulla, non eviterà i contagi, staremo comunque lontani e gli effetti secondari saranno cazzi nostri??
Emanbet, interpreto: c’è una parte disperata del tuo post (la prima: “a cosa serve cercare una spiegazione?”) e una parte resistente (l’ultima: “rimettere in moto il cervello”).
De Martino diceva che, anche di fronte all’apocalisse culturale, alla “fine del mondo” (del proprio mondo, beninteso), ci sono sempre almeno due possibilità: abbandonarsi allo scoraggiamento, oppure provare a costruirne un altro. E se poi davvero il mondo ha da finire, allora è più decoroso farsi sorprendere dalla catastrofe mentre si sta resistendo alla sua avanzata.
L’articolo e’ interessante e ricco di spunti. Pero’ trovo che Nene abbia sollevato un problema importante sul “parlare difficile” che non puo’ essere liquidato con la difesa che questo approccio retorico serva ad argomentare con maggiore precisione. Cosi’ naturalizziamo un modo di scrivere che storicamente ha danneggiato non poco il rapporto tra le scienze umane/sociali e il mondo esterno. E’ un problema non tanto di efficienza retorica, quanto etico e politico. E lo e’ nella misura in cui questo stile funziona (di fatto, anche se non nelle intenzioni) come il “latinorum” di Don Abbondio: ossia, esclude persone potenzialmente interessate dal capire chiaramente cio’ di cui si sta parlando.
Come dice WM2, molti filosofi anglosassoni scrivono con un “nitore esemplare”. Vero; e mi pare che tu ammetta che sia una cosa buona. Ma allora perche’ non pretendere lo stesso da Heidegger ecc.? Siamo sicuri che lo stile “continentale” ne guadagni in _precisione_ rispetto al nitore di (molta) filosofia analitica? Secondo me ne guadagna piuttosto in “aura”: e’ uno stile che dice “sono un/a intellettuale, pensaci dieci volte se vuoi esprimere disaccordo”. Rimando a Martha Nussbaum: https://www.openculture.com/2013/07/jean_searle_on_foucault_and_the_obscurantism_in_french_philosophy.html
Questo pezzo e’ molto piu’ chiaro di tanti altri, pero’ secondo me non sarebbe difficile scrivere piu’ limpidamente senza perdere precisione. Cosi’ come – presumo – impiegate qualche momento in piu’ per spiegare i termini tecnici ai vostri studenti, si potrebbe fare lo stesso qui con termini come “veridizione” (che, per inciso, e’ un termine che implica tutta un’epistemologia “naturalizzata”).
Quanto a “rendere meno indigesti questi argomenti”, permettetemi una proposta: andrebbe coltivato nella propria scrittura, specialmente quando ci si rivolge a non specialisti, un senso di straniamento analogo a quello dell’ “apprensione critica dell’acqua in cui si nuota”, che produca un distacco dai tic retorici prodotti dall’economia di prestigio dell’universita’ italiana. Si impara a scrivere cosi’ da studenti, dottorande, ricercatori ecc. perche’, scusate la brutalita’, paga. Ma se davvero si vuole essere “critici” trovo che sia necessario uno sforzo extra di chiarezza e inclusivita’.
Molto dipende dagli obiettivi che un testo si propone. E mi piace pensare che possano essere molteplici, anche in un campo che chiamiamo col nome univoco di scienza. Voglio dire: il manuale di istruzioni di un attrezzo deve farti capire come utilizzare quell’attrezzo. Ma un saggio di antropologia cosa deve fare? Non vorrei che il suo scopo dovesse essere, per forza, comunicare una tesi. Ci sono pagine di Deleuze & Guattari che per me si leggono come prosa poetica. Non importa capire cosa vogliono dire, nei termini di x, y e z, importano i pensieri che ti mettono in testa. Ma anche Wittgenstein – per quanto nume tutelare di tanta filosofia analitica – nel Tractatus logico-philosphicus si esprime in maniera che molto a fatica si potrebbe definire logica o limpida. Certe preposizioni sono più evocative che denotative. Quindi è giusto dire che la lingua di un saggio non dev’essere per forza accademica, che esistono tic e un certo marketing dei concetti. Ma non vedo perché accettare come scelta stilistica la prosa di un romanzo, e imporre invece un certo stile alla prosa di un saggio. In fondo, molte innovazioni nascono proprio dall’usare gli attrezzi in maniera non convenzionale, disattendendo il manuale d’istruzioni – o leggendolo come se fosse una poesia.
Premetto, questo post è un testo importante, da leggere e rileggere, da cui partire e a cui tornare. Vero è che la sua lettura costa fatica. La questione dell’inclusività del linguaggio, della massima accessibilità a una prospettiva complessa rappresentano un tema a sé che merita la giusta attenzione. Così mi sono messo a scrivere un commento (che non è questo), ma poi mi sono reso conto che il testo non stava né in uno né in due commenti qui su Giap. E allora, siccome ci tengo alla questione e a poter in qualche maniera contribuire alla discussione, ho per l’occasione riesumato il mio blog personale, aggiustando quel poco il testo che doveva essere un commento per un farne un post. In sintesi parto da questo che segue e cerco di approfondire un po’:
«Io tendo a pensare che il problema non sia la complessità del linguaggio, nemmeno l’uso di un linguaggio specialistico; credo che sia proprio la complessità del discorso, anche una certa “contro-intuibilità” (per le ragioni stesse, “sistemiche”, presentate nell’articolo) dell’analisi lo scoglio. Non è facile evitare questi problemi per chi scrive un articolo così, tanto più se di un post si tratta (quindi con un numero ridotto di battute a disposizione e con una sua peculiare forma); quel che “sento” è che sia una difficoltà di cui farsi carico collettivamente, anche se non immagino ora in che modo pratico farlo. E allo stesso modo (e tempo) si dovrebbe immaginare come elaborare e ri-elaborare collettivamente punti di vista complessi come questo presentato da Consigliere e Zavaroni.»
(Il resto si trova qui; perdonate il link, ma tagliare oltre un tot mi sembrava togliere tutto il senso).
Riporto qui una parte del post di mr mill, che apparentemente non c’entra con la questione del linguaggio, ma che pone un ulteriore, importante problema:
«Dopo la lettura della pars costruens del pezzo, diciamo la seconda parte del post, mi è rimasta appiccicata la sensazione che sia, così posta, un riflesso di ottimismo della volontà (e non dico sia poco oppure sbagliato), come se dopo la grossa analisi critica che precede quella parte mi aspettassi (e non solo come desiderata, ma per la qualità della prima parte) una prospettiva di contrattacco più solida.»
Ho l’impressione che l’evento-covid sia particolarmente crudele per questo motivo: da un lato, la gestione della pandemia da parte degli Stati, e dell’Italia in particolare, ci mostra quanto il diventare-individui sia già una malattia, un elemento del disastro; dall’altro, però, proprio quella gestione e quell’evento rendono difficile la nascita e la tenuta dei con-dividui, proibendo lo stare insieme, relegando le persone in casa, indicando nella distanza una misura di sicurezza, assegnando un ruolo chiave al tracciamento e all’individuazione. Questo rende particolarmente difficile l’elaborazione di una pars costruens che non si riduca a un semplice attendismo, o a una riduzione del danno, ma sviluppi una prospettiva di contrattacco. Banalmente: come creiamo parentele mentre ci raccomandano a reti unificate di frequentare solo congiunti, di rinunciare anche soltanto a una riunione di famiglia allargata, di ritirarci in casa nelle ore non lavorative, di rispettare confini ristrettissimi, di proteggerci anche all’aperto dall’aria che respirano gli altri? Come possiamo riannodare una matassa di corrispondenze, quando proprio la gestione della pandemia ci ha fatto smarrire amicizie, collaborazioni pluriennali, luoghi di ritrovo, attività comuni?
Parlarne qui, parlarne in modo comprensibile, interrogarsi sulle parole ha un senso che non va sminuito. Eppure è innegabile il bisogno di una pars costruens più articolata. Sempre che questa nostra ricerca di un disegno, di una mappa, di una rotta da tracciare, non sia figlia anche quella dei dualismi che vorremmo combattere. Non abbiamo tanto bisogno di una “parte da costruire”, quanto piuttosto – come dicono le autrici – di una parte da prendere, da coltivare.
Buongiorno Cioban Bey e Nene, dal canto mio accolgo la segnalazione. Ho molto nitide nella memoria alcune circostanze in cui, leggendo un saggio, non ho capito un tubo e ho sospettato che questo risultato fosse un obiettivo specifico dell’autore che, volendo, si sarebbe potuto esprimere altrettanto bene facendosi capire (non credo che abbiamo fatto questo effetto ma sempre meglio tenersi a bada). Qui parlo al singolare perché la formazione e la posizione professionale di Stefania e mie sono molto diverse, così come i nostri personali rapporti con il dispositivo della letto-scrittura. (Sospetto che le capiti più raramente di non capire un’acca quando legge mentre io sono – tecnicamente – dislessica). E’ vero che di fronte a studenti e formandi mi adopero per farmi capire e di volta in volta mi fermo a chiarire il vocabolario che lo specifico gruppo o il singolo umano non coglie non avendolo già in comune con me. Del resto, anche in questo hai ragione: nel mio caso, consulente e all’uso formatrice, “paga” il fatto che io mi faccia capire. Scrivendo qui, In assenza del confronto in vivo che permette di intonarsi a un’aula, lo scambio ricco di commenti in calce ai post mi pare possa servire per sciogliere i nodi collettivi e personali. Grazie per la funzione di specchio.
questo tema è da sempre presente nella nostra cultura occidentale, pensa solo le polemiche di Platone contro i sofisti, o per fare un esempio più recente, trovi trattato questo tema e il confronto con lo stile degli inglesi nella seconda prefazione di Kant alla Critica della ragion pura. Pensa per dire ancora più di recente, ieri, come Rovelli abbia completamento frainteso Heidegger, e Rovelli sarà forse un po’ arrogante ma non è un cretino. Strano è che non si chieda mai ad un informatico, o ad un ingegnere nucleare di spiegare il suo linguaggio, in genere con questo tipo di discipline si accetta passivamente di non capire.
Grazie a voi autrici per il succoso e gustoso articolo. Sono un appassionato lettore di Illich, e segnalo una sua intervista datata 1999, questa: http://www.altraofficina.it/ivanillich/Articoli/saluteperfetta.htm in cui l’autore torna su Nemesi medica a venticinque anni di distanza ridiscutendo le premesse di una mutata idea di “salute”. Come dite anche voi, ciò che è più pericoloso della nuova “salute” del XXI secolo è il fatto che sia una salute scorporata, e il medico – quando mi parla della mia salute – non parla più a me e di me, ma di un optimum statistico-cibernetico in cui io non esisto più. Forse l’impresa medica contemporanea, dopo aver contribuito a delineare i contorni del moderno sé indivisibile (quel sé storico costituitosi dalla triangolazione colonialismo-capitale-scienza, ecc.), lo dissolve ormai in un intersecarsi di statistiche, numeri, curve e probabilità: ovvero, a costringerlo a rientrare in un “sistema” omnipervasivo in cui un soggetto umano integro non può essere dato. Quando voglio diventare madre e mi scarico l’app per conoscere le mie ovulazioni e i miei giorni fertili, il mio corpo sentito-vissuto-percepito non esiste più, ma demando all’algoritmo di turno (ovvero numeri, profilazioni, raccolta sistematica dei dati) il compito di elaborare un calcolo probabilistico il più possibile preciso che potrebbe, dovrebbe, riguardare anche me e il mio ciclo. L’app funziona tanto più se io – ma esiste ancora l’io? – sono facente parte del sistema-salute cibernetico contemporaneo. In effetti, la metafora vitale della contemporaneità è il sistema: la rete è il paradigma di conoscenza contemporaneo. Il mondo non è più la grande Madre, ma è l’ecosistema. Forse il coronavirus ha esasperato fino al parossismo l’ideale di società come sistema-salute scorporato, in cui io conosco l’altro soltanto in quanto facente parte di un calcolo probabilistico (se la curva di contagio è alta non mi posso avvicinare a te, e sono d’accordo che l’agente di polizia ti impedisca di avvicinarti a me) e in cui la massima disfunzionalità è la morte dell’utente. Morte dunque non solo come infrazione di un tabù (non si deve morire!), ma come disfunzionalità dell’utente all’interno del sistema-salute (non si può più morire, perché la tua morte minaccia il sistema!).
Per quanto mi riguarda, che studio da più di 40 anni, l’articolo è di grandissimo valore, e anzi invidio la capacità delle autrici di riuscire a rendere così leggibile e scorrevole un testo che riguarda temi spinosi e molto difficili. Più di così era impossibile, e ciò nonostante io l’ho letto più volte, proprio per avere quell’unità di comprensione globale che va oltre i possibili scogli delle singole parti. Su questo spero di non annoiare se mi dilungo: noi sappiamo che una proposizione è composta di parole, di termini: bene, il senso della proposizione non coincide con la mera somma dei significati dei termini, ma ha qualcosa in più, o comunque di differente. E’ il senso proposizionale, cioè il concetto espresso, che non corrisponde alle parole, anche se di esse si serve. Ora se anziché una proposizione pensiamo ad un intero discorso, lo stesso vale per le varie parti: il totale del discorso trascende la somma semantica delle parti. In tal senso io mi dichiaro d’accordo sul senso totale, ed anche sulla parte finale in cui non tanto si illustra, ma appena si indica una via per poter uscire dalla situazione in cui siamo. Fuori da questa considerazione, che è la più importante, ho invece molti dubbi sull’impostazione concettuale, sul fondamento storicistico di tutto l’edificio. Ma può forse essere tale considerazione fuori dal focus di questa discussione, allora la trascrivo sotto, sperando che per alcuni possa essere di interesse e sperando di non intasare questo spazio.
Il punto da discutere è questo: “gli umani sono storici fin dall’inizio e fin nel profondo, vivono e muoiono delle verità messe a disposizione dal loro mondo e a esso, in larga parte e inconsapevolmente, si conformano. Se non lo facessero, non potrebbero abitarlo. Anche ciò che sembra più intimo e intangibile – la soggettività, il fatto di percepirsi come persone fatte così-e-così – è storica: dipende dagli assetti ontologici, culturali, economici, simbolici di un mondo umano; dalla distribuzione del potere che vi si pratica; dal tipo di rapporti ammessi e non ammessi. Solo conoscendo almeno un po’ questi presupposti si può prender parte e provare a modificare l’assetto: i tentativi di agire su un mondo culturale, e su se stessi in quanto elementi di quell’orizzonte, non possono che partire da un’apprensione critica dell’acqua in cui si nuota – apprensione faticosa, perché rivela le proprie collusioni e richiede una certa disponibilità alla trasformazione.”
Per quanto lineare ed evidente possa apparire questa posizione, è contraddittoria: infatti se l’uomo fosse così intrinsecamente storico, se la sua coscienza fosse storica, anche la consapevolezza di questa storicità sarebbe storica, e pertanto, come in effetti accade alla fondazione storicista, se è vero quello che lo storicismo dice, allora è falso (nel senso che vale solo storicamente). E così quel mare in cui nuotiamo o sarebbe solo un mare storico, presente nella nostra epoca storica, oppure non potremmo neanche percepirlo se qualcosa di noi non fosse già da sempre fuori dal mare. In sostanza: se la posizione storicista fosse vera, non la potremmo mai esprimere perché o non potremmo avere la nozione di storia, o la nozione di storia sarebbe storica, quindi valida solo nella porzione di storia in cui di essa si tratta.
Ciao Negante! Anche in questo caso, questione notevole, che ci porterebbe lontanissimo. Dopo aver attaversato “La linea e il circolo” di Enzo Melandri (a volte canticchiandolo sulle note della “Vispa Teresa”, perché capire fino in fondo era troppo arduo), me ne sono fatta una ragione: con la contraddzione bisogna convivere. La logica serve a rendere solido un mondo, a non farlo naufragare nel “tutto vale tutto”, ma se la applichi a oltranza finisce con lo sfrangiarsi, oppure col diventare una gabbia micidiale che impedisce la creatività, la resistenza e la metamorfosi (v. le osservazioni di Hannah Arendt sull'”alfabeto logico” degli assassini).
Buongiorno Negante, aggiungo che il movimento fondamentale della ricerca sul campo etno-antropologica è proprio quello di spingersi verso l’acquisizione (beninteso: parziale, politicamente situata, intrisa di contraddizioni e resa possibile da un surplus di potere rispetto al contesto) di uno sguardo emico – termine poco à la page, ne convengo, ma tecnicamente preciso – altro rispetto al proprio. Come ha sostenuto ripetutamente Francesco Remotti, il senso stesso della ricerca etnografica è quella di dotarsi di uno sguardo “da fuori” sul proprio mondo. Quello che lui chiama “il giro lungo dell’antropologia” è proprio un tentativo, perennemente parziale, di confrontarsi con la storicità propria e dei propri strumenti conoscitivi.
Buongiorno Cristina. E’ un intenzione nobile e scientifica, questa che illustra, e direi che è alla base di quello che intenderebbe essere il pensiero scientifico: posto da un lato il soggetto che ricerca e l’oggetto ricercato dall’altro, a noi interessa l’oggetto, non come noi lo vediamo. Tuttavia mi domando, e le domando: come facciamo a sapere se ciò che abbiamo acquisito come prospettiva altra sia effettivamente tale e non sia l’altra prospettiva reinterpretata dalla mia? dove trovo quella postazione che mi consente quella neutralità tale da poter vedere il passaggio che ho fatto da una propettiva all’altra?
Felice di riprendere la questione. Già che con Stefania siete in tema, propongo che la pratica etnografica sia eminentemente una pratica analogica. Aggiungo, che il senso del “giro lungo” che propongo, almeno per l’uso che ne faccio io in seno alla pratica etnopsichiatrica è proprio quello di avere il “noi” come obiettivo passando per l’altro come strumento, più che come oggetto dell’osservazione. Appunto, partecipante. L’interesse dell’indagine etnografica sta nell’offrire una prospettiva esterna sul noi, non nella conoscenza dell’esotico. In questa prospettiva la definizione dell’altro come oggetto perde di centralità. (Non di pregnanza politica)
Ciao Stefania. Il libro che citi è qui di fianco a me nel mio tavolo, inoltre Melandri è il prof. con cui mi laureai decenni fa. Quindi come speravo ci siamo capiti subito. E infatti se mi sono permesso di farti una osservazione è perché si legge nel vostro testo grande rigore argomentativo. Il rigore è più ancora della coerenza. Non è solo coerenza. Inoltre, un altro grande filosofo italiano coetaneo a Melandri, anche egli morto negli anni 90, Giovanni Romano Bacchin, soleva dire che un filosofo che temesse le contraddizioni sarebbe come un chirurgo che temesse il sangue. Il che però non vuol dire che le possiamo accettare. Ci dobbiamo convivere ma sempre con l’intento di toglierle, anche se poi proseguendo ne troviamo delle nuove. Dunque, le contraddizioni, nelle nostre fondazioni, sono inevitabili ma non necessarie. E allora quando dici “me ne sono fatta una ragione”, io intendo che ti sei fatta una ragione non della contraddizione (che è in sé non-ragione) ma del nostro inesausto lavoro inteso a cacciarle. Comunque mi rendo conto che siamo in un ambito molto specifico del tema che qui non può essere trattato, ma mi fa piacere che una seria ricercatrice come te abbia solide basi teoretiche.
Ciao Negante, contenta anch’io di poter parlare senza troppi preamboli di Melandri (caso rarissimo, purtroppo, e immane spreco di una delle eredità più preziose in assoluto).
Non sono sicura che la contraddizione sia non-ragione, salvo identificare la ragione con la logica o immaginare di poter logicizzare tutto. Il che (a quel che ho capito) è proprio quel che Melandri smonta: alla radice di qualsiasi linea argomentativa, per quanto logica e ben strutturata, c’è sempre una scelta, e cioè un’analogia.
E infatti Cristina – che ha lunghissima esperienza di campo – propone di considerare l’etnografia come una pratica analogica: un po’ perché nessuna cosmovisione (nemmeno la nostra) ha piena tenuta logica; un altro po’ perché per mettere a confronto logiche differenti serve l’analogia; un altro po’ ancora perché la logica si può applicare dove i termini siano già definiti (pre-giudicati, in qualche modo), mentre se navighi nell’oscurità epistemica lo strumento migliore – per quanto inaffidabile – resta l’analogia.
Stefania, per una volta, forse la prima e unica, sono ottimista: un vero filosofo è sempre inattuale, e già il fatto che tu e Cristina ne stiate sviluppando un aspetto performativo, e che io lo abbia recuperato in merito ad una ricerca di filosofia teoretica sul linguaggio, mi fa pensare che piano piano lo spreco viene ridotto, e qualcosa cresce. Vedremo. Intanto vedo che Wu MIng 2 ha colto perfettamente lo spirito del tema da portare avanti, e quindi di lì muoverei la discussione. Su ragione e contraddizione potremmo parlare per giorni. Il punto, lo accenno, è che dall’analogia dobbiamo poi andare verso nord, come dice Melandri, a nord dell’analogia c’è la dialettica. Solo in quel terriotorio possiamo capire meglio cosa sia ragione.
Perché è nella praxis che ci riconosceremo… (Anche assunto, come certi farmaci, in isolamento da altri principi attivi e nella solitudine delle proprie letture, Melandri è già una bella ragione di ottimismo!)
Sul tema (politicamente – ma anche ontologicamente – cruciale) precisato da Wu Ming 2: si tratta di capire quali sono, e come sono fatti, i margini di libertà e di scelta, data la tendenza dei contesti a essere fortemente determinanti e a diventare sclerotici (in libera traduzione: data la tendenza del potere a scivolare in dominio). Ci piacerebbe arrivare a ragionarci, prima o poi. Nel frattempo, troviamo che sia utile, nella terra della libertà data ideologicamente per scontata, rammentare che i nostri pensieri e perfino le nostre emozioni hanno una storia; e che questa storia non è l’intero del pensabile/vivibile.
Stefania & Cristina ci invitano a gettare uno sguardo critico sull’acqua in cui nuotiamo. Negante alza la mano e dice: aspettate un attimo, da dove lo lanciamo questo “sguardo critico”? Se pensate di potervi tirare fuori da quell’acqua per osservarla, state facendo rientrare dalla finestra la “prospettiva sovrana della ragione astratta”, l’individuo moderno, freddo, razionale, universale che avete appena cacciato dalla finestra. Obiezione fondamentale, che io tradurrei in una domanda: in che modo possiamo analizzare l’acqua in cui nuotiamo, senza pretendere di uscirne e volarci sopra, come lo spirito di Dio nel primo giorno della Genesi? Credo che la risposta passi dal superamento dei dualismi natura/cultura, storia/evoluzione e via discorrendo. Infatti, se pensiamo di essere soggetti che costruiscono il loro ambiente dando forma culturale a una sostanza naturale, allora la critica dell’acqua in cui nuotiamo cade per forza nella contraddizione descritta da Negante: per analizzare come un oggetto le mie forme culturali, delle due l’una, o credo di poter accedere a uno sguardo indipendente da qualunque filtro culturale (la mitica ragione illuminista) oppure dovrò, in un passaggio successivo, guardare da fuori il punto da cui ho guardato da fuori il mio modo di costruire il mondo – in un regresso all’infinito. Se invece abbandoniamo quei dualismi, ci resta l’interazione tra l’essere umano e il suo ambiente – e pazienza per la distinzione tra noi e gli animali basata sul fatto che noi soli siamo sapiens, noi soli ci guardiamo da fuori e ci chiediamo “Chi sono?”. E’ proprio vivendo quell’interazione, abitando il mondo, che possiamo domandarci come lo abitiamo. E’ proprio perché non ci alziamo sopra le acque, che possiamo intuire come ci nuotiamo dentro. E’ camminando che possiamo comprendere il nostro modo di camminare, che non è “naturale” o “innato”, ma non è nemmeno “storico” o “culturalmente costruito”. Più semplicemente è il risultato del nostro abitare un determinato mondo, di crescere e svilupparci all’interno di esso, a contatto con strade e storie, parenti e pareti, abiti di stoffa e di vita.
Questione continuità/discontinuità della fase neo-liberista rispetto alla modernità precedente.
Ho maturato un dubbio. Mi pare che il c.d. neo-liberismo non sia altro che una risposta strategica, o una sorta di “rimbalzo” storico, conseguente al rischio di cambiamento radicale post II GM. Il secondo dopoguerra, “l’Età dell’oro” di Hobsbawm, ha avuto molti esiti paradossali, tra cui quello di far sorgere una minaccia di massa verso gli assetti socio-politici globali molto più forte e radicale di quella rappresentata dall’URSS e dai paesi del “secondo mondo”. Che anzi contrastarono la ventata emancipativa globale quasi quanto le classi dominanti del “primo mondo”. La de-colonizzazione e il pensiero post-coloniale, i movimenti giovanili, il femminismo, la liberazione sessuale, la critica a tutti i dispositivi di veridizione e disciplinamento, la stessa cultura popolare hanno costituito per un certo periodo un contraltare sia al dominio capitalista sia ai regimi autoritari di segno grosso modo marxista-leninista. Il vero nemico, il dominio capitalista, con notevole istinto di sopravvivenza, ha reagito in modo più efficace. Non solo ha inglobato gran parte di quelle pulsioni, traendone profitto, ma ha anche attinto al senso e alle forme di questa controparte e li ha impiegati per consolidare il proprio dominio, per rendere innocue le armi del nemico, per irretirlo. Da qui la polverizzazione sociale e l’assolutizzazione dell’individuo. Da qui l’invasione di nuovi spazi da cui estrarre plusvalore, comprese le relazioni personali e persino la psiche delle persone. Le lotte sociali e la produzione teorica del secolo precedente sono serviti paradossalmente più a immunizzare i presidi del capitalismo che a sconfiggerli. Senza volerlo, s’intende. Dunque non discuterei tanto di continuità/discontinuità, quanto di un movimento dialettico.
La crisi da covid19 non è autogenerativa. Ha però una potenzialità tale da rendere espliciti certi nessi, da far cadere veli di ipocrisia o di dissociazione. Oppure da enfatizzare tutto questo e riprodurre le stesse condizioni ad un livello ancora superiore.
In questi mesi mi sono chiesto spesso come mai i più feroci propugnatori dell’isolamento sociale siano certi (per me ormai ex) compagni. Alcuni nell’isolamento sociale vedono non solo un (estremo) presidio sanitario, ma un vero e proprio strumento di lotta, un’opportunità di palingenesi, un qualcosa di salvifico, con connotati quasi mistici. Una possibile risposta è nel processo più volte richiamato qua su giap e così sintetizzato da Omar qua sopra:
“Da qui l’invasione di nuovi spazi da cui estrarre plusvalore, comprese le relazioni personali e persino la psiche delle persone.”
Se le nostre relazioni sociali e la nostra psiche sono diventate materia prima da cui il capitale estrae valore, allora nell’implosione accelerazionista innescata dalla pandemia distruggere la nostra vita sociale e la nostra psiche diventa la forma più avanzata di lotta anticapitalista. E’ una forma estrema di luddismo che si risolve nell’autolesionismo, nell’autocastrazione, sostanzialmente nel suicidio. E’ questa la nuova sinistra doomer occidentale e in particolare italiana, e non è difficile capire che per il capitale non costituisca affatto una minaccia, visto che estrarre plusvalore da chi sta chiuso in casa da solo, e distrugge la sua psiche sbroccando sui social e acquistando on line, non è poi tanto complicato.
Non costituisce una minaccia e anzi ne diventa un dispositivo di conferma. È una forma di resa nichilista, ma ammantata di una retorica “di sinistra” ormai solo supponente ed esplicitamente elitaria. Non a caso, molti esponenti di questa categoria sono gli stessi che discettano di “analfabetismo funzionale” delle masse (da abbandonare al loro destino), di “sopravvalutazione del suffragio universale” (nel senso che preferirebbero restringerlo) e altre amenità reazionarie di questo genere. Una (ex)sinistra di destra banalmente anti-popolare (benché si descriva come anti-populista) e in fondo anti-democratica.
Il nodo è quello che emerge dalle discussioni qui e in poche altre sedi, e molto bene da questo stesso articolo che stiamo commentando: se si perde lo sguardo d’insieme, non solo sincronico ma anche diacronico (ossia storico), si finisce schiacciati dall’infodemia e se ne subiscono gli effetti passivamente, anche (e a volte soprattutto) quando si ritiene di avere i mezzi per non farsene travolgere.
In questo senso sono molto più vitali e originariamente sane certe reazioni istintive, magari malamente affascinate da robaccia tipo QAnon o irretite dalla propaganda destrorsa, di questa adesione acritica e terrorizzata al virocentrismo di governo. Qui si apre un’altra partita complicata, chiaramente. Drammatico non poterla giocare con buone carte e un minimo di strategia collettiva. Ma è importante almeno riconoscerne le cause, i contorni e le dinamiche, senza lasciarne il contrasto in mano ai vari burionismi social e al pensiero magico scientista, in fondo organici a quello neoliberista.
@OmarOnnis
I movimenti dialettici non sono incompatibili con le discontinuità, anzi. Il principio della trasformazione della quantità in qualità, che è uno dei punti fondamentali del materialismo dialettico engelsiano, è la definizione stessa della discontinuità. E non ci vuole necessariamente una rivoluzione sociale per produrre discontinuità del genere.
Ho cominciato a domandarmi seriamente se quello che è successo negli anni ’70 abbia rappresentato una discontinuità netta quando a un certo punto mi è sembrato che tutta una serie di strumenti, narrazioni e frame che fino a quel momento avevo dato per buoni non riuscissero a rendere conto fino in fondo di come il genere di società in cui viviamo avesse potuto emergere da quella fase storica e, soprattutto, avesse preso la direzione che ha preso (bisogna che le fasi storiche maturino un pochino per sperare di cominciare a intuire in che direzione vanno a parare).
A quel punto, è stato il classico “cambio di Gestalt”: se si pensa a questo nuovo assetto in fase di costruzione come il prodotto di una discontinuità, gli strumenti vanno ricalibrati, aggiornati e riconfigurati.
Il termine “neoliberismo” ci sta, ma secondo me è anche un po’ una trappola se si parte dal presupposto della discontinuità. Come scrivevo sopra, io lo penso come un insieme di dispositivi “governamentali” (per dirla con Foucault) che hanno accompagnato la prima fase di sviluppo di questo nuovo assetto, ma che stanno evolvendo sotto i nostri occhi. Poi possiamo certo continuare a chiamare “neoliberismo” il sistema di governance che verrà, se vogliamo… ma ho i miei dubbi sul fatto che le sue caratteristiche saranno del tutto riducibili a quello che abbiamo visto (e soprattutto sperimentato) in questi ultimi decenni.
Sì, sono d’accordo. Infatti preferisco riferirmi alla fase che è iniziata dagli anni ’70 come a una transizione storica. Non solo complicata e conflittuale, ma anche totalmente attuale. Nel senso che ci siamo dentro. Come tale, è possibile discernere giusto alcuni suoi tratti, man mano che si presentano, e alcune tendenze di fondo, a patto di riuscire ad avere uno sguardo ampio e sufficientemente distaccato. L’epidemia di covid19 in questo senso può essere – non so se e quanto paradossalmente – anche un grande strumento conoscitivo, oltre che un caso di studio di per sé, perché è come se ingrandisse e al contempo concentrasse tutto (o molto). Ma non possiamo conoscerne la durata né gli esiti. Questo aspetto è una fonte di angoscia e può sfociare, più o meno consapevolmente, in forme di dissociazione, ripiegamento, nichilismo, ecc.
Grazie per questo articolo. Avevo letto con interesse il vostro precedente, e sebbene mi trovassi in disaccordo, ho comunque trovato salutare l’intervento di due antropologhe nella discussione virocentrica che si sta conducendo in Italia. Sono stato collega di David Graeber fino alla sua improvvisa dipartita (che sua moglie ora spiega come causata dagli effetti di un “long covid”). Negli ultimi mesi prima della sua morte David si e’ speso, insieme a molti altri colleghi, per ritagliare all’antropologia un ruolo importante nel indirizzare se non il dibattito pubblico almeno le policies sulla gestione della pandemia. E’ grazie alla collaborazione e all’impegno di molti di noi (dottorandi, ricercatori e strutturati) se oggi in UK le regole sui funerali sono cambiate, abbiamo introdotto le social bubbles e abbiamo avviato un dibattito sulle ripercussioni che la gestione della pandemia sta avendo sulle frange piu’ vulnerabili della popolazione, in particolare sulle minoranze etniche. Lungi da fare “critica-critica” molti antropologi hanno abbandonato la consueta postura di opposizione radicale al sistema, per sporcarsi le mani in vari boards e commissions e cercare di attenuare qui e ora gli effetti piu’ indesiderati di una gestione pandemica ideologica e produttivista. Condivido pienamente la vostra lettura dell’”evento”, ma mi sembra che in questo intervento facciate di tutto per evitare di spingervi verso conclusioni che ormai molti di noi hanno accettato come “necessario realismo virologico”: non esistono investimenti in sanita’ che potranno mai mitigare gli effetti di politiche di apertura indiscriminate; non esiste la possibilita’ di educare oggi senza piani seri di ripensamento degli spazi educativi e l’introduzione di qualche forma di educazione in remoto (qui a LSE insegniamo in presenza, ma abbiamo accettato orari inconsueti, come lezioni alle 6-7 di mattina, o il sabato sera). Non si puo’ pensare di fare critica del “disastro” senza prima aver fatto di tutto per mitigare gli effetti che questo sta avendo su specifiche fasce della popolazione. Qualsiasi rinuncia a questo principio e’, a mio personale modo di vedere, una forma di quel “sussiegoso ragionare al riparo dei propri privilegi di classe” che cosi’ eloquentemente smantellate nel vostro pezzo.
Ma anche volendo accettare il piano che proponi – secondo me facendola troppo semplice, perché una porzione significativa di quello che viene presentato come «realismo virologico» fa a pugni con la realtà, spesso parte da premesse mai verificate, da congetture date fallacemente per confermate, e ha sviluppi a dir poco surreali –, secondo te, con la massiva «trahison des clercs» che abbiamo avuto in Italia; con il clima repressivo che c’è; con la demonizzazione di ogni rilievo critico non-virocentrico; con l’accusa di «negazionismo» scagliata contro chiunque per i motivi più labili; con la stolidità di istituzioni che vanno avanti come carri armati, di dpcm in dpcm, senza ascoltare nessuno che proponga altre angolature e soluzioni; con il Censis che, usando un linguaggio da Totale Mobilmachung anziché un linguaggio da statistici, dice «meglio sudditi che morti» (alternativa infernale se mai ce n’è stata una)… Insomma, in una situazione soffocante come questa, quali sarebbero i board e le commission in cui chi la pensa diversamente avrebbe potuto «sporcarsi le mani»?
Ciao Stefania, ine realta’ intendo qualcosa di perfino piu’ brutto e sporco: fare di tutto per diventare interlocutori credibili per quelli che una volta avremmo chiamato i nostri nemici di classe. Il lavoro che facciamo qui e’ fondamentalmente una forma di consulenza al governo di Bojo. Cio’ significa che se lo facciamo bene stiamo indirettamente dando piu’ credibilita’ al piu’ reazionario dei governi inglesi da Churchill in avanti. Se l’attivismo e’ l’unica forma di organizzaziano possibile per superare il realismo capitalista (per evitare future pandemie dobbiamo fondamentalmente distruggere l’industria della carne e farmacologica per come la conosciamo oggi, no small fit), il realismo virologico, i danni che questa “cosa” fa oggi, mentre scrivo, sulla pelle e la psiche di miloni di persone richiede qualcosa di diverso, richiede l’occupazione cognitiva dello stato. E’ un lavoro orribile ma essenziale, e dobbiamo farlo.
Gilgalad, ho capito il problema… accidenti. Forse non c’entra niente, ma mi hai fatto venire in mente la ricerca di campo di un antropologo fra i broker finanziari dei derivati azionari, e il tipo di questioni etiche e politiche che era stato costretto ad affrontare (qui un resoconto del suo lavoro, che probabilmente tu già conosci: http://suitpossum.blogspot.com/2015/08/financial-anthropology-culturehacking.html); nonché la dark anthropology e le sue avventure nella wild side del mondo presente. La sola cosa che mi verrebbe da aggiungere è: in quelle lande, è bene non restare troppo tempo da soli.
Facilis descensus Averno.
La questione che pone gilgalad a me pare molto importante. La tematizza da una postazione scomoda: quella di chi si ritrova nel ruolo di “consigliere” del governo di Mr. Wannabe Churchill per provare a salvare il salvabile e ridurre il danno del governo degli inetti. È, per certi versi, questione atavica quella del grado di compromissione col potere e del confine tra contenimento e complicità (per dirla rozzamente). Nel 1940 i laburisti appoggiarono Churchill, perfino contro la maggioranza del suo stesso partito, entrando in un governo di salvezza nazionale, e immagino che parecchi ingegneri lavorarono al perfezionamento degli apparecchi della RAF che salvarono le isole britanniche dall’invasione nazista senza preoccuparsi di come sarebbero stati utilizzati in seguito (ad esempio per il bombardamento-rappresaglia di Dresda o negli anni Cinquanta in Kenya, dal medesimo Churchill).
Come si fa a fare la propria parte per aiutare il prossimo, consigliando il “sovrano” per il meglio, e al tempo stesso mantenere un approccio critico alla conduzione delle cose? È impresa ben più difficile – eticamente, politicamente – che gestire un blog. E soprattutto, è questione senza soluzione.
Io non credo che in certi frangenti si possa fare molto altro che navigare a vista seguendo la propria coscienza. Ha ragione Stefania: meglio non essere soli. Ma è una regola aurea generale, questa. Basti dire che Giap per certi versi esiste allo scopo, come generosamente le due autrici dell’articolo riconoscono. E questo è il nostro contributo. Ben poca cosa, ma è quello che possono fare gli scrittori, oltre a provare a raccontare i tempi. Ché di una solidarietà a parole gilgalad, come chiunque altro in una posizione scomoda, se ne fa poco o niente. Tanto più dopo avere simbolicamente scelto il nickname dell’ultimo re dei Noldor, ucciso per mano di Sauron mentre salva la Terra di Mezzo.
Sono sicuramente colpevole di avere poca dimestichezza con il “clima” che si vive in Italia in questi mesi, ma ho seguito il “dibattito” sulla pandemia attentamente (e tutto cio’ che non si dice a riguardo, e.g. di quale sia davvero la situazione negli ospedali o su come molti paesi asiatici abbiano gestito l’emergenza meglio di noi. Ricordo di essere intervenuto qui mesi fa sulla questione e mi venne risposto – non da voi Wu Ming – che gli amici infermieri alle cui storie di esasperazione mi riferivo non erano realmente in grado di vedere il fenomeno nel suo complesso). Quello che mi appare evidente e’ che per noi antropologi non ci sia alcuno modo di intervenire efficacemente “nel” e “sul” mainstream Italiano — conosco perfettamente la posizione di “marginilita’” cosi’ ben descritta dalle autrici di questo articolo. Quello che pero’ mi sembra opportuno sottolineare e che ci possano essere spazi certamente meno visibili ma forse maggiormente influenti nei quali da antropologi possiamo si investire capitale culturale e di expertise. Ho recentemente partecipato alla conferenza nazionale della societa’ Italia di Antropologia Applicata e molti interventi hanno riguardato pratiche attive nelle istituzioni e nella sanita’ che molti di noi stanno conducendo per attenuare gli effetti piu’ deleteri della gestione pandemica. Penso a persone come Antonino Colajanni che sono estremamente ben connsesse ed influenti politicamente, e allo spazio che si puo’ occupare con le nostre conoscenze. Dico solo che una posizione diciamo “Basagliana” in Italia sia ancora possibile e che marginalita’ nel dibattito pubblico spesso si traduce in capacita’ di oeprare alla “frontiera” della prassi emergenziale.
Ciao Gilgalad, non mi è chiaro il punto del tuo post e in particolare questa frase: “Non si puo’ pensare di fare critica del “disastro” senza prima aver fatto di tutto per mitigare gli effetti che questo sta avendo su specifiche fasce della popolazione”.
Se intendi dire che, nella melma in cui siamo, bisogna soprattutto “sporcarsi le mani” con la politica, l’attivismo, l’organizzazione di spazi di protezione – beh, sì, certo. Ma troverei di cattivo gusto aprire un un post elencando le mie medagliette di attivista (e anzi: non perderei tempo a scrivere per un blog, se questo richiedesse un patentino di buona condotta.)
Se invece intendi che /prima/ bisogna mitigare gli effetti, e solo /dopo/ si può ragionare, allora no. Di azioni voleterose, benintenzionate, orbe rispetto a proprio presupposti e del tutto cieche rispetto alle esigenze del prossimo è pieno il mondo. E il risultato si vede (v. ad esempio, il fallimento etico e politico della cosiddetta “cooperazione internazionale”). In più, a forza di non pensare, il sistema pensa per noi e finisce con l’imporci un “necessario realismo virologico” che altro non è se non l’ennesima versione del realismo capitalista.
In realtà sto commentando solo perché ci tenevo particolarmente a ringraziarvi di questo pezzo.
Mi ha confortato molto leggerlo, non scherzo e non solo per la lucidità e le traiettorie che riesce così miracolosamente a tenere assieme a mio modo di vedere ma anche perché è una sorta di bussola in un momento così difficile. Rimette a dritta il timone dell’analisi e al tempo stesso riavvolge un nastro che si pensava ormai del tutto perso.
Fra l’altro, proprio in questi giorni, stavo leggendo l’ultimo libro di Marco D’Eramo, “Dominio”, che ricostruisce un po’ la genealogia di come sia stata progettata e costruita la soggettività contemporanea. Lettura che si sposa molto bene con questo preziosissimo pezzo.
Poi vabbé che altro dirvi, siete riuscite a citare sia i Pink Floyd che Clastres, chapeau!
Grazie, grazie grazie e ancora grazie.
Salve, sono a digiuno di buone maniere Forum-Social-Digitali (FSD) e non so come introdurmi in questa discussione in altro modo che a gamba tesa.
Alcune regole minime di discussione le ho intraviste in qualche commento dei Wu Ming ma sembrano rivolte ad un nocciolo duro di partecipanti che si frequentano anche dal vivo quindi, non trovandole scritte in nessuna pagina specifica, mi trovo costretto ad ignorarle. Mi scuso in anticipo.
Ho letto a ritroso e con interesse tutti i post di attualità politica di questo blog che colpevolmente non leggevo più da tempo, ho letto con pazienza anche tutti i commenti dei post più frequentati, senza mai intervenire perché resistente alla tentazione di gettarmi nella mischia FSD per affermare le mie temporanee certezze o condividere i miei dubbi.
Stavolta però non resisto e dico: suggerire che la madre del malessere odierno (inteso come tutti i mali) sia la modernità (colonialismo + capitalismo + scienza -> Stato nazione … fino al neoliberismo) credo sia una riduzione discutibile.
L’antropocene, stavolta il padre di tutti i mali, ha sicuramente origini anteriori.
Oggi è estremamente utile leggere o rileggere Illich che qui citate, come ha suggerito di recente Agamben*… anche lui da rileggere, perché entrambi ci insegnano che dovremmo rivolgere di più lo sguardo al passato.
Però, quando si approccia il pensiero radicale di Illich bisogna accoglierlo tutto (non manca certo di sistematicità, fondatezza e coerenza), non basta citare en passant “Nemesi Medica”.
Senza riapropriarsi oggi, in una riflessione sul come siamo arrivati fin qui, anche di “Gender”, testo nel quale l’autore si irrigidisce manifestamente con l’antropologia, si rischia di produrre delle fallacie archeo-logiche che minano l’intera riflessione.
Io ho trovato il presente intervento di difficile lettura per questo motivo, non per altro. Intervento comunque gradito, pertanto grazie.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
* anche se qui su Giap Agamben è stato ingiustamente accusato di aver sistematicamente sbagliato lo sbagliabile su Pandemia2020 (detto con altre parole, mi scuso con Wu Ming 1).
Porto anch’io qualche tessera allo smagliante mosaico di Consigliere e Zavaroni.
“Se siamo così malmessi, non è per via di un destino ineludibile o di immutabili leggi di natura, ma a causa di ciò che è successo ai singoli e ai collettivi, dell’organizzazione delle nostre vite, dell’insieme di convinzioni e costrizioni che regolano i nostri giorni.”
Se i tempi di nuovi progetti politici sono lunghi e incerti, forse un po’ di creatività sociale ci aiuterebbe almeno nella gestione del quotidiano. L’ambiente arricchito, una delle variabili importanti della psicoepigenetica, e le riflessioni sulla intersoggettività di alcuni filosofi e neuroscienziati dovrebbero spronare a costruire qualcosa di diverso – forme di vita diverse – senza però guardare nostalgicamente alle comuni degli anni ’60 o ai vecchi modelli di famiglia allargata di stampo contadino e al di fuori del “poliamore”.
Penso a forme di co-residenza che però non ricalchino l’impianto organizzativo delle RSA, case di riposo ecc. o delle comunità-alloggio/casa, che ingabbiano le età, la condizione anagrafica e altro ancora.
“L’ambiente non è qualcosa di esterno, uno sfondo ostile o accogliente, un parco da colonizzare, ma l’esito di un modo di vivere e di stare in relazione fra umani e non-umani. È il caso della parentela, persone «fatte della stessa sostanza».”
Donna Haraway, autrice di “Chthulucene. Sopravvivere su un pianeta infetto” esorta al “making kin”: creare delle parentele, delle affinità, non solo con altri esseri umani ma con i molti esseri viventi sul pianeta. 1/2
2/2
“Espropriati soggetti e comunità della possibilità di agire sull’ambiente, delle basilari competenze di salute primaria e della presa sui diversi momenti dell’esistenza, l’unica risorsa di salute disponibile è quella professionale e statale”
La tecnologia medica ha accresciuto la dipendenza dei “pazienti” nei confronti delle macchine e dei tecnici in grado di controllarle. E non si può certo affermare con sicurezza che si siano affinate le capacità diagnostiche.
@StefanoR
“Lo sviluppo della conoscenza scientifica e delle sue possibilità di applicazione pratica richiede inevitabilmente la specializzazione.”
Questo sviluppo ha portato, e lo possiamo constatare attualmente, a un non sano dibattito medico-scientifico. L'(eccessiva) specializzazione non sprona a riflettere sui presupposti del proprio ambito di ricerca, sulla somiglianza/divergenza con altre discipline e sui vari contesti. Favorisce un atteggiamento mentale tutt’al più di interdisciplinarietà, non di metadisciplinarietà/complessità.
@Nina
Subito dopo però ho aggiunto anche che le conseguenze concrete di questa proliferazione di conoscenza sollevano a loro volta una quantità enorme di problemi e rischi, che richiedono l’elaborazione di ulteriori conoscenze e applicazioni.
La specializzazione è quello che ci permette di avere cure, vaccini, materiali all’avanguardia, soluzioni innovative per lo smaltimento di rifiuti o la produzione di energia… e in generale conoscenze sempre più approfondite su come funziona il mondo, con tutte le relative possibilità di applicazione tecnica che ne derivano e che possono aiutarci a migliorare l’esistenza di milioni di persone e anche a sperare di risolvere alcuni dei problemi originati dallo stesso sviluppo tecnico ed economico.
Ma anche l’approccio metadisciplinare di cui parli, in fondo, è una specializzazione: richiede strumenti di analisi e di intervento specifici, anche se tenta di abbracciare un orizzonte più vasto. “Specializzazione” non è (necessariamente) sinonimo di “settorialità”.
Il mio punto era che se vogliamo disporre di strumenti conoscitivi e pratici avanzati per cambiare la nostra società per il meglio, dobbiamo fare i conti (a) con l’inevitabile proliferazione delle specializzazioni e (b) con la necessità di sviluppare nuovi filoni di specializzazione per l’analisi e la gestione dei rischi connessi a questa proliferazione e alle sue applicazioni pratiche.
Si tratta di un ragionamento “se-allora”. Il che vuol dire che ciascuno è poi libero di rifiutare la premessa e pensare che la specializzazione sia un problema in sé e che vada quindi rigettata a favore di un approccio differente… io personalmente non sono d’accordo, non solo (e non tanto) per motivi di convinzione personale, ma anche e soprattutto perché, volenti o nolenti, siamo “presi” in una dinamica del tipo che ho descritto. In altre parole: il punto secondo me non è la specializzazione o meno della conoscenza, ma la titolarità del processo conoscitivo, l’esistenza di un controllo collettivo su di esso, la possibilità, come società, di orientare le sue finalità pratiche… nella consapevolezza (non però rassegnata!) del fatto che, vista la complessità enorme del processo, ci saranno sempre delle aree “opache” che sfuggiranno allo sguardo e al controllo collettivo.
[…] Terminata la lettura del post di Stefania Consigliere e Cristina Zavaroni, pubblicato su Giap e intitolato Come siamo arrivati fin qui? Il contagio di un’idea di salute, ho avuto modo di confrontarmi velocemente e avere un feedback sulla preziosità di questo contributo da parte di alcune mie sodali. In questo primo scambio di pareri a caldissimo, una di noi riporta una considerazione raccolta secondo cui «il grande limite del post è nella complessità del linguaggio». Successivamente anche nei commenti in calce al post si sviluppa un thread proprio a partire da una considerazione simile a quest’ultima, con Nene che chiede: […]
(Scrivo anche a nome di Cristina Zavaroni)
Ci stiamo – a non star sol*, cioè, e a cominciare un lavoro di ripensamento collettivo del nostro mondo e di noi in quel mondo. Con qualche premessa e una domanda.
Prima premessa. La difficoltà “interna” al post viene da un intreccio di fattori. Il linguaggio tecnico delle scienze umane (che, anche diluito, resta comunque latinorum); il fatto che l’argomentazione non è per singoli punti sulla base di uno sfondo già condiviso, ma è un’unica arcata (e richiede quindi di trattenere il respiro); e soprattutto il fatto che, attraverso l’antropologia, si aprono prospettive stranianti. Come scrivevo a Nene, a voce è tutto più semplice, c’è un contesto materiale condiviso, ci sono i timbri, si può andare e tornare, si possono prendere altre strade. Mediato da un articolo, e peggio ancora in un post, il discorso arriva secco come un ramo d’inverno e se ti piglia male non c’è nessuno lì accanto a ingentilirlo.
Seconda premessa. La difficoltà “esterna” al post viene dal fatto che siamo socialmente disabituati all’attenzione prolungata. È un punto su cui non serve insistere (basta vedere la scuola, l’università per pillole, il modo in cui sono montate le serie tv, la rapidità degli spot, il tempo in cui possiamo lasciar stare il cellulare), ma l’esito è un disastro cognitivo. E se nell’epoca della massima complessità sistemica globale “la scienza dice” che l’attenzione umana non dura più di 15 minuti, è lecito sospettare qualcosa di losco.
Tocca far fatica a tutti quanti. Cominciamo, allora, con la parte che tocca a noi, chiedendoti (e chiedendo ai giapsters) se potete darci un feedback tecnico sulle parti del post che sono risultate meno comprensibili. A partire da lì, proveremo a tener fede alla complessità senza perdere di vista la gentilezza.
Grazie Stefania e Cristina per questo commento, è bello leggere le vostre parole, soprattutto quelle nella frase finale. Ci piace l’attenzione a non perdere la gentilezza. E suona giusto anche il «tener fede alla complessità», un altro punto su cui sono assolutamente in accordo con voi. Mi ripeto: per me articoli come questo sono estremamente necessari, perché è irrinunciabile interrogarsi su e interrogare la complessità del reale, che altro non è che il mondo di relazioni in cui agiamo. Questo non toglie che sia utile porsi il problema dell’accessibilità, dell’inclusività – meglio – come scrive Nene, di analisi e testi di non immediata lettura. Per me questo scoglio o si supera collettivamente (coi tempi necessari, i lunghi tempi necessari), oppure temo che ci lascerà solx ognunx con le proprie – più o meno certe – certezze.
Sono in difficoltà a darvi un «un feedback tecnico sulle parti del post che sono risultate meno comprensibili», perché come ho scritto credo che la difficoltà discenda in primo luogo dall’approccio stesso alla complessità, non dai singoli concetti utilizzati; poi perché io alla mia maniera, negli anni, ho messo a punto un mio metodo, che tuttavia per quanto mi permetta di non subire blocchi reverenziali davanti a un testo denso come il vostro mi richiede tempo e risorse, generalmente “scarse”. Questo però vale per me e non mi impedisce di comprendere chi molla dopo aver letto pochi paragrafi (sicuro c’entra l’essere «socialmente disabituati all’attenzione prolungata», ma anche qui due parole aprono un discorso: come non tener conto che l’attenzione di ognunx di noi è sollecitata e contesa da molti “apparati di cattura”? Al contempo, non è necessario evidenziare l’ambivalenza di questo processo?) o chi avrebbe bisogno di chiarimenti su alcuni passaggi e non si sente di chiedere qui nei commenti su Giap. E, in generale, lo scrivete benissimo voi che apprendere criticamente dell’acqua in cui nuotiamo è una gran fatica, «perché rivela le proprie collusioni e richiede una certa disponibilità alla trasformazione».
Io mi interrogo, ed è confortante poterlo fare con voi e tuttx le/i giapster, su come uscirne, provando – sì, mi piace molto come l’avete espresso – «a tener fede alla complessità senza perdere di vista la gentilezza».
Io volevo aggiungere una considerazione sulla questione del linguaggio sollevata da Nene, mr mill e da altri. Se non sono capace di interpretare correttamente un testo, o anche una singola parola ( come “veridizione”, facendone una mia ricostruzione, magari sbagliata) posso domandare spiegazioni, senza falsi pudori. Se non capisco una cosa, chiedo. Chiedo perché dall’altra parte c’è la disponibilità a creare un rapporto dialettico su cui si possono costruire autentici e proficui confronti. C’è la formazione politica per affrontare il dibattito uscendo dal ruolo accademico. I post pubblicati qui sono sottoposti dai lettori ad un’ acuta scansione in grado di rivelare cose che i singoli assunti non avevano esplicitamente detto. Ognuno di noi punta il microscopio sulla definizione e sul focus che più caratterizza il suo modo di vedere. Per esempio, Negante attraverso la filosofia. Poi magari interviene Wu Ming 2 con una “dissertazione sull’acqua” che chiarisce un argomento filosofico astratto ed estraneo a molti. Io credo che se si vuole superare una difficoltà di comprensione si debba fare lo sforzo di mettersi in gioco. Come quando si impara a parlare un’altra lingua. All’inizio non si conoscono abbastanza termini per poter dialogare, ma se l’ obiettivo è comunicare si cerca di acquisire più termini possibili per comprendere e farsi comprendere. Se voglio capire, sono io che mi devo sforzare. Altrimenti il livello di discussione rimarrà sempre elementare, confinato alle istruzioni invece che alle riflessioni. Limitato all’impartizione invece che allo scambio. Usare un linguaggio complesso è un modo per fornire agli altri attrezzi che altrimenti rimarrebbero prerogativa solo di un selezionato gruppo di intellettuali. Quando impari una ricetta di cucina, per capire il motivo per cui le uova non possono essere mescolate immediatamente ad un composto troppo caldo (per evitare la pastorizzazione che comprometterebbe il risultato nei bignè, per esempio) posso anche dirti: non mischiare le uova con un composto caldo, ma non avrai capito per quale motivo non devi farlo. Solo perché pastorizzazione è un vocabolo nuovo?! Allora è meglio sapere cosa sia la pastorizzazione.
Nella mia esperienza di malintesi, il problema vero sono i termini facili, non quelli difficili.
Se in un testo mi trovo di fronte concetti come epoché, ontologia, sussunzione, e non conosco il loro significato, posso sempre trovare delle definizioni più o meno chiare o soddisfacenti. Il termine difficile, in un certo senso, risveglia la mia attenzione, e mi mette nella condizione più propizia per intendere quel che mi circonda. Se invece un geografo, o un antropologo, usano i termini paesaggio, territorio, spazio, io penso di aver capito tutto, perché sono termini del linguaggio comune, ma il geografo li usa in un senso preciso, con distinzioni importanti alle quali non presterò attenzione. E’ come quando vado a Londra e ordino un piatto di cucumber, sognando una bella fetta di anguria. I termini comuni, usati in senso tecnico, sono come dei falsi amici. Anche perché cambiano significato a seconda di chi li pronuncia: se un fisico dice “potenza” intende una cosa, se lo dice un filosofo ne intende un’altra. E addirittura: se un filosofo strutturalista dice “spazio” intende una cosa, se lo dice un filosofo kantiano ne intende un’altra. Il problema nasce quando ci si rivolge a un pubblico misto: perché se parliamo tra geografi e diciamo “paesaggio”, più o meno ci intendiamo, e se non c’intendiamo lo capiamo subito: “Questo è uno di quelli che intende il paesaggio come visione del territorio, pfui!”. Invece, come succede qui su Giap, è molto più difficile usare i termini in maniera precisa – per evitare di confondere i “precisini” che ne conoscono il significato tecnico – e dall’altra parte usarli in maniera comprensibile – così che se uno legge “spettacolo” e intende “esibizione artistica” non venga del tutto fuorviato perché non conosce l’uso situazionista di quel concetto (“lo spettacolo è il capitale a un tal grado di accumulazione da divenire immagine”).
Come hanno detto altri in questa discussione, è abbastanza semplice sciogliere i malintesi quando si è faccia a faccia, accettando anche un certo livello di incomprensione reciproca (“famo a capisse”), mentre è più difficile farlo in un testo breve. Una soluzione, che ho visto praticare da alcuni scrittori (anglosassoni, ça va sans dire) è quella di precisare fin dall’inizio, o alla prima occorenza, proprio i termini più suscettibili di ambiguità: “In questo articolo userò il termine paesaggio nel senso xy, e il termine “dominio” nel senso t…” Chiaro che non si può riscrivere ogni volta il vocabolario, ma se vogliamo fare attenzione al molteplice, i molteplici significati delle parole, e i molteplici dialetti delle varie tribù, possono essere un buon punto di partenza.
Si, è proprio vero quello che dici sui ” falsi amici”, facendo una precisazione importante. Io trovo però che l’argomento della complessità di un testo non possa diventare motivo di critica trasversale alla sua sostanza, per un semplice motivo: quando vado da un avvocato o da un medico, entrare nel suo linguaggio tecnico, può garantirmi di non essere completamente in suo ” potere”. Invece, nei confronti di queste figure, avviene come una delega spontanea dell’esistenza. Questa mancanza di esercizio critico sulla propria vita ha contribuito ad erodere il potere di classe dei più deboli. Per uno sfruttato, appropriarsi anche e non solo di una lingua che non gli appartiene, diventa il modo per sradicare una cultura di oppressione. Dalla mia quarantena fiduciaria senza neppure sapere se sono positiva e a cui ho dovuto porre rimedio con i soli mezzi che ho, facendomi ospitare in campagna, isolata, fuori Bologna, per continuare a poter fare uscire i miei cani, vedo un abuso di potere sulla mia vita che si giustifica con un sacco di termini tecnici a cui si viene piegati con la forza istituzionale della ragione. Nel doppio binario ipocrita di una falsa tutela della salute ( il mio compagno si è contagiato in ospedale e dopo di lui ne hanno trovati altri sei e, grazie solo alla sua insistenza, è stato possibile fare un tampone) mi viene imposta una misura restrittiva senza la necessità di alcuna ” prova”. Le parole in questa pandemia hanno giocato un ruolo fondamentale di stordimento ma dai più sono state accettate ed assorbite come elementi sacri e non discutibili. Dando per scontato il loro potere assoluto. Qui si è fatta molta fatica ad affermare la pluralità del termine ” lockdown”, una pluralità che corrisponde ad un universo di misure differenti. Le parole non possono diventare lo scoglio di fronte a cui rinunciare alla comprensione. Come hai specificato tu, vanno chiarite e precisate, soprattutto quelle ” semplici”.
Davvero complimenti, è l’articolo più interessante e ampio che mi sia ritrovato a leggere da un bel po’. Mi è venuto da pensare alla qualità letteraria e divulgativa degli anni ’70, alla complessità, originalità, profondità del pensiero di Pasolini o Camatte, alle prese bene della Beat!
Leggendo, mi sono chiesto (tra le milioni di cose) se non ci possa essere una sorta di contraddizione interna tra l’attitudine dell’individuo moderno a delegare ogni sua funzione vitale, sociale, di salute ecc. a un organo completamente esterno e astratto come lo Stato, o il capitale, o il potere, e la sua(dell’individuo) tendenza intrinseca a non riuscire a definire altro che non sia sè stesso, a sentirsi il centro del mondo, quasi fosse l’unica cosa reale.
E poi, domanda forse retorica, spero di no: è possibile che si sia arrivati ad uno stato di obsolescenza umana così avanzato da farci automaticamente barattare ogni curiosità con questa noia mortale?
1/2
Entro un po’ di sbieco nelle questioni sollevate da mr mill, Wu Ming 2, pto, tuco sul “che fare” a partire da dove siamo. Nel post abbiamo descritto la modernità, e l’attuale neoliberismo globale, come una gigantesca impresa di esproprio e messa a servizio. Ora, perché tutto possa funzionare secondo la logica del plusvalore, bisogna che tutto venga /ridotto/ e /unificato/ (“sussunto”, nel vocabolario di Marx) secondo un unico modello. La modernità è quindi, anche, una gigantesca impresa di abbattimento della molteplicità e della complessità, una messa a regime di ogni parte della vita umana (della sussistenza secondo i dettami del plusvalore; dell’affettività secondo il paradigma della coppia; della conoscenza secondo gli assunti dello scientismo; della coscienza secondo la gabbia della veglia razionale ecc.).
Opporre a questa modernità totalizzante un “Piano d’uscita” (come nel caso della rivoluzione: al singolare e meglio se con la maiuscola), significa rispondere in modo speculare e mimetico alle mosse dell’avversario, opporre a un Uno opprimente un altro Uno, che fantastichiamo libero e accogliente ma che, alla fine della fiera, non può che essere tanto opprimente quanto il precedente – e non perché male organizzato, ma, appunto, perché “uno”. Nonostante l’affetto per certe stagioni della lotta novecentesca, il machomarxismo ci sembra ormai poco utile. (Peraltro, come ha argomentato Pier Paolo Poggio in un’opera monumentale, l’opposizione binaria di “democrazia capitalista” e “comunismo sovietico” è stata una delle peggiori trappole concettuali del Novecento, funzionale alla rimozione della complessità del pensiero utopico-rivoluzionario.)
2/2
Rinunciare al Palazzo d’Inverno, però, non significa rassegnarsi al presente. A partire dalla tradizione femminista e da quella anarchica, si può ipotizzare che uscire dalla propensione totalizzante della modernità significhi, sempre e comunque, prender parte per la molteplicità e la complessità, per la libertà dei singoli di opporsi al dominio e delle collettività di autodeterminarsi.
In ciò, la “prospettiva di contrattacco più solida” ci sembra essere quella che passa per un’accurata, consapevole e gioiosa coltivazione della molteplicità, delle traiettorie che divergono da quelle comandate, dei luoghi di mediazione e scambio, delle sensibilità altre. Non è semplice: diventare refusenik della follia di questo mondo richiede applicazione cognitiva, fatica emotiva, il desiderio di strapparci alle passioni tristi e la possibilità di pensare noi stessi come molteplici, non-identitari, capaci di molti modi della coscienza, costruiti dalla qualità delle nostre relazioni. Niente che si possa fare da soli, insomma, ma molto più divertente che sprangarsi in casa (o nel lavoro, o nella militanza sacrificale, o nei confini della propria pelle).
PS Oltre che “guerra civile”, il greco /stasis/ significa “trovarsi nella posizione attesa; blocco; ristagno”; /ek-stasis/ può essere allora l’uscita dal blocco, l’andare oltre ciò che era previsto. Ci servirebbe, oggi, una politica dell’ek-stasis.
La prospettiva che delinei è interessante, Stefania, e l’uscita dal machomarxismo, come lo chiami, e dalle diarchie novecentesche mi sembra del tutto salutare. Purtroppo questo non elude il problema del potere. Sappiamo che il potere può declinarsi come relazione, sinergia, cooperazione, oppure come dominio. Spesso però il confine è labile, più teorico che pratico.
Ora può darsi che in quel pertugio, nel tentativo di tracciare quel limite, stia buona parte della fatica che ci tocca [N.B. sono uno che studia Tolkien da anni, le questioni che tu e Cristina sollevate sono centrali nella sua opera], ma cambiare l’essere umano storico, cambiare la mentalità e il modo di vivere gli uni con gli altri all’insegna del molteplice e del rispetto della diversità, è impresa che ha qualche chance soltanto se si accompagna a una trasformazione materiale (non si dà l’una cosa senza l’altra, diceva Bogdanov, e non c’è automatica inferenza, tocca lavorare su entrambi i fronti). E la trasformazione materiale presto o tardi si trova a cozzare con il potere come dominio, con il potere armato. Perché il capitalismo è tutt’altro che disarmato, insomma, e tutt’altro che disposto a lasciarti vivere al di fuori di certe dinamiche se questo lo mette in discussione radicalmente.
Questo per dire che il machomarxismo non è che la degenerazione di quell’idea della presa del Palazzo che significò provare a dare continuità e incisività a una società diversa, anziché essere il bellissimo fuoco d’artificio di una stagione. Perché il falansterio e la comune non solo non bastavano, ma non erano e non sono abbastanza resistenti contro il dominio del capitale. La risposta “sovietica” è abbastanza resistente, ma finisce per ritrovarsi prigioniera delle logiche del dominio e poi di nuovo del capitale (Bogdanov l’aveva previsto, ma a essere profeti di sventura siamo bravi tutti). C’è del buono da salvare in entrambe le prospettive, credo. Quanto al conciliarle, davvero non so, mi viene in mente solo dell’ottima narrativa di fantascienza (l’anarco-femminista Le Guin, guarda caso, che però sapeva non essere utopistica).
Insomma bisogna capire – e questo è il dilemma che ci lascia intatto la modernità fin dal suo inizio, fin dalla mancata rivoluzione dei contadini in Germania nel 1525 – se possiamo sfuggire al doppio destino “cristiano” del martirio (che nella religione rivelata funziona perché rimanda a sua volta al destino ultimo ultraterreno), quello di padre Gabriel e padre Rodrigo, i due gesuiti di “The Mission”, il non violento che rinuncia al potere, e il “teologo della liberazione” che si fa guerrigliero e impugna la spada. Muiono entrambi, sopravvivono i loro “figli” nella giungla. Compatto è il potere di fronte a quei due: è quello della modernità capitalistica, appunto, che spazza via ogni fede, ogni cultura precedente, per imporre il commercio e l’unica razionalità possibile, quella dei buoni affari.
Se dunque non siamo così ingenui da pensare che questo moloch ci lasci disertare le sue file a nostro piacimento per andare a costruire altro, allora dobbiamo anche sapere che sempre correremo il rischio di “corromperci” (per dirla con Tolkien), o, come dice gilgalad (non quello di Tolkien, ma il commentatore qui nel thread), di sporcarci le mani con il potere. E questo a mio avviso rimane anche il punto a favore di Marx rispetto alla prospettiva propriamente anarchica o di certo femminismo, che continua a suonarmi insufficiente. Non lo so davvero come si esce da dilemma, che più invecchio più mi sembra connaturato alla condizione umana.
@SteCon @Wuming4: bellissimi questi ultimi interventi su una questione che mi é sempre stata a cuore, cioé la posizione che si dovrebbe avere nei riguardi del potere/sistema. Il dilemma, quello tra “prendere le distanze” o “sporcarsi le mani”, ben delineato nelle due figure del film “Mission” e in tutta l´opera di Tolkien (di cui sono anche io un grande ammiratore). In Tolkien soprattutto mi é sempre parso, ma correggimi se sbaglio Wuming4, che le due posizioni in qualche modo siano entrambe presenti: alcuni personaggi contribuiscono perché si avvicinano al potere (l´Anello), ma altri invece contribuiscono proprio perché “rinunciano”, come Galadriel quando le viene offerto l´Anello. Preferisce non avere contiguitá diretta col potere sapendo che nelle sue mani diventerebbe un potere devastante e terribile. Forse la posizione di Tolkien é una sorta di via di mezzo dove una profonda sagezza dovrebbe guidarci quando e dove e come avvicinarci al potere, tenendo anche conto del fatto che almeno lui credeva in una qualche divina provvidenza che avrebbe, in qualche modo, guidato dall´alto.
Personalmente sono generalmente un inguaribile ottimista, ma ho il timore che il sistema capitalistico crollerá, ad un certo punto, di suo semplicemente perché alla fine innescherá una qualche crisi (sociale/ambientale/politica) cosí profonda e completa da inceppare perfino se stesso. E quel periodo non sará affatto un bel vivere: il sistema non se ne andrá senza scalciare e mordere e bruciare. Toccherá poi alle generazioni successive raccogliere i pezzi.
Che poi, come si diceva, il problema non è tanto “il potere”. Il potere entra in gioco in qualunque relazione – persino nella cura, nell’amicizia, nella complicità. Il problema è quando tutto il potere sta da una parte, e sempre da quella. Non si muove mai, i ruoli sono fissi, predeterminati, a priori – magari stabiliti in base al genere, alla razza, alla classe. Non c’è gioco – in entrambi i sensi del termine. Se invece il potere gira, danza, come in un trescone di fine estate, come quando i bambini si tirano la palla pensando che scotti, allora è un potere molteplice, moltiplicato, meno dannoso.
Che poi forse è proprio quello che fa Galadriel. Galadriel ha il potere, che prende forma materiale nel suo anello di diamante; ha il potere di chiudere la porta e tenere l’Occhio fuori dalla sua terra, sorvegliandolo. Non mi è mai stato chiarissimo il modo né in cosa consista, ma direi che ha il potere anche di tenere viva una terra e una gente sovrumana in condizioni del tutto particolari.
Condivide questo tipo di potere con gli altri due “portatori” dei Tre (non ricordo se Tolkien li accomuni in una definizione e quale, “portatore” è soprattutto Frodo) Elrond, che ha una funzione molto simile alla sua ma essendo anche in parte uomo è più aperto al mondo degli uomini, e Gandalf che tira insieme le fila dei vari mondi coi suoi fuochi d’artificio. Gandalf è infatti eternamente mobile, mentre gli altri due non lo sono: sono poli di attrazione di genti e compagnie, meta o luogo di passaggio; ma quando si mettono in moto è per abbandonare la Terra e la propria era.
Galadriel e Gandalf si rifiutano entrambi di rompere questo equilibrio collettivo di poteri accettando l’unico (anche se si dice che Vilya – credo – è il più potente dei Tre, cosa peraltro non spiegata bene).
Mi piace molto questo filone del discorso e apprezzo tutti i contributi che sono arrivati.
Non è cerchiobottismo, è che secondo me gli interventi di Stecon e WM4 sono su piani differenti.
Per formare qualunque nuova società è necessario prima di tutto immaginarla, renderla possibile e desiderabile, prima di tutto sul piano della visione e della immaginazione.
E i 2 commenti sopra di SteCon vanno in quella direzione: a me che sono totalmente digiuno anche delle più elementari basi di filosofia (e che sono un lettore molto pigro, quando si fa sul serio), permettono di immaginare (intravedere, fra le nebbie) un futuro fra quelli possibili che è desiderabile, in mezzo a un infinito ventaglio di futuri uno più distopico dell’altro, come quello dell’individualismo del perfetto consumatore nella matrix capitalista o quello della collettività tipo Borg (importantissime le riflessioni sull’Uno e il Noi che state facendo).
Il fatto è che poi, per portare l’immaginato nel reale, è nel reale che bisogna agire, e ogni scelta che facciamo ogni volta che “agiamo” sul mondo reale si prospetta spesso come “binaria”, duale, o di qua o di là, quindi per seguire la strada più stretta, il “pertugio” di cui parla WM4, bisogna pensare ogni scelta momento per momento, perché quello che va nella direzione giusta oggi non è detto che sia giusto anche domani. Bellisimo l’esempio di WM4 sugli ingegneri britannici che lavorarono agli spitfire: se dall’altra parte c’è il nazismo, limitarsi a spegnere gli incendi a Londra è utile ma non sufficiente, perché se nessuno costruisce gli spitfire, la battaglia d’inghilterra la vincono i nazisti Ma questo è vero solo in “quel” momento.
Il problema è se arrivi al punto in cui si è trovata Galadriel, per restare nell’esempio di Alessio, quando anche la scelta giusta è comunque perdente, nel senso sia che comporta una perdita e sia che, “da sola” non salva il mondo: da quando Galadriel ha rinunciato all’idea di tenere l’anello e diventare un “signore oscuro gentile” a quando l’anello è stato distrutto, molti altri hanno dovuto fare scelte determinanti e se anche una sola di quelle scelte fosse andata nella direzione sbagliata la rinuncia di Galadriel sarebbe stata non solo inutile, ma forse persino dannosa.
Domanda: e se invece la cifra delle società capitalistiche avanzate non fosse la sussunzione nell’uno, ma proprio la capacità di “mettere a servizio”, sia pure in un contesto sempre più precario e sfilacciato, proprio la proliferazione dei molti? E’ un aspetto (e forse quello fondamentale) della discontinuità che ho sostenuto qualche commento sopra.
In quest’ottica, ad esempio, uno strumento di analisi molto utile per immaginare delle forme di resistenza (e anche, perché no, di contro-potere) diventa quello dell’intersezionalità. E’ proprio perché i dispositivi capitalistici sono diventati sempre più abili nell’intrufolarsi nelle innumerevoli pieghe e fratture di una società complessa che, per restare all’immagine usata da Kimberlé Crenshaw per illustrare il concetto, l’impatto dell’automobile all’incrocio può arrivare da più direzioni, per cui diventa sempre più difficile ridurre l’ingiustizia sociale e lo sfruttamento a qualcosa che agisce lungo una direttrice unica, facilmente identificabile e quindi anche più facilmente contrastabile.
Il “machomarxismo”, tra parentesi, rigetta l’instersezionalità proprio perché la pensa come “rivale” dell’approccio di classe… quando invece, per come almeno la capisco io, è solo una riformulazione più “sottile” dell’approccio di classe!
Ciao Stefania, ciò che dici suscita in me una tempesta concettuale. Anche emozionale naturalmente. Vado subito al nocciolo: io so ragionare solo in termini teoretici, cioè usando i termini nel modo più universale possibile, radicalizzandoli per vedere meglio le contraddizioni insite inevitabilmente nelle composizioni che opero. Allora, il problema io lo chiamo “riduzionismo”: per ragioni di opportunità si riduce il fenomeno a quegli aspetti che si possono controllare, negando la presenza degli altri aspetti solo perché risultano ingestibili, o perché non si vedono (il paradigma di ciò è la scienza empirica). Ora, quando noi subiamo il fenomeno ridotto, ce la prendiamo con il concetto da cui proviene la riduzione. Nel nostro caso il problema non è l’”uno”, senza il quale non si potrebbe pensare, ma le “unificazioni”, che non sono la stessa cosa. Le unificazioni fanno uso dell’uno ma non sono l’uno, diciamo che impongono un ordine unitario, ma sempre insufficiente. Le unificazioni sono atti violenti. Per usare un altro linguaggio, la riduzione comporta la traduzione sempre infelice della struttura a funzione. Ciò che siamo a ciò che facciamo, per dirla brutalmente. Il problema è serio: noi dell’uno non possiamo avere esperienza, possiamo avere esperienza solo delle unificazioni, ma l’uno non è l’unificazione, sebbene senza uno non si possa unificare. Non vi è un Uno a cui si contrappone un altro Uno. L’uno è uno, vi sono unificazioni che si contrappongono, ma sono tutte negative non in quanto uno ma in quanto unificazioni.
Come si fa allora per mantenere un uno che non unifichi? Io non lo so, riesco a pensare solo ad un caso esemplare, il “noi”: nel noi c’è l’io, che è l’uno del noi, che non esclude e non comprime i molti, ma li valorizza. Nel noi gli altri non mi limitano, ma mi completano. Dove si costituisce un noi, lì abbiamo l’unico caso non di esperienza diretta ma di presenza dell’uno. Allora, cosa possiamo fare? Costruire esperienze in cui si costituisce un autentico noi. Semplice? No, perché il problema si ripropone, il noi non può essere imposto, anche il noi si presenta come fosse un autentico noi ma è una imposizione. Ci abbandoniamo ad un fatalismo della storia? La tentazione è forte, un po’ come il gaberiano “mi ritirerò in campagna”. Ma così facendo abbandoniamo i giovani a se stessi. Sarebbe una cosa infame. Ci tocca stare qui a trovare una soluzione.
Però, mannaggia, c’è pure il “noi” dell’Inno nazionale, il terribile “Canto degli Italiani”: “Noi fummo da sempre calpesti e derisi”. Perché bisogna anche guardare a come si mette insieme quel “noi”. Se lo si mette insieme con tante congiunzioni (“tu e tu e tu e tu” – una somma di individui) oppure con una preposizione (tu con tu con tu – un con-dividuo). Si può stare insieme senza appartenere? Oppure “appartenere” è un bisogno irrinunciabile? Nella gerarchia dei bisogni di Maslow, al terzo livello c’è il “social belonging”. Io a quella gerarchia ci credo poco, ma vabbe’, la domanda resta: possiamo prenderci cura di una terra, senza essere “di” quella terra, senza che quella terra sia nostra, “di” noi, ma – sempre giocando con le preposizioni – abitando in quella terra, vivendo con lei?
Wu Ming 2 hai totalmente ragione, infatti io me l’ero cavato con un “autentico noi”, contro i noi apparenti, e pensavo proprio ai noi retorici delle feste della repubblica o simili. Non c’è infatti un termine per poter indicare quell’unità che è armonia e non compressione dei molti, quell’unità in cui i singoli molteplici trovano la propria identità non nella propria differenza ma nell’universalità del senso. Mi posso aiutare con la musica: un accordo, io amo il mi minore visto che sono un chitarrista scarso: nel mi minore vi è armonia di molte note ma è uno solo, ma è anche molti.
Conosco un chitarrista molto bravo che a volte suona accordi meravigliosi. Tu gli chiedi: “Quello cos’era?”. Lui prova a risponderti, comincia a dirti che è un Re7, però diminuito, e poi ci ha aggiunto una quinta, senza contare che stava suonando con un’accordatura aperta… E alla fine anche lui si arrende, ti dice “Boh, è fatto così”, ti mostra le dita sulle corde. Suona bene, ci sta benissimo nel pezzo, ma non ha nemmeno un nome.
Qui, in questo che dici, c’è una chiave importante: il nostro dare nomi, conoscere, determinare tutto è un atto di dominio, di volontà di potenza, di controllo, io voglio incartare quell’accordo in un nome, nome che non è solo un nome, ma è un introdurre in un sistema di riferimento, che mi precede, che mi domina. Ecco allora l’atto libero: è così, non ha nome.
Uno degli ultimi libri di Melandri si intitola Contro il simbolico. Cos’è sto simbolico contro cui dobbiamo andare? questo, il nostro voler dominare l’altro determinandolo. A cui si aggiunge il drammatico credere che in effetti noi si domini tutto.
Un intellettuale martinicano, Eduard Glissant, parla di “diritto all’opacità”. Sostiene che in una relazione sana dovremmo concedere all’altro di essere opaco, non del tutto trasparente al nostro sguardo. Noi di solito, per descrivere un rapporto ideale con un’altra persona diciamo che “ci capiamo al volo”, e pensiamo che “non capirsi del tutto” sia un ostacolo alla relazione. Invece Glissant dice che si può stare insieme – si deve stare insieme – anche se l’altro non ci è trasparente, e rinunciando a renderlo tale, accettando l’opacità – che non è un muro, ma uno schermo dietro al quale filtra pur sempre qualcosa, ma non in maniera nitida, precisa e quindi: controllabile.
Scusate se entro un po’ bruscamente, ma su questo argomento mi sento di consigliare ‘La società della trasparenza’ di Byung Chul Han, filosofo di origini sud coreane, ma di formazione e lingua tedesca.
Detto questo, articolo di grande spessore. Complimenti alle autrici e ai WM per portare sempre più in alto il livello di analisi di questo (assurdo e schizogeno) momento della nostra storia. Vorrei intervenire più spesso, ma per dare un contributo significativo a certe discussioni ci vuole tempo, concentrazione ed energie che di rado trovo tutte in contemporanea.
Inutile fare l’elenco dei nomi: il ringraziamento va a tutti, l’insieme di questi post è come una mappa parziale, o una vecchia pergamena con isole di bianco in mezzo al testo rimasto.
Aggiungo qualcosa su un brevissimo passaggio di WM4 che, in chiusura del post sull’alternativa fra stare fuori dai giochi e sporcarsi le mani con il potere, scrive: “più invecchio più mi sembra connaturato alla condizione umana”. Per nitore di linguaggio, cambierei “potere” con “dominio” (v. post successivo di WM2 sul perché di questa scelta). Ma, soprattutto, m’interrogo su quel “connaturato”.
Purtroppo per noi, il potere diventa dominio molto spesso. Anzi, quasi sempre, e perciò la scelta fra sottrarsi e isolarsi può sembrare, a un certo punto, connaturata alla condizione umana. Ma ci sono eccezioni: le società senza stato descritte da Clastres; le società non-patriarcali; certi momenti storici di autonomia delle collettività; certi movimenti ereticali ecc. Non è vero che son durate poco – ma indubbiamente sono “ecologie umane” che richiedono intelligenza, attenzione e sensibilità, e sono quindi più delicate rispetto a formazioni sociali fatte apposta per essere dure e distruttive. Se di solito le ignoriamo, è perché, per via dello storicismo progressista, tendiamo a pensare che la ragione sia sempre e solo del vincitore, di quello che le ha suonate più forte (come se, a una pentolaccia, proclamassimo reginetta della festa la bambina prepotente che si è accaparrata tutte le caramelle a suon di calci e pugni).
Poi potremmo interrogarci sulle pratiche di “igiene del potere” che evitano la sua calcificazione in dominio. Qui c’è l’imbarazzo della scelta: dai meccanismi decisionali della tradizione anarchica alla pratica delle antiche virtù (che guarda caso cominciano a essere sbeffeggiate proprio all’inizio della modernità, con la Favola delle api di Mandeville); dall’accettazione dell’opacità, dell’equivoco e dell’incertezza che qualsiasi “altro” porta con sé al misurarsi con la finitudine dei nostri corpi e delle nostre vite (qui i transiti in stati non ordinari aiutano); da una ripresa di contatto con le intenzionalità non umane (i maiali in allevamento intensivo saranno contenti di vivere così? che fine ha fatto il genius loci dei romani?) fino all’esplorazione della “zona d’ombra” che permane, non conoscibile, al di sotto del mondo culturale in luce.
Perché alla fine il dominio che avversiamo è fatto di umani – e cioè, spesso, è fatto anche di noi, del nostro chiudere gli occhi sulla violenza strutturale e sui trucchetti con cui ci cattura. Più ci sottraiamo alla sua presa, meno è potente. Esempio un po’ estremo, ma chiaro: i soldi (oggetti magici per eccellenza, enti inanimati capaci di trasformarsi in qualsiasi altra cosa e che, al chiuso dei caveaux delle banche, si riproducono come se fossero vivi…) funzionano perché e fintantoché /tutti/ ci crediamo. Se smettessimo di crederci, li vedremmo per quel che sono: pezzi di carta.
Forse il miglior trucco del dominio è quello di averci convinti della sua inevitabilità.
Stefania, tutto giusto per me. Mi interrogavo su come la mettiamo quando ci spareranno addosso. Perché nel momento in cui chi è devoto al dominio dovesse sentirsi minacciato da una diserzione di massa dalla sua stessa credenza, questo farà: sparerà a vista, temo. E il dilemma tra la scelta di padre Gabriel e quella di padre Rodrigo ci si riproporrà. Nella consapevolezza che non ce n’è una giusta e una sbagliata e che alla fine muoiono entrambi. Sopravvivono i bambini nel profondo della foresta. Finché ci riusciranno… Ciò che percepisco come ineluttabile non è il dominio, ma il conflitto con il dominio. Lo so che è una partita che si vince soltando se si è capaci di rinunciarci, di decontaminarsi, di gettare via lo strumento del dominio che ci portiamo dietro. Sono partito citando la storia di un gruppo di persone diverse (9) che devono fare proprio questo. Ma sai quanta legna devono fare per riuscirci…E intanto Sauron non sta a guardare.
La terribile questione della violenza, se farla o subirla…
Quando ci spareranno addosso, combatteremo. Il punto è come.
Se ci fosse da combattere, vorrei farlo da viva e non da mezza morta. E cioè: non vorrei farlo per conservare quel che resta della mia sopravvivenza, ma per proteggere un modo collettivo di stare al mondo, un “buon vivir” condiviso. Il che significa aver già intessuto un insieme di relazioni che rendono bella e sensata la vita, essere già /kin/ (“fatti della stessa sostanza”) di altri – e questo va fatto subito.
Poi, se ci fosse da combattere, vorrei farlo in modo non mimetico e non speculare. Una lotta non mimetica può sperimentare molte vie: l’ironia, la “non-violenza militante”, l’interposizione, la costruzione di miti, l’arte dello stupore, il sabotaggio dei dispositivi di tristezza. La forza che toglie il dominio non è la stessa cosa della violenza che lo instaura – ma è vero che il confine fra le due è sottilissimo e il risentimento è il peggior consigliere.
Ancora: un combattimento “percorribile” eviterebbe di disumanizzare gli umani, inclusi gli avversari. I galoppini che esercitano violenza per conto degli Stati e dei para-Stati sono stati lungamente costruiti per poter fare lo sporco lavoro. Prima di poterla infliggere, hanno dovuto subire violenza. Come noi, hanno paura. A volte sono disperati e, a un certo punto, potrebbero decidere per la diserzione. Il “male assoluto” (ab-solutus: sciolto da ogni legame, non storico, non contattabile) non esiste: esistono umani intrappolati in storie dell’orrore.
Un sacco di legna da fare, hai ragione WM4. Ma è ben possibile che sia proprio la nostra strutturazione come individui (e quindi come padroni, disabituati alla fatica e alla perseveranza, avvezzi solo alle /facilities/) a renderci così ingrato il pensiero che, a questo mondo, c’è da far legna. Ci servirebbe una vera e propria nuova educazione sentimentale collettiva.
@SteCon: beh dopo il tuo esempio sui soldi non possiamo non citare l´incipit dell´intramontabile Guida Galattica di Adams:
“Lontano, nei dimenticati spazi non segnati nelle carte geografiche dell’estremo limite della Spirale Ovest della Galassia, c’è un piccolo e insignificante sole giallo. A orbitare intorno a esso, alla distanza di centoquarantanove milioni di chilometri, c’è un piccolo, trascurabilissimo pianeta azzurro-verde, le cui forme di vita, discendenti dalle scimmie, sono così incredibilmente primitive che credono ancora che gli orologi da polso digitali siano un’ottima invenzione.
Questo pianeta ha, o meglio aveva, un fondamentale problema: la maggior parte dei suoi abitanti era afflitta da una quasi costante infelicità. Per risolvere il problema di questa infelicità furono suggerite varie proposte, ma queste perlopiù concernevano lo scambio continuo di pezzetti di carta verde, un fatto indubbiamente strano, visto che a essere infelici non erano i pezzetti di carta verde, ma gli abitanti del pianeta.”
Grazie per il contributo profondo, denso, chiaro e illuminante. Grazie perché nel dibattito è stata anche chiarita la profonda differenza fra marginale e minoritario. Vorrei collegarmi al discorso di Nene sul linguaggio per dire che ogni messaggio scaturisce dalla volontà di farsi ascoltare unita a quella di voler comprendere, e viceversa se il mezzo lo prevede. Ma c’è un altro tema, ed è l’interlocutore assente. C’è l’intendo di dialogare anche con l’Assurdisatan o l’analisi serve a dimostrare quanto “siamo” più sapienti e nel giusto?
Questa eccellente costruzione ricostruzione del come siamo arrivati fin qui, rischia di essere uno stupendo vertiginoso castello di carte se posta in relazione allo schiacciasassi dell’Assurdistan, non-destinatario del post.
Ieri e oggi, nonostante l’intento d’evitarlo, sono incappato nelle farneticazioni rabbiose del bambinello toscano, che pretende di essere posto al centro della mangiatoia. Duecento e più miliardi –da cosa sia stata determinata questa cifra è un mistero indecente– provocano l’azzannarsi dei cani alla ricerca delle briciole e degli avanzi, sotto il tavolo del banchetto della finanza, come i cani nei dipinti di Pietro della Francesca. È già accaduto coi terremoti e con ogni altro provvidenziale disastro. Gli scienziati usano il metodo scientifico, forse, fin quanto si occupano di scienza, ma quando siedono o presiedono i consigli d’amministrazione della clinica di Don Raffaè, rigettano ogni metodo e entrano nella logica della Pandemenza finanziaria, con quello che ne consegue.
Ed ecco come siamo arrivati sin qui, e anche dove andremo a finire: siamo solo agli inizi.
Azz! Scusatemi, sono riuscito a piazzare quattro strafalcioni in tre parole. A perdersi a contare le battute può succedere. Ciò che si è analizzata, a mio parere è l’economia dei disastri. Meccanismo perverso che riesce a trasformare l’incidente pandemico in accumulo di capitale per pochi, a scapito dei marginali maggioritari. La stessa pandemia è una conseguenza probabile di un disastro ben maggiore che è la devastazione ambientale, in Europa derubricata a clima.
E, però, questa eccellente analisi sulla quale siamo tutti concordi, in che misura è capace d’incidere sull’Assurdistan planetario? Zero?
Io credo che il machomarxismo di cui ha parlato Stefania sia un atteggiamento molto diffuso ed, in primo luogo, una posa di cui, per giunta, ci si compiace a sinistra. Forse non si può affrontare un cambiamento senza una rivoluzione, forse la rivoluzione deve passare attraverso un atto di forza ma proprio qui, in questo luogo simbolico, mi viene in mente che la potenza/ forza americana è stata annientata dall’intelligenza strategica di un popolo nettamente più debole. Intelligenza vuole che rispondere alla forza solo con la forza sia una strategia perdente. La vittoria però non è soltanto una questione strategica ma, principalmente, culturale e poggia le sue basi sulla “conversione” culturale di un sistema patriarcale di violenza e sfruttamento. A questo proposito mi viene in mente il romanzo di Coetzee ” Digrace”. Mi aveva colpito molto che a scriverlo fosse proprio un uomo, spettatore impotente di una violenza patriarcale, coloniale, classista che ad un certo punto travolge lui e la sua famiglia. È una storia che ha molto da dire su come le donne vogliono opporsi e rielaborare la violenza del sistema. È una storia scioccante per come la protagonista decide di reagire alla violenza. È un libro che continua a tormentarmi.
Vorrei ringraziare anch’io le autrici, per averci offerto la possibilità di far emergere al livello della consapevolezza certe intuizioni e inquietudini.
Vorrei fare una domanda a tutta la comunità di Giap a proposito di quanto segue:
“Ci sono, per cominciare, una miriade di questioni politiche immediate su cui si sono mobilitati i diversi gruppi dell’attivismo nazionale, che da mesi discutono, si confrontano e avanzano proposte perfettamente sensate per intervenire sulla crisi (…) in modo da ridurre collettivamente il rischio del virus senza trasformarci individualmente in zombie terrorizzati e terrorizzanti.
(…)A fronte dell’isteria maggioritaria, gli altri, quelli che sentivano il mondo in un’altra maniera, dapprima si sono sentiti pazzi. Poi hanno cominciato, ciascuno a suo modo, a reagire.”
Conoscete qualcuno di questi gruppi? Qualche associazione che non si sia piegata ad angolo retto alla narrativa dominante? Preferibilmente a Milano. E’ una domanda serissima, perché vorrei davvero uscire dalla solitudine del sentirmi l’unica pazza che si sgola contro il vento e cominciare a fare qualcosa, o almeno a provarci. Grazie di cuore.
Le uniche forme poderose di reazione che si sono viste a Bologna, sono state quelle di Black lives matter e quelle dei riders che, per questioni logistico/ organizzative, non hanno mai abbandonato il campo. Nessuno dei due movimenti ha però espresso una critica esplicita alla gestione della pandemia. L’urgenza che hanno comunicato era precedente alla vicenda pandemica ma il modo in cui si sono espressi era, nei fatti, una sfida all’ordine imposto. La differenza consistente tra i due movimenti riguardava il tipo di narrazione, auto narrazione, prodotta. Black lives matter ha introdotto una modalità narrativa “sconosciuta” nel nostro emisfero politico italiano: il canto della sofferenza come momento di catarsi e partecipazione collettiva. Un modo “nuovo” ed empatico di trasmettere i contenuti politici, di comunicare le coordinate esistenziali di una condizione umana. Qualcosa che uno sprezzante cinismo politico ed uno spietato realismo ci impediscono di fare, pena la derisione. La giovanissima età dei partecipanti ha, credo, influito sulla comunicazione, rendendola più spontanea, più ingenua e più vera. Altro di significativo in termini numerici purtroppo, qui a Bologna, non ho visto.
Grazie per la risposta, Filo a piombo. Sì, entrambe possono essere viste come forme di reazione indiretta alla gestione della pandemia: i rider hanno continuato a lavorare sempre e comunque, quindi sono un perfetto esempio dello “stare in casa” forzato senza però “stare a casa” dal lavoro, mentre Black lives matter ha funzionato per certi versi anche come grido di vita contro l’ondata di morte non solo fisica, ma peggio interiore e sociale. Spero che altrove siano emerse forme di protesta più mirate, ma non so più dove cercare, davvero. Associazioni che conosco si sono adeguate senza fiatare a ogni imposizione e, quando ho provato a sollevare obiezioni, non hanno voluto prenderle in considerazione. Come tanti, ho dato una mano con spese a domicilio, pacchi alimentari e pasti pronti, ma più di quello non ho trovato, in giro per Milano. Ci sarà qualche voce critica, da qualche parte?
Grazie alle autrici per la risposta, apprezzo molto l’adozione del metodo femminista! E grazie anche alle altre persone che hanno mostrato interesse per questo tema e hanno condiviso le proprie riflessioni.
Certamente il mondo è molto complesso e non è proprio possibile semplificarne la lettura, questo post parla di “strutture” che hanno millenni di storia alle spalle, per decodificare il senso di alcune dinamiche è necessario ricorrere a concetti complessi.
Che cosa “debba” fare un saggio non lo stabilisco di certo io, lo stabilisce chi lo scrive, io mi sono limitata a porre delle domande.
Non sono d’accordo però che non sia possibile tradurre un testo saggistico in un linguaggio più semplice: se è vero che per ragionare intorno ad un problema sanitario come un virus, mi servono due concetti difficili come “letalità” e “mortalità”, è anche vero che per renderli chiari è sufficiente fare un esempio numerico. In un testo complesso di cui riesco a capire solo una parte, la semplice presenza di esempi mi può restituire degli spunti di riflessione cui mai avevo pensato o addirittura una visione d’insieme, perché il capitalismo, il suprematismo bianco e il patriarcato sono esperienza quotidiana condivisa per un sacco di persone (esistono nella pancia prima ancora che da qualsiasi altra parte).
Avere tempo da dedicare allo studio è un privilegio di cui godiamo proprio in pochx, il tempo della maggior parte delle persone non vale niente sul “mercato” e quindi moltx devono investirlo prevalentemente nell’obiettivo di garantirsi una sopravvivenza.
Dal mio punto di vista le persone istruite che si pongono come obiettivo quello di “cercare di rendere comprensibile ciò che è intrinsecamente complesso” stanno facendo una cosa molto potente: stanno rompendo una barriera millenaria che, nonostante l’esistenza dell’istruzione “pubblica”, è tutt’ora di “classe” – che è stata anche istituzionalmente vietata in base a genere ed “etnia” – e che punta in modo sistematico ad impoverire materialmente una botta di persone e contestualmente ad escluderle dalla possibilità di capire il mondo e quindi il proprio malessere e quindi, caso mai, a canalizzare la propria la rabbia.
Per me che leggo stanno facendo una cosa ancora più potente: stanno scegliendo di condividere in qualche modo questa forma di “capitale” invece di avvantaggiarsene, mi stanno dicendo che sono mie alleate anche se non ci siamo neanche mai conosciute. Internet è potente anche in questo senso (non solo in senso distruttivo), ma mi rendo perfettamente conto che è una forma di cura che ha effetti non visibili nell’immediato per chi sceglie di adottarla perché è una relazione virtuale appunto (da cosa nasce cosa diceva mia nonna).
Il movimento notav è diventato potente anche per questo: moltx tecnicx invece di vendere le proprie prestazioni a caro prezzo alle società criminali di turno, hanno investito energia, tempo e cura per spiegare cosa significasse questo treno in teoria e in pratica (semplificare per restituire la complessità dei problemi), organizzando per decine di anni incontri che sono serviti a moltx per capire; altrx non hanno capito niente magari sul piano “tecnico” che le cose alcunx le capiscono per altre strade, però di sicuro tuttx partecipando hanno constatato la nascita e il continuo ampliamento di una rete, hanno riconosciuto persone alleate anche con tutte le diversità del caso e tuttx ci siamo sentitx più forti rispetto alla capacità di affrontare questa e altre forme di violenza istituzionale che sarebbero seguite. Di queste cose avremmo tuttx grande bisogno ora.
È stato istituito un nuovo dispositivo di detenzione per le persone migranti, la “nave quarantena”, ed è stata istituzionalizzata una nuova forma di detenzione domiciliare, quella per motivi sanitari (non più solo come alternativa al carcere per “estinguere” certi tipi di “reati”) e le biblioteche di Torino hanno chiesto al Prefetto se possono riattivare i servizi di prestito libri e potrei andare avanti un po’ ma mi è già venuta l’ansia. Se non ci diamo collettivamente degli strumenti per ragionare viene fuori un grande pasticcio in cui non si riesce più a capire dove sta il confine fra un grave problema sanitario e l’imposizione di misure fasciste.
Grazie a tuttx quellx che vorranno provare ad accogliere questa sfida!
@ alessio: grazie di aver incollato la citazione, non me la ricordavo più! (Il che è grave perché la Guida Galattica è una delle pietre angolari della mia formazione.)
@ fvacc: a Genova i luoghi – materiali e immateriali – di queste elaborazioni sono la Libera Collina di Castello e la rete “È già settembre” (entrambe hanno una pagina fb). Di Milano non so molto, salvo che la Calusca ha appena pubblicato con Colibrì uno smilzo libretto, preciso ed efficace, intitolato “Lo spillover del profitto”.
@ arocle: v. ultimi post di Nene.
@ Nene: grazie davvero di aver aperto la questione: l’accessibilità delle analisi resterà per me, di qui in avanti, un “pensiero attivo” (tanto più che l’università dove lavoro continua, e continuerà, a tener chiuse le aule, il che significa che uno dei luoghi dove il “bene comune” del pensiero critico poteva essere messo in circolazione, condiviso e diventare collettivo, non esiste più e bisogna inventarne altri).
Buongiorno a tutte,
Ho letto e riletto l’articolo e i relativi commenti. Colgo l’occasione per ringraziare le autrici, i curatori del blog e i commentatori. Tutto chiaro e tutto condivisibile, a parte un paio di quelli che mi son sembrati refusi (uno mi viene in mente “sovrani di stessi” per “sovrani di se stessi”?). Mi sembra che l’articolo muove sul solco della tradizione critica di questo blog, critica del reale che è fondamentale per ogni possibile azione. Quello che sento di aggiungere, anche leggendo i commenti più recenti, muove dalla teoria verso la pratica. Ovvero essendo il capitalismo agito essenzialmente dagli umani, allora tramite un lavoro sugli umani si può smuovere questo ordine di cose. Ovvero finchè non ci mettiamo alla prova il dubbio rimane, il dubbio che davvero questo è il migliore dei mondi possibili (e oltre al dubbio la certezza, perchè è l’unico). Se da quanto, 3 secoli? il capitalismo ha vissuto una irrefrenabile ascesa, avrà almeno avuto i suoi meriti, no? Saluti
Il sistema industriale e il soggiacente sistema dell’economia di mercato hanno prodotto una condizione di benessere e di produzione e possesso di oggetti che mai prima, nell’intera storia dell’umanità, si è verificata. La necessità deriva dalla disponibilità degli oggetti, senza i quali non si avrebbe neppure coscienza del desiderio. Gli artefatti sono pensati come merci per lo scambio, e sono l’esito di un duro lavoro di costruzione di senso e di stabilizzazione della realtà.
I desideri più inappagabili, egoistici e individuali hanno trovato nel paradigma del mercato la più ampia possibilità di soddisfazione. Con la conseguenza di determinare uno stato di acquiescenza, fornito dall’ultimo bisogno soddisfatto, sempre più breve ed effimero. L’economia fondata sullo sfruttamento dell’uomo e delle risorse prelevabili dall’ambiente, considerano queste ultime come semplicemente res nullius nella disponibilità di chi è capace di farne un qualche uso. Non serve far altro che prenderli e utilizzarli. Lo stesso vale per i quasi-oggetti biologici, gli artefatti ibridi derivati dalle colture e dagli allevamenti, che –uniti alle catene di trasformazione e distribuzione– ben poco hanno a che fare con le forme vegetali e animali da cui derivano. Allo stesso modo del prelievo, le eccedenze e gli scarti possono essere riversati nell’ambiente senza alcuna preoccupazione.
Sparita la fame, con la disposizione d’una quantità di cibo che mai riusciremo a consumare (non è fame, Ambrogio, è solo voglia di qualche cosa di buono…), tenuti al riparo dal caldo e dal freddo, liberi dalla fatica e dal dolore, dalle malattie –quelle fisiche, quelle mentali– curati e perennemente coccolati, cosa potremmo desiderare di più?
desiderare di più?
Non mancherà che il progresso trovi riparo alle piccole crepe, alle occasionali e rapidamente superabili pandemie globali. C’è chi non ancora ha accesso a questa fantastica condizione, ma basterà po’ di crescita in più e il gioco è fatto.
L’Economia Unica del Mondo, fonda il suo paradigma su un pianeta piatto e infinito, nel quale basta eseguire qualche buco qua e là, prendere cosa serve e, innanzi tutto, consumare sempre più.
Se si osserva la Rivoluzione Industriale si vede che le condizioni iniziali non sono dissimili da quelle finali: c’era il petrolio, c’è il petrolio; c’era il rame e il rame c’è ancora; l’acqua e l’aria sono più o meno limpide allo stesso modo. Sfioriamo l’interruttore e le lampadine si accendono.
A qualcuno sarà accaduto di finire la benzina prima di arrivare al distributore. Non è che l’auto inizia a rallentare quando restano gli ultimi trenta chilometri di autonomia. L’auto corre in modo proporzionale alla pressione sull’acceleratore sino all’ultima goccia di benzina. Poi, di colpo, si ferma.
Sappiamo, ormai da qualche generazione, che la terra non è piatta ma è tonda e finita e che le risorse sono in via di esaurimento. Dovremmo iniziare a rallentare, cercare di non sperperare carburante, e invece, ecco che pestiamo sull’acceleratore del suv sempre più energivoro ed inquinante. E siamo sempre in più a cercare di diventare consumatori. La tavola imbandita del banchetto del consumo è troppo attraente per starne distanti. Per di più, tanto maggiore è il numero dei commensali, tanta maggiore è la crescita dell’economia e l’accumulo di straordinaria ricchezza per pochi.
Ciao Arocle. Parto dal fondo del tuo intervento. Sembra che tu intenda che questo mondo potrebbe crollare da un momento all’altro a causa della scarsità delle risors. E’ dal 1970 che è stata predetta la fine imminente dei combustibili fossili, e hanno toppato clamorosamente. Con questo non voglio dire che non possa succedere, ma ugualmente si potrebbero ipotizzare un’infinità di cause per la distruzione del pianeta (dalla catastrofe nucleare all’asteroide).
Forse il ciclo del concetto che noi chiamiamo capitalismo non è ancora giunto al termine, e certo non saremo noi a poter abbattere un tale (almeno da come lo descrivi tu) mostro. Ciò non ci esime però dal criticare e di cercare di costruire un’alternativa. L’amicizia, la sincerità, la simpatia, non si possono comprare. Saluti
A novembre dello scorso anno, durante un seminario dedicato agli impiegati bancari di un grosso gruppo italiano del nord specializzati nelle relazioni con gli enti ecclesiastici e le associazioni del terzo settore, uno dei relatori, appartenente alla galassia di coloro che si occupano di “finanza sostenibile”, fa “il punto della situazione” mondiale in termini di risorse economiche e naturali. Devo dire in modo molto accurato. Ad un certo punto cita il Club di Roma e il “Rapporto sui limiti dello sviluppo”, commissionato al MIT dal club e pubblicato nel 1972. Il relatore sovrappose le curve della proiezione degli indicatori di sviluppo descritti nel Rapporto, alle curve che quegli stessi indicatori hanno effetivamente seguito in questi decenni. Erano quasi sovrapponibili. Le previsioni del rapporto individuano nella prima metà di questo secolo il punto di rottura definitivo della “crescita”. Uno dei partecipanti chiese preoccupato “è lì cosa succede?”. Confesso che sto vivendo le conseguenze economiche e sociali di questa pandemia completamente suggestionato da quell’episodio. Non conoscevo il Club di Roma, ne tanto meno le sue attività, e in una frettolosa ricerca non ho trovato grossi riscontri nelle analisi in cui mi sono imbattuto. Normalmente mi occupo di altro e le lacune in questo ambito sono sterminate. Mi rimetto quindi a chi ne sa di più.
Il pezzo di Stefania Consigliere e Cristina Zavaroni è davvero illuminante e pieno di spunti, quindi davvero grazie. La discussione che è seguita mi ha suggerito un’altra immagine. Il finale di Snowpiercer, quando un orso polare osserva i due superstiti del treno, una sorta di arca di Noè umana costretto a girare all’infinito su una Terra in piena glaciazione e fatto saltare in aria anarchicamente dopo una lotta di classe violentissima a bordo. Ci si salva soltanto scendendo dal treno. In un mare di neve bianca gli unici due superstiti sono una teenager asiatica e un bambino di origine africana.
Francamente, se da una parte sono contento di aver ricevuto dei commenti al mio commento, in questa contentezza non potrei essere più “dispiaciuto”. Nel senso, due commenti in calce al mio che apparentemente non rispondono a quello che ho scritto. Il senso? Posso fare mille ipotesi, ma in nessuna rientra un qualunque spirito di convivialità (ovvero di collaborazione, inclusione, apertura etc. etc.). Capisco la critica (che sia il più chiara possibile, sennò posso anche non capire); invece questa modalità mi rimane oscura. Può darsi sia colpa mia. In tal caso ragguagliatemi pure. Grazie.
La discussione si sta incartando. Invitiamo tutte e tutti a lasciare commenti che non si allontanino troppo dai focus tematici dell’articolo.
Lascio qui il mio contributo perche’ non trovo piu il pulsante ‘commenta’.
Ringrazio le autrici. Credo il pensiero laterale, la capacita’ di ricercare pattern tanto nel macro quanto nel micro ed il modo sottile in cui sono legati, sia uno strumento fondamentale per capire in che mari navighiamo e soprattutto dove stiamo andando.
Poiche’ reputo questo articolo una vera e propria mappa crono-culturale ho deciso (mi sono permesso) di farne una mappa concettuale (https://drive.google.com/file/d/1B0NHZds1Aec3qCTdC45czPA4jdMiNwA6/view?usp=sharing), in modo da srotolare su due dimensioni la miriade di concetti e connessioni contenuti che dopo piu riletture non sono riuscito a trangugiare in un solo sorso monodimensionale/verticale.
Il processo stesso di dedicare del tempo alla costruzione di questa mappa (mia figlia di 8 anni mi ha chiesto piu volte: ma perche’ lo fai se non e’ ‘lavoro’?) mi ha fatto riflettere su molte cose a contorno dell-articolo stesso.
Contribuire, lottare, condividere, partecipare (nell-articolo si fa giusto un accenno ai prossimi passi da muovere, una volta presa coscienza del filo rosso degli episodi precedenti) richiede tempo.
Dopo aver letto e riletto l-articolo durante la redazione della mappa concettuale ho letto anche tutti i commenti…. intanto sono passati una decina di giorni, altri tre o quattro post su giap, altri commenti…. piu tutto il mondo che continua a scorrere (a velocita’ molto piu elevata) fuori da giap…..
Il vortice di dati, conoscenze, novita’/falsita’, ha aumentato il suo raggio di azione e la sua velocita’ di avvolgimento, in linea con la voracita’ del *capitalismo che lo sottende…… mi sto allontanando troppo :)
“La stessa esistenza soggettiva diventa un bene espropriabile.”
In pratica esiste un fenomeno umano, perche’ dagli esseri umani implementato, molto complesso, di cui gli umani stessi non hanno pieno controllo (a meno di non finire in sdrucciolevoli tesi complottiste). Cio’ ricorda un po il legame tra macrobiota e singolo batterio, ma anche quello tra macrobiota ed esperienza del ‘se’. Ma qui pure finiamo fuori tema… non me ne vogliate
Parte II
Personalmente sono inciampato nel filo rosso dipinto nell-articolo qualche anno fa, quando si e’ deciso che il morbillo fosse una malattia mortale ed il suo debellamento una priorita’ non procrastinabile.
In quella occasione il sistema ha deciso di espropriare la pelle dei figli dalla sfera decisionale genitoriale, creando a riguardo un pensiero unico. Rimuovendo chiunque avesse il benche’ minimo dubbio marchiandolo indelebilmente come NOVAX, legato con una catena ai sostenitori delle scie chimiche e ai tanto citati terrapiattisti.
Eppure io NOVAX non sono. L-ultimo vaccino , contro la febbre gialla, l-ho fatto due anni fa prima di un viaggio in brasile. Ai miei figli ho fatto l-antitetanica a giugno prima di mandarli dalla citta’ alla montagna per un campo estivo.
Eppure l-idea che si volesse cancellare dalla faccia della terra un ‘male’ (non IL male) con tanta bramosia non supportata da statistiche mi ha fatto proprio pensare al capitalismo vorace che ha bisogno di nuovi spazi e non guarda in faccia a nessuno pur di colonizzare nuovi territori (non si tratta di complotti ma di mero business, in linea con l-ossessione dell-insostenibile crescita perpetua).
Rivedo quindi nelle ultime vicende dell-essere umano un riprodursi, a piu vasta scala, e con dinamiche senza precedenti (e senza possibilita’ di previsioni)di quello che ho vissuto negli ultimi anni (il mio dubbio sui vaccini e’ nato dopo una reazione avversa)e che trova una spiegazione proprio nel cammino da cui gia’ venivamo.
Al divide et impera gli alchimisti contrapponevano l-une et solve. Da ingegnere credo uno dei mali maggiori del nostro tempo, legato all-atomizzazione dell-individuo ed alla sua scarnificazione, sia l-approccio unicista preso da LA scienza e LA comunita scientifica, che non mi stanco mai di declinare al plurale.
Credo l-ultimo capitolo, il prender parte, sia il piu sfumato, per forza di cose.Sapevamo tutti che dove stavamo andando puzzava, ma almeno quella puzza la conoscevamo, adesso ci siamo dentro e l-odore e’ cambiato, e’ tutto buio, siamo SOLI.
Mi piace pensare che siamo SOLI che possano mutualmente scaldarsi, forse solo la rilettura di kropotkin puo salvarci, l-agognata implementazione di una salvevole anarchia basata sulla condivisione, in contrapposizione all-accumulo. In questo senso ogni singolo passo, per quanto piccolo, mosso verso la comunita’ e non l-individualita’, sara’ un atto di lotta.
Io però continuo a non capire come sia possibile, con tutti i crimini veri che il capitalismo compie ogni secondo, ritenere il vaccino contro il morbillo l’abominio descritto da chi lo critica. Il morbillo è contagiosissimo – ha un valore di R0 che va da 12 a 18 –, può causare complicazioni respiratorie e gravi encefaliti, e in occidente, prima delle vaccinazioni, aveva una letalità di tutto rispetto. In molti paesi ce l’ha ancora.
Mi sono ritrovato più volte di fronte a miei coetanei (cioè cinquantenni) o persone più grandi che dicono: «’Mbeh, non ce lo siamo fatti tutti il morbillo da piccoli? Eppure siamo ancora qui.»
Qui sono all’opera un bias cognitivo e un errore logico.
Il bias cognitivo è la retrospezione rosea, che consiste nel selezionare gli aspetti del passato più piacevoli o comunque innocui, rimuovendo dolore, morte, sciagure.
L’errore logico deriva dal fatto (ovvio) che “noi”, quelli che siamo “ancora qui”, siamo quelli che non sono morti. Svariati miei coetanei, cioè bambini degli anni Settanta, morirono di morbillo.
Tra l’anno in cui è nato mio padre (1950) e l’anno in cui sono nato io (1970), in Italia, e limitandosi alla fascia di età dai zero ai quattro anni, il morbillo fece 5473 morti. Molti di più se considerassimo anche bambini più grandi e adulti.
L’altra premessa sbagliata è quella del presunto mega-business rappresentato da vaccinazioni come quella per il morbillo. È una leggenda metropolitana. L’industria medico-farmaceutica ha sempre considerato il comparto vaccinale di gran lunga il meno profittevole in assoluto, corrispondente soltanto al 3% del suo giro d’affari globale. Il grosso dei profitti lo ha sempre tratto dalla vendita delle apparecchiature (che include una vastissima gamma di prodotti piccoli e grandi, dalla siringa monouso all’impianto per la ventilazione meccanica) e soprattutto dai farmaci.
Ho linkato più volte questi dati in varie discussioni, nessuno li ha mai potuti smentire. Chiaro che adesso, con la vaccinazione per il Covid, quella percentuale aumenterà, ma non tanto da poter divenire maggioritaria, e in ogni caso nemmeno questo è un investimento di lungo corso, perché la vaccinazione la fai una volta, le siringhe o l’Oki, il Tavor o la tachipirina, il cotone idrofilo o lo spray nasale li vendi per sempre.
1/2 La questione vaccinale è, in pratica, materiale radioattivo… Dati i tempi, tocca cominciare con un disclaimer: quando per la prima volta sono partita per l’Africa equatoriale, non solo ho fatto tutti i vaccini possibili ma, se ci fossero stati, avrei fatto anche quelli contro l’insolazione e lo straniamento. Li ho fatti in base a un insieme di fattori: la pericolosità delle malattie; la disponibilità di cure a me note; la mia propensione alla patofobia quando sono all’estero – in base, quindi, a una certa “conoscenza di me” e alla mia capacità di autodeterminarmi.
L’obbligo vaccinale invece non finisce di convincermi, e non tanto in base a considerazioni economiche, ma in base a considerazioni politiche.
Poiché ritengo che la molteplicità e il pluralismo siano la sola way out dal disastro della totalizzazione capitalista, ne segue che anche in materia di “medicina, cure & salute” prediligo il pluralismo. Ora, non tutti i medici (e non stiamo parlando solo dei medici omeopati) sono favorevoli all’estensione indiscriminata dell’obbligo vaccinale – a volte per via dei rischi connessi ai vaccini stessi, altre volte perché lavorano in vista di un diverso concetto di salute. Uno dei maggiori epistemologi della medicina del Novecento, Georges Canguilhem, diceva che la salute è l’esatto contrario della “bolla di vetro” del non-ammalarsi, ma è la capacità dei soggetti di attraversare le malattie. In base a questo, sulla bilancia vaccinale bisogna mettere da un lato il non-ammalarsi, e dall’altro la disabitudine generale a “far funzionare” la capacità fisiologica di rispondere alle malattie. Non so dire, caso per caso, da che parte penderà la bilancia – so, però, che è una valutazione che va fatta collettivamente e non delegata ai soli tecnici di governo.
2/2 Inoltre, come ha appena scritto Wolf Bukowski, la protezione dei cittadini da tutto (da minacce create a bella posta così come da se stessi) sembra diventato il solo scopo dei governi – o, quantomeno, il solo argomento che porta voti. Il che, però, come abbiamo argomentato in questo post, va verso forme di autoritarismo che deprivano i soggetti della loro autonomia nonché, nel caso della medicina, anche di una minimale presa su di sé, sul proprio stato di salute, sulla quantità di “rischio accettabile”, e via dicendo.
Sui vaccini, come su tutto il resto, non c’è quindi una risposta univoca, né una sola posizione ragionevole, ma “solo” la necessità di riprenderci la discussione e la capacità individuale e collettiva di scelta.
Stefania, il mio rilievo era molto specifico, su certi argomenti assurdi contro il vaccino anti-morbillo.
Se si vuole fare un dibattito serio sull’obbligo vaccinale – che però, purtroppo, non mi risulta stia avvenendo da nessuna parte, per via della dialettica viziosa e della specularità tra scientismo e cospirazionismo – dire: «In fondo il morbillo ce lo siamo fatti tutti e siamo ancora qui» è – uso un eufemismo – controproducente. L’esempio del morbillo è proprio sbagliato, e il modo in cui viene fatto idem.
Wu Ming 1 ti rispondo qui (non so perche’ ma apparentemente non posso rispondere nella diramazione sotto). Io concordo con il bisogno di Pluralismo, direi biodiversita’, anche memetica.
Il morbillo e’ un esempio. Potremmo (dovremmo!) intavolare un discorso per ognuno di quelli resi obbligatori dalla lorenzin…
1. io non nego si possa morire di morbillo.
“può causare complicazioni respiratorie e gravi encefaliti, e in occidente, prima delle vaccinazioni, aveva una letalità di tutto rispetto”, io il ‘rispetto’ lo misuro in numeri. 1.1 Se osservi l-andamento della mortalita’ sotto i 5 anni da fine -800 per esempio (https://www.istat.it/it/files/2011/09/rapporto-istat-unicef.pdf grafico 1) vedi che la curva decresce progressivamente MOLTO prima dell-introduzione del vaccino. 1.2 se compari le morti (potremmo e dovremmo di certo considerare anche gli impatti a lungo termine) in italia negli ultimi 50 anni le malattie esantematiche non rientrano neppure tra le prime 20 cause. In un sistema con risorse finite mi aspetterei quindi dapprima un intervento sulle prime 20 in modo da ridurre le morti. Certo se tra te prime 10 ci sono alcool e tabacchi in cui ho grandi interessi economici….
Le cause di morte sono molteplici. MA in Italia, nel 2016 il morbillo non e’ una malattia con un rishio tale da richiedere il baratto dell’autodeterminazione e della libera scelta. Di morbillo si muore e si moriva per lo piu in africa e nei paesi colonizzati e stuprati dove siamo pronti ad esportare vaccini ma non accesso ad acqua e pace… purche’ non si muoia.
2. il capitalismo insegna che c’e’ bisogno di sempre nuovi spazi da colonizzare e spolpare.
“L’industria medico-farmaceutica ha sempre considerato il comparto vaccinale di gran lunga il meno profittevole in assoluto, corrispondente soltanto al 3% del suo giro d’affari globale. Il grosso dei profitti lo ha sempre tratto dalla vendita delle apparecchiature e soprattutto dai farmaci.” Poiche’ gli altri comparti sono saturi (un anziano in italia prende mediamente 8 pillole al giorno, senza rinunciare a nessuna delle cattive abitudini) perche’ escludi a priori che le aziende (private) non possano avere un interesse ad attaccare un nuovo mercato? esiste il marketing dei vaccini… come puoi guardare agli intenti di domani solo in base a quello che e’ successo finora? “Wu Ming 1 ti rispondo qui (non so perche’ ma apparentemente non posso rispondere nella diramazione sotto). Io concordo con il bisogno di Pluralismo, direi biodiversita’, anche memetica.
La curva della mortalità infantile nel corso del Novecento non cala “da sola” ma grazie ai progressi della pediatria (vaccini compresi), alle conquiste sociali in tema di sanità pubblica e al miglioramento dell’igiene nei luoghi di cura e nelle abitazioni. Il che, in linea di principio, può essere annoverato nell’estensione della medicalizzazione e della “pretesa di proteggere da sempre più rischi” ecc. Il novecento è il secolo della medicalizzazione della società, con tutti gli annessi e connessi. Ergo, stai citando come pezza d’appoggio un trend che in realtà è lo stesso che critichi.
Il fatto che già prima del vaccino il morbillo facesse meno morti rispetto a X non implica che vaccinarsi sia ridondante o futile, perché comunque di morbillo si continuava e in un certa misura si continua a morire.
«Si muore di più di altre cose» è un’affermazione a forte rischio di benaltrismo, ma soprattutto è inutile, perché non sposta nulla. Se salvo un bambino dal morbillo e tu mi vieni a dire: «Però mio cognato tabagista si è scoperto un tumore ai polmoni!», cosa stai spostando? Cosa stai cambiando? Stai solo mescolando due cose diverse.
La tua domanda retorica «come puoi guardare agli intenti di domani solo in base a quello che e’ successo finora?» è senza senso, primo perché stavamo parlando del presunto megabusiness del vaccino antimorbillo, non del vaccino anti-Covid, secondo perché io l’ho scritto – e mi sembra di averlo scritto chiaramente – che con il vaccino anti-Covid la percentuale del fatturato relativo ai vaccini aumenterà. Ma aumenterà partendo dal 3%, non da più in alto, e sarà un aumento più effimero di quanto si possa pensare.
Non mi sembra corretto dire che il mercato medico-farmaceutico non vaccinale è “saturo”. Quella delle medicine è una gallina dalle uova d’oro, e garantisce un flusso continuo. Questa è la “classifica” dei 50 farmaci più venduti in Italia:
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_bancheDati_14_3_0_file.pdf
Sono tutti degli “evergreen”, inossidabili, garanzia di profitto nel presente e nel futuro.
Se poi ci aggiungiamo gli strumenti di uso quotidiano sia domestico sia nelle strutture, come siringhe, cotone, disinfettante, guanti, tutto l’usa-e-getta, l’idea di un settore “saturo” è messa in crisi ulteriormente.
Ancora una volta faccio notare che nel 2019 i tre medicinali più venduti al mondo – Humira (un farmaco contro le artriti), Eliquis (un anticoagulante) e lenalidomide (un chemioterapico) – hanno generato più profitti di tutti i vaccini somministrati. E sono solo tre farmaci, su decine di migliaia in commercio. Ripeto: il vaccino anti-Covid altererà la situazione, ma i “vaccinocentrici” stanno dando decisamente troppa centralità alla cosa.
1. “non cala “da sola” ma grazie ai progressi della pediatria (vaccini compresi), alle conquiste sociali in tema di sanità pubblica e al miglioramento dell’igiene nei luoghi di cura e nelle abitazioni” sono pienamente d-accordo con te. Dico solo che i tre elemnti non hanno lo stesso peso, e a guardare la curva non mi pare si possa concludere che l’intorduzione dei vaccini sia stato quello fondamentale. A spanne direi 90% sanita’ e igiene 10% vaccino. MA bisognerebbe fare uno studio serio per avere dei pesi. Il vaccino e’ UNO strumento, non LO strumento.
2. In Italia il vaccino anti morbillo e’ stato introdotto nel 1976. La curva di mortalita’ era in costante discesa gia’ dai fini dell-800 (guerre a parte). Si passa da 10,2 morti (per mille nati vivi – sotto i 5 anni) allo 0,2 (di 32) nel 1971. Difficile giungere alla conclusione che dieci anni dopo si sia arrivati a zero grazie al vaccino.
3. «Si muore di più di altre cose» non significa che ogni singola vita salvata non sia un successo. Ne facevo un discorso di scelte politiche dettate da una valutazione oggettiva dei rischi a fronte di risorse limitate.
4. Non voleva essere retorica. Sono d-accordo, partiamo dal 3% che non era una gran cosa. Sull-effimero spero tu abbia ragione, io sono dell-opinione opposta.
5. Per saturo intendo il fatto che sia difficile raddoppiare o triplicare le vendite (obiettivi annuali ragionevoli per le aziende di bigpharma) senza introdurre un elemento/un prodotto/ un bisogno nel mercato. Anche qui spero abbia ragione tu.
Mi scuso con le nostre gentili ospiti e con tutti e se questa ramificazione ci porta fuori tema. Se ritenete, cancellatemi pure. Nel contempo rivolgo un invito estemporaneo alle due autrici, sollecitandole ad applicare i loro potenti strumenti d’analisi al tema che è qui abbozzato, sarebbe utile.
Mi sono occupato per decenni di design, di strategie di prodotto e di comunicazione. Sono sempre meravigliato dello sguardo ingenuo ed estasiato di chi, estraneo ai meccanismi perversi del mercato, ritiene che questo sia il migliore dei mondi possibili.
Scienza e tecnica sono al servizio dell’economia, la quale, per perpetuarsi necessita della crescita costante, all’infinito.
Tutto quanto ci circonda, dalle megalopoli alla merce più effimera, deriva da un progetto. Fra tante ipotesi immaginate, diviene oggetto del mondo reale solo ciò che, dopo rigide selezioni, risponde al principio fondamentale del Ritorno degli Investimenti. Non si produce per le necessità delle persone, si producono merci da consumare. Dei prodotti dolciari industriali –merendine, barrette, creme spalmabili–, per fare un esempio, la parte edibile è inferiore al 20 -25% del costo. Ciò che comperiamo è per il 75-80% è imballo, espositori, immagine, a cui si sommano trasporto, vendita, pubblicità, rifiuti, costi sociali derivanti dalla pessima qualità dell’alimento che produce obesità, carie, diabete, ma risponde in modo efficace all’incremento degli utili.
Potremmo pensare a una società nella quale l’obiettivo sia il benessere reale, non effimero? Una società dell’equilibrio? Dove non si allevano i polli nel modo peggiore possibile, come facciamo? Dove le monocolture non siano avvelenate coi pesticidi e poi bombardate coi raggi gamma?
Io credo che, proprio perché di Mondo ne abbiamo solo uno e ne siamo parte integrale, potremmo aspirare a renderlo migliore, senza dipendere da principi e meccanismi perversi come la finanza, che di scientifico non ha proprio nulla.