Sui problemi etici e poetici dello scrivere «oggetti narrativi non-identificati» e su come il Prunetti ci lavora sopra. Si parla anche di Orwell, Montanelli, Saviano, Lilin, Pansa e altri. Avvertenza: sassi sparati fuori dalle scarpe come se grandinasse.
di Wu Ming 1
«Nearly all the incidents described […] actually happened, though they have been rearranged».
Scriveva così George Orwell nel suo The Road to Wigan Pier (1937), memoriale e reportage immersivo sulle condizioni della working class del nord dell’Inghilterra tra le due guerre mondiali, scritto con tecniche da romanzo. Più o meno lo stesso vale per il suo libro del 1931 Down and Out in Paris and London.
«Quasi tutti gli eventi descritti sono realmente accaduti, anche se sono stati riarrangiati». Ma se «quasi» tutti sono realmente accaduti, vuol dire che alcuni sono inventati. Quali? E gli altri, se sono «riarrangiati», in che senso sono «realmente» accaduti?
Per chi vuole fare inchiesta e ricerca usando tecniche narrative e letterarie — cioè, tagliando con l’accetta, vuole scrivere «non-fiction creativa» — è un problema di poetica e di etica, un problema su cui ci si arrovella e accapiglia da tempo. La vexata quaestio riguarda principalmente due tecniche:
1. Il ricorso a composites, cioè a personaggi immaginari che riassumano in sé le caratteristiche di più persone realmente incontrate;
2. Il porsi dell’autore al centro dell’azione anche quando, nella realtà dei fatti, non era presente.
Sono entrambe tecniche legittime, ma a determinate condizioni. Lo scrittore o scrittrice dovrebbe:
■ applicarle con consapevolezza, rigore e rispetto per chi legge;
■ inserirle in un contesto ricostruito grazie a una seria ricerca documentale e/o sul campo;
■ soprattutto, dichiarare le proprie scelte, esplicitamente oppure inserendo nel testo alcuni marcatori, elementi che permettano a chi legge di capire il lavoro fatto, di cogliere e seguire i cambi di passo e di registro.
Ho più volte chiamato quest’approccio «mostrare la sutura»: significa tematizzare le tecniche utilizzate anziché nasconderle. Perché nasconderle, fingere di non averle usate, è disonesto. Se un autore — scrittore o giornalista — nasconde il ricorso a quelle tecniche, vuol dire che non le ha usate «a maggior gloria della verità», cioè per rendere meglio l’idea di un periodo storico, di un fenomeno sociale, di un’esperienza vissuta. No, le ha usate per tutt’altri scopi: per far passare una propria tesi e/o ingigantire il proprio ruolo negli eventi. Questo millantare credito, fegato e palle è tipico di un certo «superomismo» giornalistico italiano, da Barzini a Malaparte, da Montanelli a Fallaci e Pansa, fino a certi tristi epigoni d’oggi.
D’altro canto, tematizzare quelle tecniche non significa per forza sbandierarle ai quattro venti, dire continuamente: «guardate, sto facendo questo, sto facendo quello, adesso inserisco un elemento di fiction, qui invece cito la fonte» ecc. Il fulcro della questione è proprio: all’atto pratico dello scrivere, come essere onesti nei confronti di chi legge? Come segnalare quel che va segnalato senza appesantire il testo, senza immettervi una voce autoriale invasiva, insomma, senza rompere i coglioni?
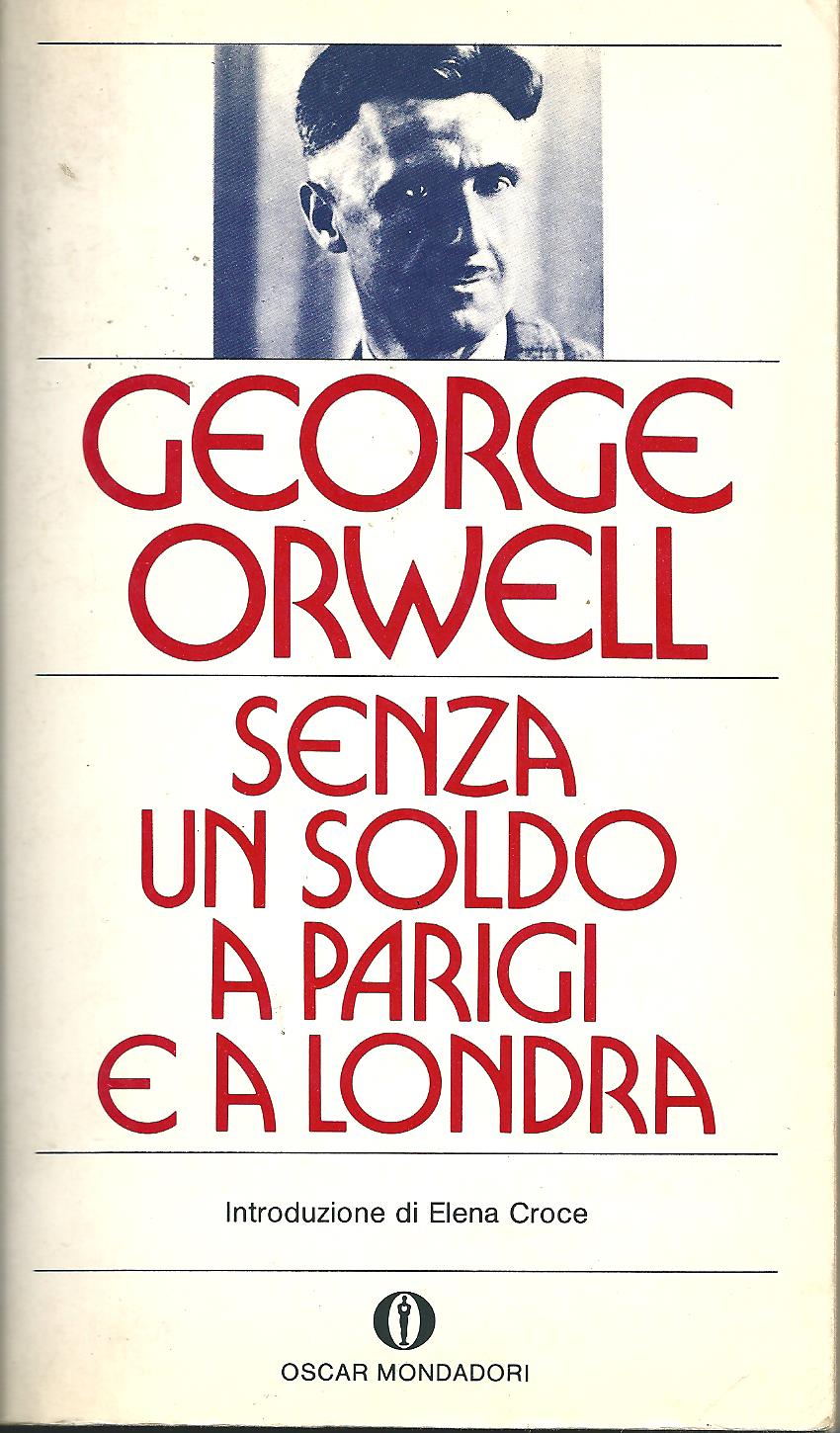 Orwell se la cavò con quel brillante understatement, e oggi nessuno gli darebbe del bugiardo, né definirebbe poco veridici i due libri citati sopra. Al contrario, sono annoverati tra le più efficaci testimonianze sulla disuguaglianza, lo sfruttamento e le condizioni di vita di proletari e underclass negli anni Trenta, tra il crollo di Wall Street nel 1929 e la seconda guerra mondiale. Ma a noi che scriviamo e leggiamo oggi — abituati a nuove tecnologie dello scrivere e del diffondere, abitanti di un mondo mediatico molto più vasto e complesso, esposti a un maggiore plurilinguismo e a ibridazioni ben più risquées di quelle di Orwell — una frasetta così non basterebbe, anzi, solleverebbe più domande, attizzerebbe le braci del problema.
Orwell se la cavò con quel brillante understatement, e oggi nessuno gli darebbe del bugiardo, né definirebbe poco veridici i due libri citati sopra. Al contrario, sono annoverati tra le più efficaci testimonianze sulla disuguaglianza, lo sfruttamento e le condizioni di vita di proletari e underclass negli anni Trenta, tra il crollo di Wall Street nel 1929 e la seconda guerra mondiale. Ma a noi che scriviamo e leggiamo oggi — abituati a nuove tecnologie dello scrivere e del diffondere, abitanti di un mondo mediatico molto più vasto e complesso, esposti a un maggiore plurilinguismo e a ibridazioni ben più risquées di quelle di Orwell — una frasetta così non basterebbe, anzi, solleverebbe più domande, attizzerebbe le braci del problema.
Nel nostro piccolo, noi autori e autrici che nell’Italia degli ultimi anni abbiamo battuto le piste degli «oggetti narrativi non-identificati» — gli UNO, Unidentified Narrative Objects — abbiamo sperimentato diverse soluzioni. A dirla tutta, penso si possa parlare di «UNO» solo ed esclusivamente quando la scrittura include queste preoccupazioni, le fa proprie e si adopera per affrontarle. Altrimenti non sono «UNO», ma libri che raccontano frottole. E così abbiamo usato i «titoli di coda»; abbiamo usato in modi spiazzanti i peritesti (titoli, epigrafi, note); abbiamo inserito “salti” stilistici a rimarcare i passaggi dalla fiction alla non-fiction; abbiamo estremizzato gli elementi di fiction, ad esempio ricorrendo all’horror e al soprannaturale, per staccarli nettamente dalle parti di inchiesta ecc. Di esperimenti ne abbiamo fatti tanti, alcuni più o meno riusciti, altri no.
Per quel che mi riguarda, nuove ispirazioni e suggestioni me le ha date, a partire dal 2014, la collaborazione con il mago Mariano Tomatis. È davvero molto utile guardare a quel che accade nell’illusionismo, dove sempre più artisti sfidano il tabù del non-svelare-il-trucco, fino a integrare l’esibizione della «sutura» dentro la loro pratica magica.
Va detto che abbiamo scontato un sacco di «concorrenza sleale», perché mentre noi ci ponevamo questi problemi, molti altri «ibridavano» spensierati, cinici e smargiassi, senza farsi alcuno scrupolo.
Da noi, infatti, molta «ibridazione di fiction e non-fiction» non viene dichiarata. In parole povere: un sacco di «testimonianze in prima persona», sedicenti inchieste e presunti reportages erano e sono in realtà fiction. O meglio: mischioni di reportage e invenzione di sana pianta. Il problema è che i loro autori, spesso «decani del giornalismo italiano», non lo dichiarano prima: no, lo ammettono soltanto dopo, una volta sgamati, e per giunta lo ammettono a bocca storta, mugugnando giustificazioni: «Non è andata proprio così ma la sostanza è quella, non spacchiamo il capello in quattro, non sono i fatti precisi quelli che contano ma l’atmosfera che si respirava ecc.»
L’Espediente Montanelli

«Sul livello morale di Montanelli rinvio al libro, molto documentato, di Renata Broggini: Passaggio in Svizzera.» (Carlo Ginzburg intervistato da Repubblica, 22/10/2013)
Lo chiamo «Espediente Montanelli» perché vi si è massicciamente ricorso per difendere l’Indro nazionale, soprattutto dopo le scoperte d’archivio della storica Renata Broggini.
Nel suo Passaggio in Svizzera. L’anno nascosto di Indro Montanelli (Feltrinelli, 2007), Broggini dimostra, documenti alla mano, che nelle sue ricostruzioni autobiografiche Montanelli mentì a più riprese sulla sua partecipazione alla Resistenza, sulle reali circostanze della sua reclusione ed evasione dal carcere di S. Vittore, sulla sua reale condizione di esule in Svizzera e, dulcis in fundo, sulla sua presenza a Piazzale Loreto il 29 aprile 1945.
In particolare, l’insistito tornare di Montanelli su quest’ultimo episodio, sempre piazzandosi al centro del racconto, ne ha pesantemente condizionato la ricezione e interpretazione a livello di cultura popolare piccolo-borghese e memoria pubblica qualunquista. Il tutto garantito dal sigillo dell’«io c’ero».
Quella di Montanelli su Piazzale Loreto è stata una delle narrazioni-capostipite dell’odierna «dittatura del testimone»: oggi basta dire che quella volta tu c’eri, che hai respirato l’aria di quel giorno — anzi, ormai basta dire che c’era tuo nonno — e automaticamente la tua parola vale più dei documenti disponibili, degli studi storici, delle verifiche, del metodo scientifico.
Vale di più, intendiamoci, a patto che confermi le vulgate egemoni: «prima tutti fascisti poi tutti antifascisti», i partigiani erano volgari banditi, i poveri italiani nelle foibe, e quant’altro.
La dittatura del testimone ha prodotto quella che alcuni hanno chiamato «storiografia del nonno»: è così, lo raccontava mio nonno!
E Montanelli era un po’ il nonno di tutti, no?
Ebbene, è altamente probabile che a Piazzale Loreto, quel giorno, Montanelli non ci fosse. Dagli archivi risulta fosse ancora in Svizzera e sia rientrato in Italia solo alcune settimane dopo. E in ogni caso, gli studi di Broggini mettono seriamente in questione tutta la narrazione di come Montanelli trascorse il periodo dalla caduta del fascismo alla Liberazione.
Come hanno reagito i suoi accoliti, collaboratori e ammiratori?
In un articolo pubblicato su Il Giornale del 2 ottobre 2007 e (alquanto puerilmente) intitolato «Indro mentiva, ma meno di chi dubita di lui», Mario Cervi scrisse:
Mario Cervi
«[…] nel ricostruire la propria straordinaria vita così come nel costruire i suoi straordinari articoli e libri, Montanelli a volte modificava questo o quel particolare. Voleva che la storia risultasse più giornalistica, voleva accentuare la sua presenza di testimone dei maggiori eventi. Non era a Milano nei giorni della Liberazione e non poteva perciò aver visto i corpi appesi di piazzale Loreto. Ma il racconto montanelliano, così come i suoi ritratti, resta genuino, autentico, impeccabile nelle linee generali, che sono quelle che contano […] [Renata Broggini] ha voluto documentare qualcosa che agli ammiratori di Montanelli importa moderatamente: che ogni suo brandello di reminiscenza e ogni sua virgola regga alla prova dei ricercatori e delle ricercatrici.»
Insomma, non importa che un fatto sia accaduto davvero, basta raccontarlo “bene” e diventa vero lo stesso, perché «le linee generali» bla bla bla.
L’Espediente Saviano
 Altri autori, una volta scoppiato il caso, hanno provato a spiegarsi brandendo in modo confuso nozioni di teoria letteraria: «miscela di fiction e non-fiction», «anche Truman Capote…» ecc.
Altri autori, una volta scoppiato il caso, hanno provato a spiegarsi brandendo in modo confuso nozioni di teoria letteraria: «miscela di fiction e non-fiction», «anche Truman Capote…» ecc.
Questo lo chiamerei «Espediente Saviano», con riferimento alla querelle esplosa negli USA nel 2015 sul libro Zero Zero Zero, nel quale Roberto Saviano — per sua stessa ammissione— ha fatto ricorso a composites. Sicuramente è un composite il personaggio chiamato «don Arturo», e forse ce ne sono altri. Non solo: pare che Saviano non fosse presente a episodi che invece racconta in prima persona.
Ripeto, sono tecniche legittime, purché vengano dichiarate prima, tematizzate, in qualche modo segnalate.
Qui la faccenda è particolarmente spinosa: come ho scritto diverse volte nel periodo 2006-2009 (poi ho smesso), già in Gomorra Saviano ricorreva alle due tecniche di cui sopra. Alcuni personaggi erano quasi certamente composites, e l’io narrante di Gomorra era «ipertestimoniale», nel senso che raccoglieva e sintetizzava esperienze non solo dell’autore, ma anche di altri. Alcuni lo capirono, molti altri no. Alcuni si risentirono, altri cercarono il quarto d’ora di celebrità, vi furono accuse di plagio e persino strascichi giudiziari. Io provai a riassumere la questione nei paragrafi 2, 4 e 5 del mio scritto Wu Ming / Tiziano Scarpa: Face Off (marzo 2009, pdf qui).
Certo, rispetto allo sfilacciato Zero Zero Zero l’esito formale del 2006 era ben diverso: Gomorra forniva in modo accattivante e coinvolgente — e finalmente in una lingua non da “mafiologo” — insight preziosi sull’economia politica del crimine organizzato post-novecentesco. Sì, l’opera era riuscita, anzi, era un capolavoro, ma fu allora che cominciarono i problemi. Saviano decise di non chiarire il proprio approccio. Certe cose che di Gomorra scrissi io, beh, avrebbe dovuto dirle anche lui. E invece non lo fece, mantenne e coltivò un’ambiguità che col tempo ha gonfiato equivoci, contribuendo a fare dell’autore stesso un «ipertestimone», e quindi — in tempi di dittatura del testimone — un uomo-simbolo. Saviano dice la verità perché lui c’era. Ma in realtà non sempre c’era, e da un certo momento in avanti, costretto a vivere sotto scorta, non c’è stato più. Niente più street life, ergo niente più street credibility, e «ricrearle» sulla pagina non basta mica.
Negli USA, sulla deontologia dello scrivere non-fiction sono molto sensibili.
Negli USA, promettenti carriere si sono infrante sull’uso non dichiarato di composites e/o sul presentare come autobiografiche storie che non lo erano. Si vedano, ad esempio, il caso James Frey nel 2006 e il caso Herman Rosenblat nel 2008.
Negli USA, quando hanno scoperto, cadendo dal pero, che l’ipertestimone Saviano aveva “mentito”, è scoppiato il caso. The Daily Beast ha pubblicato un accurato smontaggio di Zero Zero Zero. Smontaggio che nei riassunti italiani è stato ridotto alla sola questione del plagio, mentre l’aspetto più importante era: dove finisce la non-fiction, dove comincia la fiction?
Solo a quel punto Saviano si è scosso, ha provato a spiegare, ad argomentare sul metodo, pur prendendo qualche scorciatoia di troppo. In ogni caso (mi tocca ripetermi) sarebbe stato meglio farlo prima, perché dopo il giornalista non ti crede più.
Non ti crede più anche perché, nell’esportare non-fiction che poi si rivela fiction, nel 2015 l’Italia era già recidiva: nel 2011, infatti, c’era stato il caso Lilin.

Nicolai Lilin
Qui da noi, con poche meritevoli eccezioni, i primi libri di Nicolai Lilin sono stati accolti acriticamente: che forte, che esotico, l’educazione siberiana, la guerra in Cecenia! Wow! Questo sì che è un duro!
Eppure dalla Russia qualcuno l’aveva fatto notare che troppe cose non quadravano. Lo scrittore russo Zachar Prilepin aveva trattato Lilin da millantatore e preso per i fondelli le sue ricostruzioni, paragonate alle «mirabolanti frottole» del Barone di Münchhausen. E direttamente dalla Transnistria era arrivato un giudizio alquanto spiccio: «un fanfarone come tanti» [обычный фантазер].
Del resto, non risulta che alcun libro di Lilin sia mai stato tradotto in russo.
Dopo la pubblicazione in inglese, ai recensori bastò un rapidissimo fact-checking per concludere che Caduta libera era un libro di fiction. Cioè un «fake memoir». Anzi, «il delirio di un vaneggiatore» [a fantasist’s raving], come riportò The Independent.
Lilin abbozzò, provò a dichiarare: «It is not a memoir. It is a novel based on real events.» Anche lui, venuto dall’est ma oramai italianissimo (milanes’ 100%, «l’accento che ho lo tengo perché fa rustico»), lo disse soltanto dopo. E appunto, se lo dici dopo non ti credono più. Dai tempi di Caduta libera, nessun altro libro di Lilin risulta tradotto e pubblicato in inglese.
Una curiosità: il mentore di Lilin, il primissimo a spingere Educazione siberiana, era stato proprio Saviano.
È solo un caso che, dopo le polemiche su Zero Zero Zero, Saviano abbia scritto La paranza dei bambini, cioè un romanzo-romanzo, dichiarato subito «di finzione», come per mettere le mani avanti? Caso o no, forse è meglio così.
L’espediente del silenzio: Giampaolo Pansa

Giampaolo Pansa
Ma i peggiori sono quelli che fan finta di niente, come Giampaolo Pansa.
I suoi libri, presentati come inchieste storiche, sono in realtà, in gran parte, opere di fiction. È stato dimostrato, più volte si sono sviscerate le tecniche e gli stratagemmi a cui Pansa ha fatto ricorso da Il sangue dei vinti in poi. Lo ha fatto Ilenia Rossini nel suo L’uso pubblico della Resistenza: il «caso Pansa» tra vecchie e nuove polemiche (pdf qui). Lo ha fatto Gino Candreva nel suo La storiografia à la carte di Giampaolo Pansa (pdf qui). Lo hanno fatto diversi altri, ma finora è servito a poco: Pansa se ne frega, tira diritto e continua a scodellare quasi-romanzi spacciati per tutt’altro.
Pansa sa bene che nessuno «smontaggio» raggiungerà mai i suoi lettori. Soprattutto, sa che ai suoi ammiratori, molti dei quali tout court fascisti, della verità fattuale non è mai fottuto niente.
Una volta, chiacchierando, un amico mi ha detto che in fondo anche quelli di Pansa sono «oggetti narrativi non-identificati». No, sono solo libri disonesti, perché nascondono la propria natura ibrida, ne simulano una «oggettiva», si spacciano per inchieste quando non lo sono. Sono oggetti narrativi male identificati, che è molto diverso.
Su 108 metri
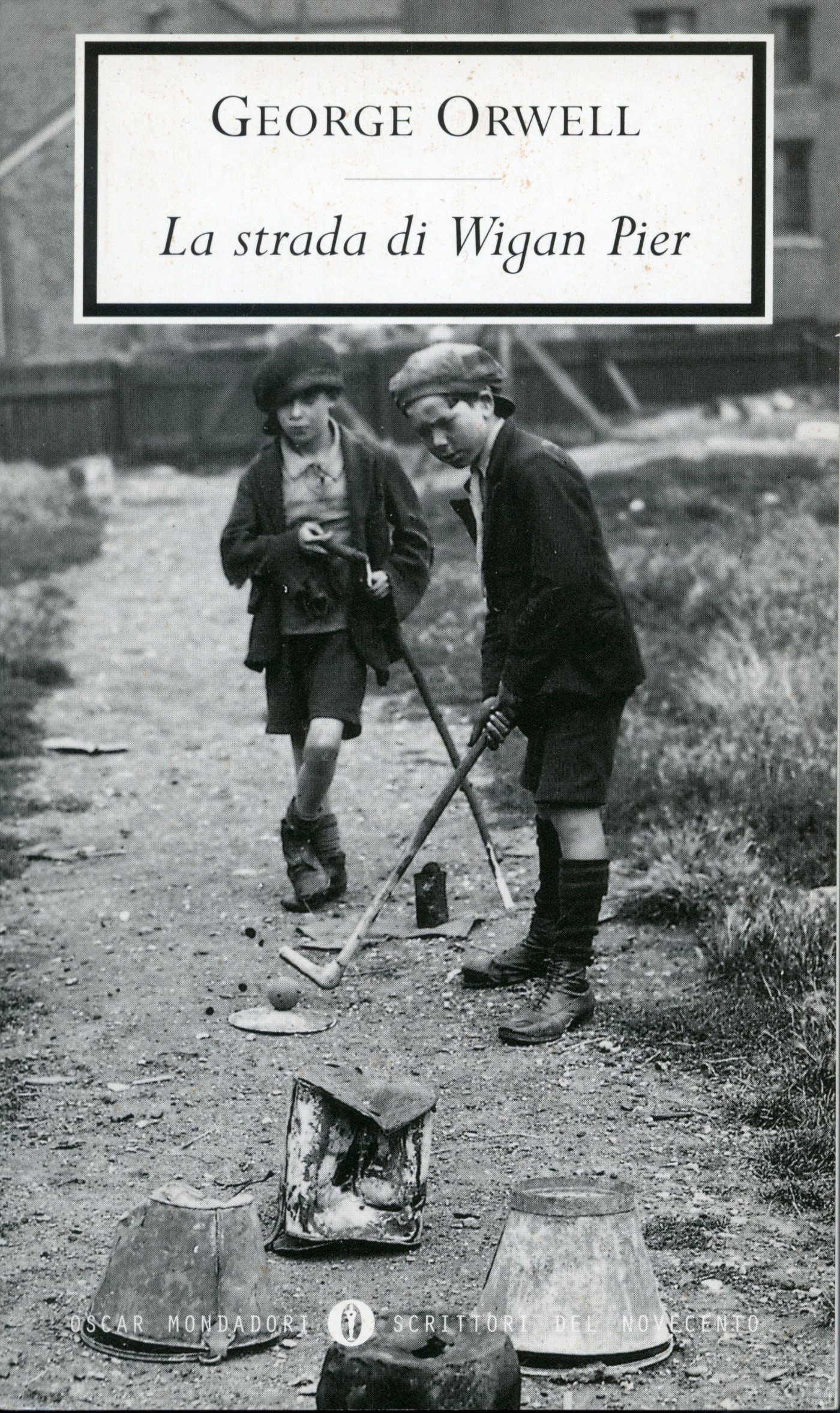 Tutte queste cose mi sono venute in mente, torrenziali, non appena chiuso l’ultimo libro di Alberto Prunetti 108 metri. The New Working Class Hero (Laterza, 2018) e ripreso dal loro scaffale i due libri di Orwell citati all’inizio.
Tutte queste cose mi sono venute in mente, torrenziali, non appena chiuso l’ultimo libro di Alberto Prunetti 108 metri. The New Working Class Hero (Laterza, 2018) e ripreso dal loro scaffale i due libri di Orwell citati all’inizio.
A quei due libri 108 metri deve molto. Nel mostrarci il «backstage» della ristorazione italiana in Inghilterra, di un grande shopping mall e infine di un pretenzioso villaggio vacanze, nel raccontare lo sfruttamento che ha luogo in quegli ambienti (nelle cucine e nei cessi), l’opera del Prunetti non può non ricordare Down and Out in Paris and London. Nel descrivere lo stile di vita dei proletari di due epoche e due paesi, tra il pub e l’altoforno, non può non ricordare The Road to Wigan Pier.
Ho scritto e discusso molto dello struggente Amianto. Una storia operaia (Agenzia X, 2012; nuova edizione ampliata Alegre, 2014), dove Alberto raccontava la morte di tumore del padre Renato, operaio e comunista, in contrappunto con la propria esperienza di precario del lavoro intellettuale. Come direttore della collana Quinto Tipo ho poi pubblicato PCSP. Piccola ControStoria Popolare (Alegre, 2015), un “remix” del libro d’esordio Potassa (compendio di miti e leggende della Maremma libertaria e antifascista) ampliato con un montaggio di brevi reportages e short stories apparse in rete e sui giornali.
Benché fossero narrazioni molto ibridate, e benché nell’Avvertenza iniziale 108 metri venga definito «romanzo», è proprio quest’ultimo l’opera più perturbante del Prunetti, la meno facilmente descrivibile. Rispetto ai libri precedenti, qui la compresenza di fiction e non-fiction è più sorprendente e suscita più interrogativi.
Tocca affrontare la questione del rapporto tra invenzione e verità fattuale facendo inversione a U e avviandoci nell’altra direzione. Se fino a poco fa ho scritto di opere che si presentavano come non-fiction dissimulando i propri elementi di fiction, spesso preponderanti, ora devo occuparmi di un’opera che fa l’esatto opposto: si presenta tout court come fiction, dissimulando il fatto che quasi tutto ciò che vi è raccontato è accaduto davvero.
L’Avvertenza stessa è ibrida. Consta di due distinti messaggi, il primo dei quali è il canonico disclaimer: «Ogni riferimento a fatti realmente accaduti o a persone realmente esistenti è da ritenersi puramente casuale». Non è vero, guardate, il Prunetti ci sta strizzando l’occhio. Nel libro ha un ruolo importante Renato Prunetti, padre di Alberto, che è esistito eccome e la sua presenza qui non è affatto «casuale», inoltre viene più volte evocata (e vituperata) Margaret Thatcher, e tanti sono i personaggi prelevati dal vissuto dell’autore.
Quanto al «realmente accaduti», quasi tutti i fatti raccontati nel libro lo sono, ancorché riarrangiati. Alcuni sono facilmente riscontrabili, come lo spegnimento dell’altoforno di Piombino e i primi sintomi del tumore polmonare di Renato; altri sono decifrabili (l’omicidio della deputata laburista Jo Cox da parte di un neofascista); altri sono inestricabili dalla fiction.
Fiction che non ha il suo fulcro nell’uso di composites, talmente vistoso che non c’è bisogno di occuparsene, quanto in due scelte di fondo, strutturali. È il prosieguo dell’Avvertenza a spiegarci la prima:
«[…] Alcuni eventi che stanno sullo sfondo del romanzo sono stati intenzionalmente riuniti dall’autore in una fittizia unità temporale. Questa può risultare incongrua con la successione fattuale delle vicende storiche.»
Il Prunetti condensa nell’arco di un anno e mezzo (quello che lui stesso ha trascorso nel Regno Unito) trent’anni di neoliberismo, deindustrializzazione, attacco ai diritti e ai salari dei lavoratori. Il narratore parte dalla Maremma con l’altoforno di Piombino funzionante a pieno regime, e torna dall’Inghilterra che è tutto finito: non solo una fase del capitalismo, ma una civiltà. È finito il vecchio mondo operaio.
Le parti del libro dove Alberto torna a raccontare della propria infanzia e adolescenza, di suo padre, degli amici del padre, del vecchio mondo comunista, del proletariato tra Livorno e la Maremma, con la sua cultura ben distinta da quella del padrone e la sua passione per il calcio giovanile e amatoriale, richiamano direttamente — e con grande emozione per chi legge — l’epopea di Amianto. Ed è chiaro che sono vicende vere e vissute, al 100% autobiografiche. Il frequente ricorso all’iperbole, come nella scena del bagaglio troppo pesante all’aeroporto, serve ad affilare i contorni di quel mondo, a restituircelo in modo più netto. Era un mondo in cui le si sparava grosse, un mondo di imprecazioni barocche che scomodavano interi pantheon, di ipertrofiche leggende da bar.
L’accelerazione/compressione del tempo avviene quando Alberto decide di partire per l’Inghilterra. A voler essere precisi, 108 metri comincia in medias res, con Alberto già Oltremanica, membro di una ciurma di cuochi e sguatteri reietti, tutti composites, personaggi plasmati col fango de L’isola del tesoro di Robert Louis Stevenson. C’è persino Long John Silver.
 In un crescendo di visionarietà, nel libro appare diverse volte Cthulhu, ripugnante semidio dei racconti di H. P. Lovecraft, e appare l’Entità, mostruoso campo di forza già raccontato in altre narrazioni italiane recenti, delle quali 108 metri è un implicito sequel. Ed è questa l’altra scelta di fondo importante: si agita, in queste pagine, una folla di spiriti-guida, mostri, santi folli, personaggi archetipici. Vi avvengono continuamente prodigi e magie. La compressione degli anni, il collasso di tre decenni su un unico piano temporale, è stata la necessaria premessa alla scelta di forzare tutto, di radicalizzare ogni elemento stilistico e narrativo. Perché tutto diventa immaginabile, una volta spalancata una temporalità che è la temporalità del mito.
In un crescendo di visionarietà, nel libro appare diverse volte Cthulhu, ripugnante semidio dei racconti di H. P. Lovecraft, e appare l’Entità, mostruoso campo di forza già raccontato in altre narrazioni italiane recenti, delle quali 108 metri è un implicito sequel. Ed è questa l’altra scelta di fondo importante: si agita, in queste pagine, una folla di spiriti-guida, mostri, santi folli, personaggi archetipici. Vi avvengono continuamente prodigi e magie. La compressione degli anni, il collasso di tre decenni su un unico piano temporale, è stata la necessaria premessa alla scelta di forzare tutto, di radicalizzare ogni elemento stilistico e narrativo. Perché tutto diventa immaginabile, una volta spalancata una temporalità che è la temporalità del mito.
Forse il soprannaturale non è la dimensione che ci si attenderebbe dalle «scritture working class». Nondimeno, per quanto possa suonare strano, in 108 metri la narrazione dello sfruttamento resta ancorata a un realismo sociale impietoso. Impietoso come la mossa chiamata «morso del ciuco», «una presa della carne delle gambe dell’avversario che produce dolore lancinante».
Le condizioni di merda in cui Alberto e i suoi colleghi lavorano, il rapporto con supervisori e capetti, le tattiche di microsabotaggio dei tempi imposti, di tutto questo non si mette mai in dubbio la veridicità. Nemmeno quando, nel giro di poche righe, la narrazione sfonda nell’orrorifico e nel soprannaturale. In fondo è normale, o almeno dovrebbe esserlo, che lo sfruttato allucini il padrone come un mostro, creatura enigmatica e «fuorispecie». Tra i proletari di 108 metri, del resto, girano diverse sostanze psicotrope.
Altrettanto veridico, perché ancorato all’esperienza diretta e confermabile da chiunque abbia conosciuto quel mondo, il racconto del tempo “libero”, della vita di questa working class quando non lavora.
«In fondo, anche Shakespeare aveva detto che il succo della vita era quella roba lì: uno ti dà uno schiaffo, te glielo ridai, un altro rompe una bottiglia e minaccia di aprirti il collo. A quel punto non puoi perdere la faccia coi tuoi amici, è una cosa di orgoglio. Ti fai sotto e scoppiano le tragedie. Sono secoli che gli studiosi e i critici cercano di decifrare i segreti di Shakespeare. Basterebbe entrare in un pub di lavoratori il venerdì sera e il mistero sarebbe risolto. Orgoglio, Paura, Vendetta, Gelosia. Ci sono più cose tra il bancone e la latrina di un qualsiasi pub inglese di una catena in franchising, di quante ne sogni la vostra filosofia.»
Quattro pagine prima, alla finestra di Cthul Manor, la villa in collina dove abita il padrone, era apparso un inquietante mollusco antropomorfo.
Più di ottant’anni dopo i grandi non-fiction novels di Orwell, a raccoglierne l’eredità non sono, non possono più essere i “normali” reportages narrativi, le “normali” inchieste di non-fiction creativa. Troppe cose sono accadute nel frattempo, nella società e in letteratura: il New Journalism, le controculture, il postmodernismo, Internet, le nuove «culture convergenti» esplorate da studiosi-fan come Henry Jenkins, culture basate su partecipazione, cooperazione e narrazioni senza confini, in un tripudio di spin-off e continue gemmazioni.
A rinnovare la tradizione di The Road to Wigan Pier oggi sono, non possono non essere libri come 108 metri, a tutta prima aberranti dal modello, eppure, a un livello più profondo, rispettosi. Rispettosi nei confronti del modello, della realtà dei fatti e dell’intelligenza del lettore. A condizione di «mostrare la sutura». E saranno ciascun autore e ciascun’autrice a decidere in che modo farlo.
Bologna, 31 marzo – 1 aprile 2018

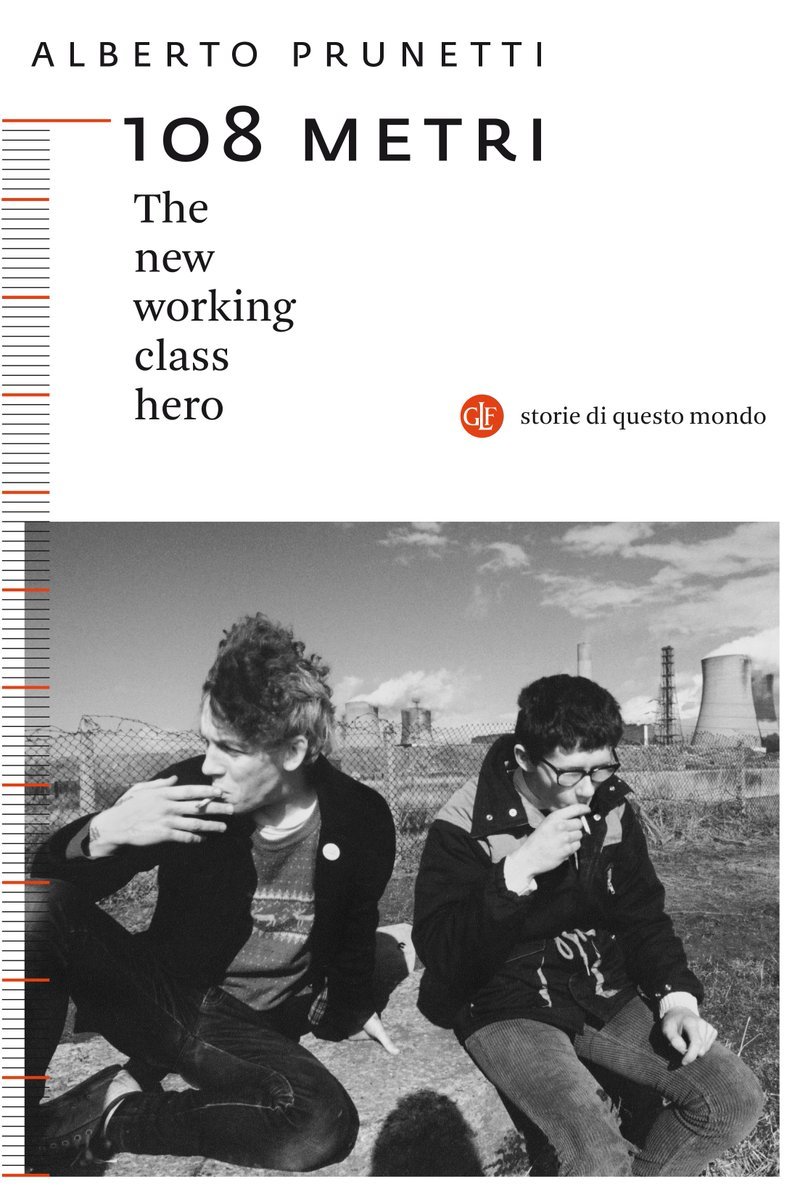

 Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)
Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

[…] giugno BOLOGNA Wu Ming presenta 108 metri di Alberto Prunetti h. 21, Vag61, via Paolo Fabbri […]
Nei prossimi giorni, sul blog di #quintotipo, dibattito a partire dagli appunti pubblicati qui sopra. Aprirà le danze un commento di Prunetti himself, seguito da un intervento di Luca Casarotti e da altri che puntualmente linkeremo qui.
A proposito di fiction e non-fiction in #Amianto e #108metri – di Alberto Prunetti, su #QuintoTipo.
Api working class: ancora su fiction e non-fiction in #108metri – di Luca Casarotti, su #QuintoTipo.
La parola a un mago. Dopo gli interventi di Luca Casarotti e Alberto Prunetti, ora a dire la sua su etica e poetica di fiction e non-fiction è Mariano Tomatis, che con “inganni etici” e illusioni ha a che fare tutti i giorni. Sempre su Quinto Tipo.
«Tutto documentato, tutto arbitrario». Interviene nel dibattito Maurizio Franco, uno degli autori della videoinchiesta Le catene della distribuzione, Premio Morrione 2016.
Tornare a casa. Luigi Chiarella (Yamunin), autore di #Diariodizona, legge #108metri di Alberto Prunetti. Su #QuintoTipo.
Su #QuintoTipo prosegue il dibattito con un imprescindibile intervento di Pietro De Vivo, uno degli editor della collana diretta da WM1. Il punto della situazione sugli «oggetti narrativi non-identificati».
[…] Alegre sta ospitando una serie di contributi sull’argomento, che hanno preso il via da una recensione del libro 108 metri di Alberto Prunetti. Wu Ming 1 chiama «mostrare la sutura» la pratica di disseminare nel testo degli elementi […]
[…] Una storia vista da dentro e da fuori. Un’ego-histoire? Un’ autofiction? Spiega Alberto in una discussione che si è aperta sul genere dell’ibrido narrativo: «Anche il Renato di 108 metri, come avevo […]
Ho finito il libro qualche giorno prima di partire per i monti Sibillini, e ho già deciso che farà parte, assieme ad altre scritture working -class, della bibliografia di cui converserò in autunno ad una conferenza a cui ho la buona sorte di essere stato invitato a parlare. Ma ora non riesco a commentare 108 metri, finirei col parlare soprattutto di me, delle risonanze, e non abbastanza di cosa mi è piaciuto e delle due cose due che non mi sono piaciute. Attendo il terzo volume della trilogia, mentre immagino paradigmi che legano quest’opera a Diario di zona, a Inox e ad altri.
L’audio della presentazione di #108metri – con Alberto Prunetti e Wu Ming 4
Vag61, Bologna, 7 maggio 2018.
[…] Prunetti (autore di Amianto. Una storia operaia, PCSP – Piccola ControStoria Popolare e 108 metri) ■ h. 15:30 – L’ambiente, gli incendi, il clima, la lotta Presentazione del libro […]
[…] influenzare tanto il proseguimento della trilogia che Amianto inaugurava – il secondo episodio è 108 metri, uscito nella primavera 2018 – quanto il progetto della collana Quinto Tipo, diretta da WM1 per […]
[…] Del resto è un’idea con la quale anche la letteratura omologa si sta confrontando, vedi l’ultimo romanzo di Alberto Prunetti, 108 metri, nel quale compare a più riprese una sorta di demone lovecraftiano che incarna l’essenza del […]
[…] Allontanandoci da questo giudizio, criticheremo il libro di Sessi per il suo scarso rigore metodologico, che a nostro avviso si traduce in un’ambigua e poco felice commistione di storia, memoria e letteratura, in uno di quelli che Wu Ming 1, con particolare riferimento alle produzioni di Giampaolo Pansa, ha definito «oggetti narrativi male identificati». […]
[…] strategie discorsive di Gianpaolo Pansa si sono espressi storici e narratori. Wu Ming 1 ha scritto: «I suoi libri, presentati come inchieste storiche, sono in realtà, in gran parte, opere di […]
Su Montanelli, io trovo apprezzabile la schietta definizione data da Luciano Canfora in questo video recentissimo (25 aprile 2019). Al minuto 8,48 del filmato, Montanelli viene sinteticamente descritto da Canfora come “il più cialtrone dei qualunquisti”.
https://www.youtube.com/watch?v=4dTLt23-bt4&feature=share
[…] 2014 è stato rieditato per Alegre in una nuova edizione accesciuta. Nel 2018 è uscito per Laterza 108 metri. Nel 2019 Amianto è stato pubblicato in Francia. Nel 2020 Amianto sarà tradotto in castigliano e […]
[…] ha scritto Wu Ming 1: i libri di Pansa, «presentati come inchieste storiche, sono in realtà, in gran parte, […]