
«This machine…»
di Salvatore Talia (guest blogger)
In tutte le lingue del mondo, dare a qualcuno del fascista significa insultarlo pesantemente. In questo modo la coscienza civile di tutti i popoli esprime, anche mediante il linguaggio, un giudizio storico e morale di condanna nei confronti di un’ideologia che ha sanguinosamente segnato il ventesimo secolo.
Nessuno, pertanto, dovrebbe trovare strano che il protagonista di un lungometraggio a cartoni animati del maestro giapponese Hayao Miyazaki pronunci la memorabile battuta:
«Piuttosto che diventare un fascista, meglio essere un maiale.»
Né si troverà strano che la battuta, proprio perché efficace e molto caratteristica, sia citata in esergo nella voce della versione italiana di Wikipedia dedicata a questo film.
Eppure qualcuno, nella pagina di discussione della stessa voce, ha avuto da ridire:
«Mi pare una citazione alquanto inopportuna. Propongo di cassarla e sostituirla. Si può tranquillamente inserire una citazione neutra e rispettosa comunque del personaggio e che non crei parallelismi offensivi per parte degli utenti di Wiki. – Jose Antonio 16:10, 4 ago 2012. [Sottolineatura mia, N.d.R.]»
Il giorno dopo è intervenuto un altro utente per dare ragione a Jose Antonio:
«Sono assolutamente d’accordo con Jose, di tutte le citazioni del film se n’è scelta una a sfondo politico… mi sembra inopportuno, anche perché le sfumature politiche non sono di certo le peculiarità più pregnanti e rappresentative del personaggio: c’erano citazioni ben più esemplari sui piloti d’idrovolanti, sull’aviazione, sull’amore, sull’Adriatico. Rimuovere o almeno sostituire con una citazione più rappresentativa e neutra. – Theirrules 07:14, 5 ago 2012».
La proposta di Jose Antonio di censurare la citazione è stata respinta, almeno finora. Infatti altri utenti di Wikipedia sono intervenuti nella discussione facendo notare (e debitamente citando alcune fonti di critica cinematografica) che il tema politico è centrale nel film di Miyazaki, e che in particolare la battuta contestata da Jose Antonio e da Theirrules rappresenta in modo emblematico l’antifascismo esistenziale del protagonista.
Tuttavia, soffermiamoci un attimo sulla singolare argomentazione di Jose Antonio. Chi, e quanti, sono questi utenti di Wikipedia Italia che possono sentirsi offesi da una battuta antifascista (tutto sommato blanda, se si considera che il personaggio che la pronuncia è un maiale antropomorfo) contenuta in un cartone animato?
Un libro inchiesta
Ci aiuta a rispondere a questa domanda un interessante libro inchiesta su Wikipedia recentemente pubblicato: Emanuele Mastrangelo & Enrico Petrucci, Wikipedia. L’enciclopedia libera e l’egemonia dell’informazione, Bietti, Milano 2013, pagg. 393, Euro 16,00, ISBN: 978-88-8248-299-2.
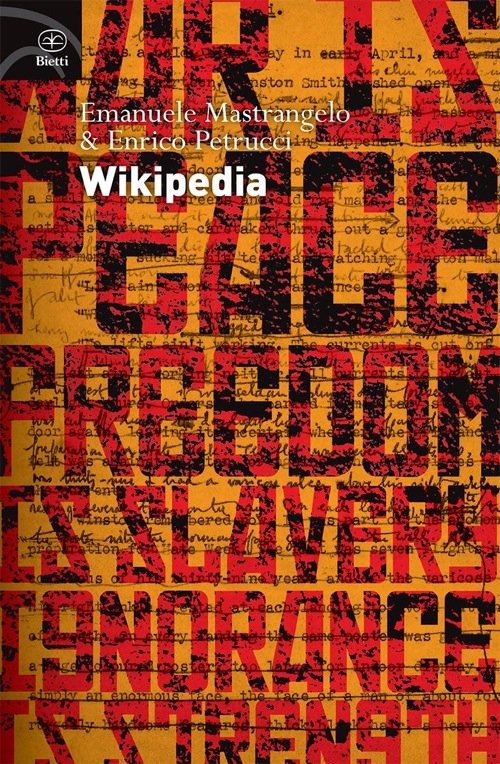
Il libro, «promosso e patrocinato» da Gianfranco De Turris (che gli autori per questo ringraziano a pag. 393), è per molti aspetti un’iniziativa lodevole. Mancano in Italia studi approfonditi su Wikipedia, nonostante l’importanza che l’enciclopedia libera viene sempre più assumendo come fonte d’informazione principale non solo per gli utenti di Internet, ma ormai anche per il mondo della cultura e dell’informazione largamente inteso (giornali cartacei, agenzie di stampa, scuola). Tutta la prima metà del libro, la più convincente, è un efficace reportage sul modo in cui Wikipedia è entrata a vele spiegate nella vita quotidiana di molti che pure a volte ostentano di disprezzarla. Sempre più giornalisti, intellettuali e politici, come fanno giustamente notare Mastrangelo & Petrucci con una serie di divertenti esempi, attingono largamente a Wikipedia come fonte, più o meno riconosciuta, d’informazione.
Altro pregio del libro di Mastrangelo & Petrucci consiste nell’offrire informazioni utili e puntuali sulla storia di Wikipedia, sul suo funzionamento, sul suo linguaggio e sulle sue regole.
Gli autori, forse per reazione alla sottovalutazione di Wikipedia da parte della cultura ufficiale, tendono in verità ad esagerare in senso opposto, enfatizzando oltre misura l’importanza dell’enciclopedia libera, fino a definire Wikipedia nientemeno come il «più grande progetto culturale degli ultimi secoli» (pag. 98) e «una delle pochissime voci positive di un bilancio epocale complessivamente negativo» (pag. 8). Mastrangelo & Petrucci non esitano a paragonare Wikipedia alla storica enciclopedia di Diderot e D’Alembert: il compito delle due enciclopedie sarebbe il medesimo, quello di «sistematizzare il sapere, fare ordine, classificare, categorizzare, indicizzare, far sì che ogni barlume d’informazione utile possa essere classificato e trovato» (pag. 99). Con il che, sia detto per inciso, Mastrangelo & Petrucci fraintendono il senso complessivo dell’impresa di Diderot e D’Alembert, la quale non aveva tanto l’obiettivo di sistematizzare e gerarchizzare il sapere, quanto invece quello di socializzare la conoscenza nell’ambito di un’ipotesi di critica e di trasformazione rivoluzionaria della società.]
Per Mastrangelo & Petrucci, «Wikipedia è un progetto grandioso e geniale. Per la prima volta da decenni l’umanità è riuscita davvero a ideare un meccanismo virtuoso con il quale si può combattere l’entropia, ancorché nel regno dell’informazione e non in quello della termodinamica» (pag. 341).
Osservo di passata che una minore fascinazione avrebbe forse evitato ai due autori di incorrere in un brutto scivolone: attribuire ad Antonio Gramsci una definizione della egemonia culturale, riprendendola (evidentemente senza verificarla) dalla omonima voce di Wikipedia (pag. 369).
Peccato che, però, quella particolare definizione sia apocrifa: il brano citato non si trova, infatti, in nessuna delle opere di Gramsci. L’utente di Wikipedia che ha inserito il brano virgolettato lo ha fatto per errore. Poco male: grazie ai meravigliosi meccanismi auto-correttivi dell’enciclopedia libera l’errore è già stato discusso e corretto, perlomeno in it.wiki. Per vedere la medesima correzione sul libro di Mastrangelo & Petrucci, invece, bisognerà attendere una eventuale seconda edizione.
Il «meccanismo virtuoso» di Wikipedia, nella visione dei nostri due autori, ne assicura l’inarrestabile progresso. Il libro tende a minimizzare alcune contraddizioni che – si direbbe – possono ben ostacolare o inceppare il funzionamento dell’enciclopedia libera. Per esempio, il fatto che Wikipedia appartiene a un ente privato (sia pure senza fini di lucro) qual è la Wikimedia Foundation, ciò che, in astratto, la rende vulnerabile a rischi di tracollo economico o agli appetiti di grandi gruppi capitalistici, che potrebbero in futuro manovrare per appropriarsi di una potenziale fonte di profitti.
Nel libro, a dire il vero, sono riportati vari preoccupanti casi emersi negli scorsi anni, in cui alcune corporation private, gli uffici stampa di alcuni uomini politici, e addirittura alcuni servizi di intelligence, hanno tentato di manipolare a proprio vantaggio i contenuti della versione inglese di Wikipedia (pp. 41-55). Tuttavia, chiosano Mastrangelo & Petrucci, «il problema dell’influenza esterna a Wikipedia è relativamente poco preoccupante a fronte di quello rappresentato dalle camarille interne alla comunità wikipediana» (pag. 55).
Viene così introdotto un tema che avrà ampio sviluppo in tutta la seconda metà del volume, fino a costituirne il motivo dominante. Qui l’ottica di Mastrangelo & Petrucci si restringe di colpo, diventa nazionale, e la trattazione è pressoché interamente dedicata alla denuncia di un grave pericolo che, a detta dei due autori, minaccia it.wiki (la versione in lingua italiana di Wikipedia): «il rischio che la pigrizia di chi usa Wikipedia e la malignità di un gruppo di furfanti la faccia scivolare verso il suo opposto maligno: un Ministero della Verità orwelliano» (pag. 104, corsivo mio).
La «cricca»
Agli occhi di Mastrangelo & Petrucci, it.wiki ha innanzitutto un problema: che «una parte molto notevole degli utenti più attivi si riconosc[e] in aree politiche vicine alla sinistra» (pp. 177-8). In it.wiki »colui il quale si professa “di sinistra” ha – e riesce a ritagliarsi – una cittadinanza che è in parte negata a chi, invece, fa aperta professione di fede politica opposta o chi, comunque, si dimostra in qualche maniera “non-di-sinistra”» (pp. 178-9, corsivi miei). Questo avviene intanto per la ben nota timidezza che impedisce a tanti italiani «non-di-sinistra» di manifestarsi liberamente come tali; la maggioranza silenziosa (cfr. pag. 182; Mastrangelo & Petrucci usano effettivamente questa espressione a pag. 374). Ma soprattutto ciò avviene perché gli utenti «non-di-sinistra», secondo i due autori, in it.wiki sarebbero apertamente discriminati.
Le pagine sicuramente più deboli, nel testo che sto esaminando, sono proprio quelle dedicate alla presunta “egemonia” della sinistra su Wikipedia, un’egemonia che il libro tende a definire in termini molto grezzi e complottistici. In Wikipedia esistono infatti degli utenti, definiti “amministratori” o “admin”, che vengono periodicamente eletti per svolgere mansioni di servizio, e che dispongono di alcune prerogative in ordine alla manutenzione dell’enciclopedia, alla cancellazione delle pagine, a determinate sanzioni che possono irrogare a utenti che violino le norme di condotta dell’enciclopedia, ecc. Ciò posto, secondo Mastrangelo & Petrucci esisterebbe in it.wiki una ristretta «cricca» di amministratori di sinistra che abusano dei loro poteri, opprimendo, discriminando e perseguitando gli utenti che non la pensano come loro.
Abbastanza onestamente, a un certo punto del libro i due autori riconoscono che il loro tentativo di analisi delle dinamiche operanti nella comunità degli utenti di it.wiki (benché il volume contenga alcune significative statistiche, come vedremo in seguito) non è condotto secondo i criteri scientifici della statistica sociologica (pag. 166).
Anche dopo questa precisazione, però, bisogna rilevare che il libro di Mastrangelo & Petrucci è penalizzato da un forte divario fra le tante pagine in cui si parla di Wikipedia in modo informativo e pertinente, con un evidente sforzo di oggettività , e altre pagine in cui la tesi della “cricca” viene argomentata in modo assai sommario, con un metodo che definirei “pansiano”. L’ipotesi degli admin di sinistra che discriminano gli utenti «non-di-sinistra», infatti, viene dapprima enunciata mediante l’uso di formule-slogan che si vorrebbero incisive e icastiche (la «cricca», i «guardiani della memoria», la «Ceka», i ripetuti riferimenti a Orwell ecc.), e poi viene illustrata mediante una casistica tratta soprattutto dalle conversazioni fra utenti nelle pagine di discussione di it.wiki. Gli esempi da loro raccolti varrebbero da soli, secondo i due autori, a dimostrare l’esistenza della «cricca».
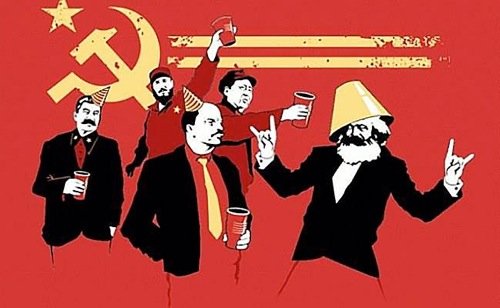
Il metodo scelto da Mastrangelo & Petrucci si presta fin troppo facilmente alla confutazione. Infatti, si possono agevolmente contrapporre, agli stralci di dibattito selezionati dai due autori per dimostrare gli abusi della «cricca» di sinistra ai danni di determinati utenti «non-di-sinistra», altri esempi, tratti sempre dalle pagine di Wikipedia, dove pare proprio che gli abusanti siano questi ultimi. Cosa che farò nel prosieguo di questo articolo.
Per ora mi limito a rilevare alcune incongruenze in cui incorrono Mastrangelo & Petrucci nel discutere il loro stesso materiale. Ad esempio: a pag. 299, i nostri due autori condannano chi discute l’autorevolezza di alcuni storici ritenuti (a torto o a ragione) di destra, in quanto secondo Mastrangelo & Petrucci è sbagliato «delegittimare una fonte denigrando antropologicamente il suo autore». Soltanto due pagine dopo, viene riportato con favore un lungo commento dell’utente Presbite nel quale tra l’altro Nicola Tranfaglia viene definito «perfettissimo esempio di “intellettuale organico” di scuola marxista-leninista ortodossa tuttora notoriamente comunista (…) storico comunistissimo schierato con tessera» (pag. 301). A pag. 307, in un suo commento parimenti citato per esteso e con approvazione, Jose Antonio dileggia lo scrittore Giacomo Scotti in quanto quest’ultimo «dopo la seconda guerra mondiale si è trasferito in Jugoslavia per vivere il paradiso di Tito». Su osservazioni come queste, Mastrangelo & Petrucci evidentemente non trovano nulla da ridire; salvo indignarsi e parlare di «razzismo ideologico” (pag. 298) quando rilevano che in Wikipedia qualcuno osa mettere in dubbio l’autorevolezza di un autore come Giorgio Pisanò.
Who’s that boy? Il caso Emanuele Mastrangelo

Emanuele Mastrangelo
Sarebbe interessante poter distinguere i rispettivi contributi dei due autori al libro, cioè quali pagine sono state scritte da Petrucci e quali da Mastrangelo; ma non ci sono elementi per stabilirlo. Il volume, in quarta di copertina, ci dice solo che Enrico Petrucci è ingegnere e «si è occupato di diverse inchieste sull’enciclopedia libera», mentre di Emanuele Mastrangelo è detto che collabora con la rivista Storia in Rete e che «[n]el 2011 fu espulso da Wikipedia per aver sostenuto che la storiografia italiana non è rimasta ferma agli anni Ottanta». In una breve nota all’interno del volume troviamo qualche dettaglio in più sulla vicenda dell’espulsione di Mastrangelo da it.wiki: «sebbene bandito per “falsificazione di fonti”, l’accusa non è mai stata provata e, anzi, risultano falsificate le prove condotte contro di esso» (pag. 228). Niente di più e niente di meno.
Per sapere qualcosa di più a proposito di Emanuele Mastrangelo possiamo partire da un libro dello storico Gabriele Turi, La cultura delle destre. Alla ricerca dell’egemonia culturale in Italia, Bollati Boringhieri, Torino 2013, pp. 175, Euro 14,00, ISBN 978-88-339-2429-8. Nell’ultimo capitolo del suo libro, Turi traccia una mappa del revisionismo storico su Internet partendo dal sito storiainrete.com, cui corrisponde una rivista cartacea fondata nel 2005 con redattore capo Emanuele Mastrangelo. Di Mastrangelo, Turi osserva che suoi interessi peculiari sono Mussolini e il fascismo, e che nel 2006 pubblicò un libro intitolato I canti del littorio. A proposito della rivista, Turi scrive che essa «abbraccia completamente la vulgata revisionista, coniugando inoltre un registro cattolico ultraconservatore con un gusto per i “misteri” e le “rivelazioni”, di cui Salò è il terreno di elezione». Secondo Turi, il mensile sarebbe inoltre caratterizzato da «una diffusa comprensione per il fascismo», condivisa anche dai lettori della rivista, i quali, nel 2009, risposero a un sondaggio su quali fossero i «super italiani» attribuendo il terzo posto a Benito Mussolini (subito dopo Leonardo e Galileo).
Fin qui Gabriele Turi. Proviamo ora a vedere se corrisponde al vero l’asserzione di Mastrangelo di essere stato espulso ingiustamente da it.wiki e di essere stato vittima di una persecuzione politica. Stranamente, i documenti della vicenda non vengono richiamati, né in alcun modo utilizzati, nel libro di Mastrangelo & Petrucci; essi comunque sono facilmente reperibili in it.wiki.
Si può partire dalla segnalazione di problematicità (l’atto che su it.wiki equivale a un’apertura di procedimento disciplinare contro un utente) a carico di Mastrangelo in data 14 giugno 2009.
La segnalazione nacque a partire dalla voce Benito Mussolini, cui all’epoca Mastrangelo collaborava, e da una relativa discussione in cui Mastrangelo si oppose strenuamente a che il… “viaggio” di Mussolini da Milano a Dongo, fra il 25 e il 27 aprile 1945 (viaggio che, come tutti sanno, si concluse con lo smascheramento di Mussolini che fu scoperto dai partigiani travestito da soldato tedesco), fosse definito «fuga». Fra l’altro Mastrangelo sosteneva che «quasi tutti gli storici di un certo peso da almeno 15 anni non danno più credito a questa vecchia tesi”» Le citazioni da storici, con cui Mastrangelo intendeva giustificare la sua asserzione che Mussolini non stesse affatto fuggendo, furono poste in dubbio riguardo alla loro veridicità. Di qui la segnalazione, che si concluse, dopo ampio dibattito, con l’irrogazione a Mastrangelo di un «blocco di scrittura» (l’equivalente della sospensione da it.wiki) di sei mesi.

Ogni passo sette leghe, via, veloci, verso la Svizzera.
Mastrangelo fu poi oggetto di un’altra segnalazione di problematicità che si concluse, dopo un lunghissimo dibattito, con il suo blocco infinito (l’espulsione definitiva, detta anche ban) da it.wiki, il 16 novembre 2010 (quindi non nel 2011, come erroneamente riportato dalla quarta di copertina del libro).
Inviterei a leggere per intero i due dibattiti, perché sono di per sé molto istruttivi per capire come funziona Wikipedia. Dalla lettura delle due discussioni, fra l’altro, si evince come le accuse rivolte contro Mastrangelo da vari utenti non si limitassero alla falsificazione delle fonti, ma comprendessero una serie di altri addebiti, quali:
1) l’aver usato Wikipedia non come una mera enciclopedia (cioè come semplice esposizione, di tipo compilatorio, di un sapere già consolidato), bensì come un mezzo per divulgare i risultati delle proprie ricerche;
2) l’aver fatto di Wikipedia una sorta di tribuna per la divulgazione di tesi storiografiche fortemente minoritarie, non condivise dalla maggioranza degli studiosi;
3) l’aver assunto un punto di vista «smaccatamente di parte», compilando voci in modo estremamente fazioso e politicamente tendenzioso («POV», in gergo wikipediese, acronimo di Point Of View);
4) l’aver preteso di selezionare le fonti a suo piacimento, privilegiando in modo indebito quelle appartenenti a una determinata corrente (quella del “revisionismo storico”), la sola da lui considerata “scientifica”, e svalutando tutte le altre alla stregua di semplice “vulgata” ;
5) l’aver dimostrato, nelle discussioni con altri utenti circa la compilazione delle voci, una evidente malafede, con un atteggiamento che non era quello di collaborare per migliorare l’enciclopedia, bensì quello di mantenere “blindate” le voci stesse, fissandole all’impostazione (politicamente orientata) che egli aveva loro dato.
Da notare che la singolare tesi di Mastrangelo, secondo cui in tema di fascismo solo la storiografia “revisionista” avrebbe valore, mentre tutta quanta l’altra storiografia sarebbe “vulgata” priva di valore scientifico o comunque sarebbe ormai superata dal progresso delle ricerche, la troviamo richiamata, in modo piuttosto apodittico, anche nel libro che sto recensendo (pp. 36 e 382).
Naturalmente, sia nella prima segnalazione del 2009 che nella seconda del 2010, e poi ancora in vari articoli sulla rivista di cui è redattore, e anche altrove in Internet, Mastrangelo si difese ampiamente e con vigore, negando gli addebiti e controargomentando. Può apparire ingiusto che in questa sede io abbia riportato solo gli argomenti dell’accusa e non anche quelli della difesa. Invito nuovamente a leggere nella loro interezza i dibattiti che ho linkato sopra, per farsi un’opinione propria. Qui mi preme soprattutto dare un’idea della dialettica interna fra gli utenti di Wikipedia e degli schieramenti in campo riguardo alla questione del revisionismo storico. Fra gli accusatori di Mastrangelo troviamo utenti come Piero Montesacro, Crisarco e Koji, che nel libro di Mastrangelo & Petrucci vengono stigmatizzati come appartenenti alla «cricca« di sinistra. Fra i difensori di Mastrangelo troviamo invece utenti come Barbicone, Jose Antonio, Presbite e Theirrules. Alcuni di loro li abbiamo già incontrati qui sopra; di altri parleremo fra poco. Jose Antonio e Presbite sono ampiamente citati (ovviamente con favore) anche nel libro di Emanuele Mastrangelo & Enrico Petrucci.
Perché Mastrangelo è stato espulso
Vediamo ora alcune voci alla cui redazione Mastrangelo collaborò prima di essere espulso da it.wiki.
Cominciamo dalla voce Squadrismo. Prenderò in considerazione non la versione attuale della voce, bensì l’ultima redazione prima del ban.
E’ una voce dotata di una sua indubbia coerenza interna, ispirata a una concezione generale che definirei alquanto “farinacciana”. Gli squadristi del 1919 – 1922 vi vengono dipinti come eroi di guerra, guasconi e un po’ goliardi, che si riunirono per reagire giustamente alle intollerabili violenze e provocazioni dei bolscevichi, salvarono l’Italia dalla sovversione, e avviarono una «rivoluzione nazionale» con lo scopo di «rigenerare moralmente e materialmente la patria». Fra gli autori citati nelle note a supporto troviamo, assieme a scrittori e storici “di area” (come Attilio Tamaro, Pino Rauti e Rutilio Sermonti, Mario Piazzesi, Giorgio Alberto Chiurco), anche i più bei nomi della storiografia sul fascismo: Renzo De Felice, Adrian Lyttelton, Angelo D’Orsi, Mimmo Franzinelli e persino Gaetano Salvemini, un cui brano campeggia a inizio voce, debitamente virgolettato, assieme a un altro di Alcide De Gasperi a giustificazione delle violenze squadriste.
Incuriosito dal fatto che tante citazioni da storici antifascisti concorressero a produrre una voce enciclopedica di tutt’altro orientamento, a partire dal dicembre 2012 ho cominciato a verificare la corrispondenza tra il testo e le fonti. E’ un lavoro impegnativo, data l’ingente quantità di riferimenti presenti nella pagina; i risultati, tuttora parziali, che ho ottenuto finora li potete leggere (se ne avete voglia) nella corrispondente pagina di discussione.

Mimmo Franzinelli. Con omissioni e taglia-e-cuci, si trasforma la sua denuncia dello squadrismo in una mezza assoluzione.
Uno dei casi più bizzarri è quello relativo a una citazione dall’eminente storico britannico Adrian Lyttelton, chiamato in causa a supporto dell’asserzione secondo cui lo squadrismo sfruttava la borghesia «per la crescita del movimento», quando invece Lyttelton, alla pagina citata, scrive l’opposto, che cioè «i capi del primo fascismo concedevano i loro servizi ai loro protettori del ceto borghese”» (quindi, secondo Lyttelton, erano semmai i borghesi a sfruttare gli squadristi, e non viceversa). Anche De Felice e Salvemini vengono interpretati in modo similmente “libero”. Peculiare è il caso di Mimmo Franzinelli: chi ha letto il suo libro (Mimmo Franzinelli, Squadristi. Protagonisti e tecniche della violenza fascista 1919-1922, Mondadori, Milano 2003) sa che si tratta di un testo serissimo, documentatissimo, nel quale la violenza squadrista viene accuratamente descritta e denunciata in tutta la sua crudezza. Poco di tutto questo traspare dalla voce, in cui Franzinelli è perlopiù citato per certe sue osservazioni incidentali, di valore decisamente secondario nell’economia del testo, che però sembrano andare in senso giustificazionista.
A onor del vero, bisogna dire che non è Mastrangelo l’autore di questi stravolgimenti delle fonti. Ad esempio, il passo manipolato di Salvemini è stato inserito da Jose Antonio (che però si è limitato a citare un testo di Giordano Bruno Guerri dove la manipolazione era già presente), mentre i richiami a De Felice e a Lyttelton sono stati inseriti da Barbicone. Di questo Barbicone (un utente che risulta inattivo su it.wiki dal 2011) un altro utente, in pagina di discussione, ha affermato l’appartenenza a Casa Pound, affermazione non smentita dall’interessato. Nella stessa pagina Mastrangelo osserva con compiacimento che Barbicone «sta rapidamente diventando il principale contributore della voce».
E’ comunque strano che uno storico di professione – come Mastrangelo ama definirsi – non si sia accorto, in una voce da lui tenuta sotto stretta osservazione, di questo uso molto discutibile di fonti che sono tutte ben note agli specialisti. Così come è strano che Mastrangelo, che sopra abbiamo visto essere così sensibile al problema del “razzismo ideologico”, non si sia posto qualche dubbio sulla qualità dell’apporto di un «principale contributore» il quale, per avvalorare il proprio uso del concetto di guerra civile, osserva che persino «gli storiografi antifascisti ed ebrei parlano di “guerra civile”». (corsivo mio).
Passiamo ora a una voce alla cui redazione Mastrangelo ha contribuito in modo significativo. Questa è l’ultima redazione della voce Fascismo prima del ban.
Le due sezioni intitolate La creazione dell’uomo nuovo e Il mito del Sangue contro l’Oro sono state inserite da Mastrangelo, rispettivamente il 13 gennaio e il 3 febbraio 2008. Sono referenziate in modo assai sommario (fra l’altro con la citazione di un libro dello stesso Mastrangelo). La prima sezione è una disamina del tentativo fascista di «riformare eugeneticamente» il popolo italiano, tentativo che Renzo De Felice definì «moralmente ripugnante» e sul quale Emilio Gentile (Emilio Gentile, Fascismo. Storia e interpretazione, Laterza, Roma-Bari 2002, pp. 235-64) ha scritto pagine esaurienti mettendone in luce le aberranti caratteristiche: l’intolleranza, il razzismo, l’antisemitismo, il militarismo, il nazionalismo imperialista, il maschilismo, spinti all’eccesso dalla delirante e ossessiva ambizione personale mussoliniana.

Senza per nulla rifarsi a questi due storici, Mastrangelo scrive sull’argomento alcuni paragrafi, leggendo i quali si direbbe che la maggiore pecca di tale programma fu il fatto di aver fallito il proprio obiettivo:
«L’uomo nuovo immaginato dai pensatori fascisti era essenzialmente un modello anti-borghese: giovanile, vigoroso, rude, pragmatico, strafottente, disciplinato. Legato alla tradizione e contemporaneamente proiettato nell’epoca della macchina. Un misto di legionario e colono romano e di aviatore futurista.»
La sezione intitolata Il mito del Sangue contro l’Oro espone con una certa ampiezza, mantenendo una alquanto breve distanza critica, tutta una serie di luoghi comuni antisemiti tipici della propaganda della repubblica di Salò.
A proposito di strafottenza: qui e qui possiamo ammirare Mastrangelo mentre inserisce tutti i dettagli dell’eroica azione delle camicie nere ai danni del deputato comunista Francesco Misiano.
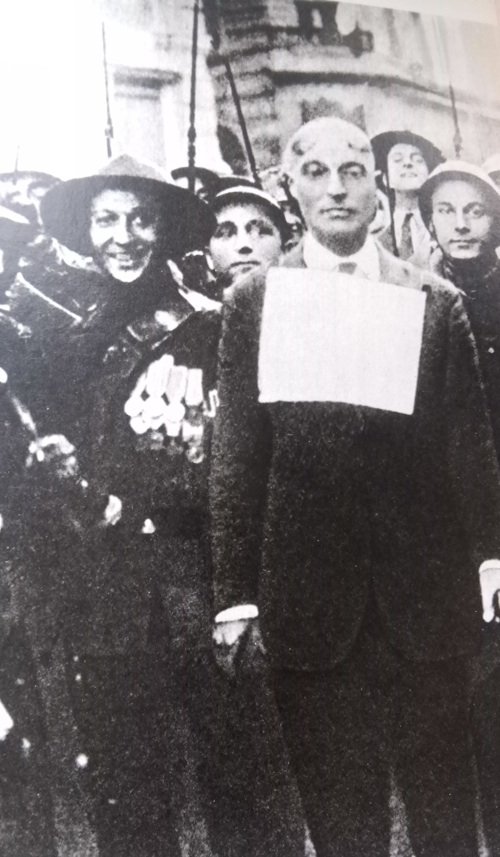
Roma, 13 giugno 1921. Il deputato comunista Francesco Misiano viene picchiato, rapato a forza e costretto a sfilare per le vie con un cartello al collo – «La patria va servita e io sono fascista» – mentre due ali di squadristi lo insultano e prendono a sputi. È l’idea di «azione eroica» che hanno i camerati. Misiano, peraltro, è un personaggio interessantissimo. Sarebbe tempo di recuperare la sua storia e ri-narrarla. Clicca sulla foto per aprire la voce che gli dedica il Dizionario biografico Treccani.
Una voce creata da Mastrangelo nel gennaio 2010, Battaglia di Tarnova, ha costituito oggetto di una discussione piuttosto accesa tra lo stesso Mastrangelo e Piero Montesacro (Montesacro ha avuto un ruolo importante nel procedimento di espulsione di Mastrangelo ed è ora bersaglio di numerosissimi strali polemici nel libro che sto recensendo: cfr. in particolare, per la discussione sulla voce Battaglia di Tarnova, le pp. 243-6). Tale discussione è ricordata nel libro soprattutto a proposito di una rispostaccia, certamente piuttosto scortese, rivolta da Montesacro a Mastrangelo; il libro, però, dimentica di menzionare il merito della questione, cioè il dato di fatto (ancora oggi ben visibile) di una voce enciclopedica, costruita prevalentemente utilizzando fonti di parte repubblichina, su di un episodio bellico di secondaria importanza il cui unico rilievo consiste nell’essere stato ampiamente ripreso nel dopoguerra da una certa propaganda di estrema destra.

Staffetta partigiana a cavallo nella zona tra Gorizia e Tarnova / Trnovo. Foto scattata nella primavera del 1945 dal nonno del giapster Tuco.
Battaglia di Tarnova è una voce enciclopedica nella quale, fra l’altro, i nazifascisti vengono quasi sempre indicati come «gli italiani» o «gli italo-tedeschi», mentre i loro avversari (fra cui la divisione partigiana italiana «Natisone» e la brigata partigiana «Triestina») sono designati come «partigiani», «forze partigiane» o «iugoslavi». Scelta terminologica solo apparentemente neutra, che in realtà sortisce l’effetto di nascondere il carattere internazionalista, o anche solo internazionale, della lotta al nazifascismo. Vi erano, come si sa, migliaia di italiani che combattevano nella resistenza jugoslava, così come c’erano migliaia di iugoslavi che combattevano nella resistenza italiana. Una variante di tale punto di vista è quella espressa in pagina di discussione dall’utente Presbite, il quale lascia intendere che gli italiani della «Natisone» e della «Triestina» erano, secondo lui, dei traditori della patria al soldo di una potenza straniera, né più né meno degli italiani della X Mas.
Altra voce ancora oggi fortemente caratterizzata dall’intervento di Mastrangelo, e menzionata nel libro (pp. 216-9), è quella dedicata all’ Attentato di via Rasella, in cui, in una apposita sezione denominata «Controversie», sono esposte con un esagerato rilievo le più inverosimili versioni complottiste della pubblicistica di destra, trattate alla stregua di «fonti» cui viene indebitamente conferita pari dignità rispetto alle vere fonti storiografiche.
Senza commentare ulteriormente, riporto qui la motivazione ufficiale dell’espulsione da it.wiki comminata a Mastrangelo: «uso quantomeno disinvolto e fuorviante, quando non direttamente contestabile delle fonti, problema aggravato dal diffuso POV, dalla presenza costante di ricerche storiche originali e dalla reiterazione di quanto già altre volte segnalato».
Con questo, naturalmente, non intendo attribuire al solo Mastrangelo la responsabilità di aver scritto voci seguendo un punto di vista poco “neutrale”. Potrei menzionare vari altri esempi dovuti ad altri contributori. Uno dei casi più recenti è quello della voce Roberto Farinacci; eccone la versione contro cui un anonimo utente di lingua inglese ha protestato, nel marzo 2013, definendola senz’altro «a piece of propaganda».
Uno dei principali redattori di questa versione della voce è Jose Antonio, il quale sembra aver operato secondo molto discutibili criteri di scelta delle fonti. Con l’effetto, fra l’altro, di minimizzare il feroce antisemitismo del gerarca di Cremona e di glorificarne la morte mediante l’uso di toni francamente agiografici.

Culatte al vento: Rodolfo Graziani
In altri casi, l’opera di POV-pushing (l’imporre a tutti i costi il proprio punto di vista) condotta da Mastrangelo è stata validamente proseguita, dopo la sua espulsione, da altri utenti. Mi riferisco in particolare al modo in cui Wikipedia riferisce dei crimini del colonialismo italiano in Africa. Fra i vari esempi che si potrebbero citare, se in questa discussione possiamo vedere Mastrangelo mentre minimizza e relativizza l’uso dei gas in Etiopia, in quest’altra troviamo Josè Antonio difendere a spada tratta la reputazione postuma del generale Rodolfo Graziani, con una tenacia veramente degna di miglior causa (l’arco dei suoi interventi si estende dal 2009 al 2013).
Wikipedia, la presbiopia, il fascismo di confine
Fra gli utenti che hanno più calorosamente difeso Mastrangelo nella sua procedura di ban, ne troviamo uno che Mastrangelo & Petrucci citano più volte, con grande favore, nel loro libro. Si tratta di Presbite, definito «uno dei migliori contributori di Wikipedia in italiano, perseguitato su quella in inglese dalla cricca croata» (pag. 300). E’ forse lo stesso utente già menzionato a pag. 56, dove si afferma che alcuni anni fa «sulla Wikipedia in lingua inglese un gruppo di nemmeno cinque utenti croati o filo-croati riusci[va] a tenere in scacco le voci su Istria, Dalmazia, Repubblica di Ragusa, impedendo de facto gli edit di utenti italiani, portando persino al ban (espulsione) di uno di essi, che peraltro è uno dei migliori e più stimati utenti della Wikipedia in lingua italiana».
Presbite è l’utente che, nella discussione relativa alla voce Narodni Dom, interviene minimizzando la valenza storica dell’attacco squadrista del 13 luglio 1920, quello che Renzo De Felice definisce «il vero battesimo dello squadrismo organizzato». Secondo Presbite, invece, si sarebbe trattato solamente di uno dei tanti episodi di un pluridecennale, se non secolare, conflitto etnico tra italiani e slavi. Passa in secondo piano, secondo questa interpretazione, la singolarità dell’episodio e il suo essere atto fondativo del fascismo di confine.
Notevole il fatto che la lettura di Presbite coincide nelle sue linee essenziali con quella proposta da Paolo Sardos Albertini, presidente della Lega Nazionale (la storica associazione neo-irredentista triestina), in questo articolo.
Nel corso della discussione, Presbite tenta di accreditare questa sua linea interpretativa che chiameremo della “faida interetnica” citando, non certo Paolo Sardos Albertini, bensì un testo storiografico autorevole e di sicuro valore (AA. VV., Un percorso tra le violenze del Novecento nella Provincia di Trieste, a cura dell’Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia, Trieste 2006, ISBN: 88-95170-02-4, reperibile on line a questo indirizzo. Quando però l’utente TBPJMR gli fa notare che tale fonte non avvalora affatto l’interpretazione della “faida interetnica”, ma anzi la contraddice espressamente, ecco che Presbite glissa:
«TBPJMR: […] l’interpretazione dell’incendio quale anello di una catena di “episodi simili” che si dipanano a partire dal 1866, è appunto una interpretazione. Accanto a questa interpretazione, la maggior parte delle interpretazioni attribuisce invece all’incendio del Narodni Dom un carattere periodizzante, lo considera […)]un evento fondante per il fascismo di confine, e un punto di svolta nei rapporti tra fascisti, esercito, e pezzi dello Stato.
Presbite: […] Venendo al discorso della concatenazione delle violenze, già anni fa sono stati pubblicati dei saggi sulla sequela delle violenze a Trieste fra la metà del XIX secolo e il secolo successivo. Anche questi sono semplici fatti, non opinioni. A meno che non si ritenga che tutto nacque improvvisamente quel giorno lì, a Trieste.
TBPJMR: Che a Trieste ci siano state violenze nei 50 anni precedenti all’incendio del Narodni Dom è fuori di dubbio. Ma costruire una certa concatenazione piuttosto che un’altra è appunto una interpretazione storiografica. Per esempio: inserire in questa concatenazione lo sciopero del LLoyd del 1902, i disordini del 23-24 maggio del ‘15, e l’incendio del Narodni Dom, come suggerivi nel 2007, a me sembra piuttosto arbitrario.
Presbite: Con tutto il rispetto per la tua legittima posizione, ti segnalo che proprio questa concatenazione non è frutto della mia fervida immaginazione, ma di un noto lavoro a più mani sulla violenza a Trieste nel ‘900. Un testo pubblicato, cui parteciparono alcune fra le migliori firme del nostro tempo, relativamente a quell’ambito storico.
TBPJMR: Scusa Presbite, ma nella prefazione del famoso lavoro a più mani (Un percorso fra le violenze del Novecento nella provincia di Trieste) c’è scritto: […] “Episodi di violenza politica non sono mancati a Trieste nei decenni precedenti: (…) Si trattava appunto, però, di episodi, che proprio per questo fecero scalpore in una città abituata al rigido legalismo austriaco, che impediva il deragliamento dei conflitti, aspri solo a parole. Con la Grande guerra invece, tutto cambiò.”
Presbite: Purtroppo non ho molto tempo, se non per dirti che sono contento che tu abbia trovato la fonte di cui parlavo, che elenca i fatti violenti accaduti a Trieste in vari decenni.»
Presbite è sempre lo stesso utente che nella discussione relativa alla voce T.I.G.R. (l’organizzazione armata antifascista che, durante il ventennio, si batté contro la politica di oppressione nazionale nei confronti di sloveni e croati), è intervenuto massicciamente fra l’ottobre 2012 e il marzo 2013 «spaccando il capello non in quattro, ma in ottantaquattro» (per usare la sua stessa espressione), postando interventi chilometrici con lo scopo apparente di ostacolare una riscrittura della voce, che in precedenza era fortemente sbilanciata in senso denigratorio.
L’intervento in voce di Presbite è avvenuto in seguito a una doppia sollecitazione: una prima volta da parte di Theirrules (19 settembre 2012) e una seconda volta da parte di AleR (22 gennaio 2013), utenti entrambi molto interessati a che il T.I.G.R. non venisse posto in una luce troppo positiva.
Il libro inesistente: Assassini nella storia
Presbite, che vediamo durante tutta la discussione mostrare una eccezionale acribia nel vagliare le fonti proposte dai suoi contraddittori, si è dimostrato però molto meno pignolo quando sono state poste in questione alcune fonti inserite in voce da suoi amici. Mi riferisco in particolare al fantomatico testo di «Samuel Frederick J.», Assassini nella storia, Editgroup S.R.L, Udine, 1994, inserito in bibliografia da AleR nel novembre 2009 e poi più volte richiamato e citato dallo stesso AleR sia in discussione che nell’editare la voce.
Con Assassini nella storia ci troviamo un passo oltre la falsificazione delle fonti: infatti si tratta di un libro mai esistito di un autore parimenti immaginario, che si asserisce essere stato stampato nel 1994 da una casa editrice che in quel periodo non esisteva ancora. La circostanza è stata chiarita sia nella discussione della voce T.I.G.R., sia successivamente nel procedimento contro AleR (per questa e altre violazioni delle regole di Wikipedia) che ha portato all’espulsione definitiva di questo utente da it.wiki.
Anche in questo caso, prevedibilmente, l’espulsione di AleR è avvenuta con il voto contrario di Presbite. Non so dire se, come Mastrangelo, anche AleR abbia in seguito scritto libri e articoli per lamentare la persecuzione politica ai suoi danni da parte della «cricca» bolscevica.
La fonte nascosta: Giorgio Rustia
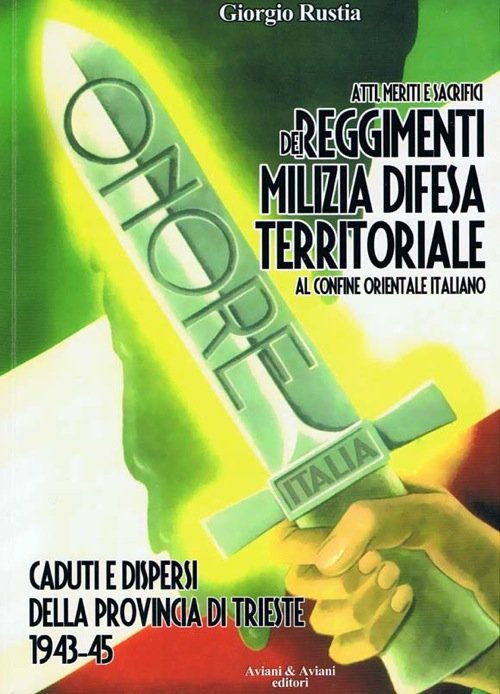
Al di là del caso plateale di Assassini nella storia, che è costato l’espulsione ad AleR, è molto interessante analizzare in dettaglio a difesa di cosa AleR avesse chiamato Presbite. La pagina sul TIGR, prima dei parziali interventi di riscrittura dell’inverno 2012/13, era rimasta blindata per anni (si veda la cronologia delle modifiche) in queste condizioni.
Come si può vedere, non c’era nessun riferimento al fascismo. Ogni tentativo di inserire l’aggettivo «antifascista» nella descrizione dell’organizzazione veniva cassato dai “guardiani” AleR e Theirrules nel giro di qualche ora. E l’intero testo della voce era praticamente privo di fonti. O meglio… apparentemente privo di fonti. Infatti ad un’analisi minuziosa, ci si accorge ad esempio che questa parte del testo:
«Il 3 agosto 1928 venne assassinato a San Canziano il vigile urbano Giuseppe Cerquenik, mentre il 25 dello stesso mese venne incendiato il ricreatorio della Lega nazionale di Prosecco.
A Gorizia il 22 settembre, vengono uccisi lo studente Antonio Coghelli, per aver abbandonato le organizzazioni irredentistiche slovene, ed il soldato Giuseppe Ventin, che era intervenuto cercando di impedire l’attentato contro Coghelli.
Nel 1929 morì durante un agguato il contadino Francesco Tuchtan, mentre un altro rimase gravemente ferito. Venne condannato per il crimine il reo confesso Vladimir Gortan di Vermo, presso Pisino, quale “capo dei terroristi slavi”. Venne fucilato il 18 ottobre 1929 vicino a Pola, mentre quattro suoi compagni di Pisino vennero condannati a 25 anni di carcere ciascuno.»
assomiglia moltissimo a questo passo tratto da un pamphlet di Giorgio Rustia:
«Il 3 agosto 1928, fu assassinata a tradimento la guardia municipale di San Canziano, Giuseppe Cerquenik.
Alla fine dello stesso mese fu incendiato il ricreatorio della Lega Nazionale di Prosecco, e, dopo pochi giorni, ai primi di settembre, fu incendiata la scuola di Storie
Infine, il 22 settembre, a Gorizia, furono uccisi lo studente Coghelli (che aveva abbandonato le organizzazioni irredentistiche slovene) ed il milite Ventin che aveva cercato di fermare l’assassino del Coghelli.
Nel 1929, le violenze slave si manifestarono, in gennaio, con la devastazione dell’asilo infantile di Fontana del Conte, mentre nel marzo ci fu l’assassinio, a Vermo, di Francesco Tuchtan. Il responsabile dell’omicidio, tale Vladimiro Gortan, reo confesso, fu processato e giustiziato, come sarebbe avvenuto in qualsiasi altro stato del mondo, a chi si fosse macchiato di un omicidio.»
Oltre al “wording” (che a tratti è identico), ciò che accomuna i due testi sono le fantasiose italianizzazioni dei nomi (Coghelli per Kogoj, Francesco Tuchtan per Ivan Tuchtan…), gli errori nelle date (“Coghelli” fu ucciso il 21 agosto 1928 e non il 22 settembre 1928. Cerkvenik fu ucciso 16 maggio 1928, e non il 3 agosto), … e il fatto che gran parte delle affermazioni siano o false o comunque esposte nella medesima maniera incompleta e/o mistificatoria. Per esempio: “Coghelli” (che era un informatore della polizia) fu ucciso dal comunista Bregant e non da un membro del TIGR. Altro esempio: Gortan non organizzò un agguato per uccidere Tuchtan, ma un’azione armata di disturbo del plebiscito del marzo 1929, e nel corso dell’azione Tuchtan fu colpito accidentalmente da una pallotola vagante.
Perché è importante osservare che una delle fonti occulte della voce sul TIGR era proprio il pamphlet di Rustia? Per due motivi: primo, perché la tesi del pamphlet è che ci fosse un progetto secolare degli “slavi” per annientare gli italiani dell’adriatico orientale. Secondo, perché Rustia non è uno storico, ma un tipico rappresentante di quel demi-monde triestino che si muove tra associazionismo degli esuli ed estrema destra. Un autore forse poco adatto ad essere citato esplicitamente come fonte per l’enciclopedia libera; molto adatto, invece, se si vuole fare di quest’ultima una tribuna per propagandare determinate ideologie.
«Non meritevole di rilievo enciclopedico», disse il falsario
Lo stesso utente AleR che nell’ottobre 2009, nella voce sul TIGR, ha usato come fonte (occulta, perché al di sotto degli standard di autorevolezza richiesti dall’Enciclopedia) il pamphlet di Rustia; questo stesso utente lo ritroviamo, nell’agosto 2011, votare a favore della cancellazione della voce Claudia Cernigoi, studiosa che AleR per l’occasione definisce «negazionista» e valuta come non meritevole di rilievo enciclopedico.
Nella discussione è richiamata la lettera aperta nella quale Cernigoi, sempre nell’agosto 2011, denunciò con toni particolarmente aspri e risentiti il trattamento, da lei vissuto come ingiusto e denigratorio, riservatole su it.wiki.
Una pallida eco di queste polemiche si trova anche nel libro di Mastrangelo & Petrucci, in cui Claudia Cernigoi viene definita «pubblicista triestina (…) nota per le sue posizioni radicali sul problema delle foibe» (pag. 306; corsivo mio). Naturalmente, per Mastrangelo & Petrucci Cernigoi è una semplice pubblicista, laddove, come abbiamo visto, Giorgio Pisanò viene insignito della qualifica di storico.
Contro «i s’ciavi» e i loro nomi complicati
Su varie voci, in it.wiki, aleggia più di un sospetto di revanscismo anti-slavo. Mi riferisco ad alcune pagine relative ai Comuni della Venezia Giulia soppressi.
Nel caso di alcune città e paesi appare giustificato che, sulla Wikipedia in lingua italiana, essi siano designati col toponimo in italiano (Groznjan-Grisignana, Koper-Capodistria): l’Istria, come è noto, ha una geografia linguistica complicatissima, e le città sulla costa occidentale sono bilingui anche per statuto. Lascia invece parecchio perplessi il fatto che, in altri casi, si usino i toponimi italiani inventati negli anni Venti, imposti d’ufficio a paesi che storicamente avevano solo il toponimo sloveno o croato, o al massimo tedesco. Come nel caso di Skopo che diventa Scoppo, con due P (evidentemente il funzionario non voleva avere problemi con la buoncostume).
Un episodio di indebita attribuzione del nome italianizzato è quello dell’aviatore Edvard Rusjan, ribattezzato “Eduardo” su it.wiki. Nella pagina di discussione della voce Simon Gregorčič troviamo il sullodato utente AleR tentare di negarne la nazionalità slovena.
E’ insomma una casistica esattamente speculare a quella denunciata da Mastrangelo & Petrucci in relazione a en.wiki, dove (a loro dire) una «cricca croata» avrebbe negli anni scorsi proceduto a «bandire ogni attributo di italianità [sic]» a determinati personaggi storici della Dalmazia, attuando una «pulizia etnica priva di vergogna» (pag. 56). In questo caso i nostri due autori hanno puntato i loro fari sulla Wikipedia inglese, forse perché trovano, invece, abbastanza soddisfacente la situazione di quella italiana.
Complotto!
Mastrangelo & Petrucci scrivono, a pag. 287 del loro libro, che «per circa tre anni – dal 2008 al 2011 – la cosiddetta “Cricca” è stata una cappa plumbea che ha coperto Wikipedia in italiano». Si riferiscono ovviamente alla «cricca» comunista che, secondo loro, opprimerebbe it.wiki.
In un suo ormai classico studio, Alessandro Portelli descrive alcune caratteristiche della pubblicistica storiografica di estrema destra nel dopoguerra italiano: il vittimismo, il ricorso a teorie del complotto, la denuncia sensazionalistica delle presunte “menzogne” della storiografia “ufficiale”. Tali caratteristiche, secondo Portelli, sono funzionali allo scopo di avvalorare ricostruzioni storiche traballanti o senz’altro false, le quali però coincidono con i luoghi comuni qualunquisti della “maggioranza silenziosa” (Alessandro Portelli, L’ordine è già stato eseguito. Roma, le Fosse Ardeatine, la memoria, Feltrinelli, Milano 2012, pp. 329-33).

Milano, 20 agosto 1922. Il tram n.948, sequestrato e guidato dalle camicie nere, è il primo mezzo a forzare lo sciopero generale indetto «contro l’illegalismo fascista». Alla guida c’è Aldo Finzi. Di origine ebraica, a partire dal 1938 Finzi cadde in disgrazia, venne inviato al confino ed espulso dal PNF. Nel 1943 si avvicinò alla Resistenza romana. Catturato dai tedeschi, finì trucidato alle Ardeatine. Quanto alla vettura del fascismo, proseguì la corsa fino a Piazzale Loreto. Come si vede nella foto, la destinazione era sempre stata quella.
Che esista un “complotto” di sinistra ai danni di Wikipedia è tutt’altro che dimostrato dal libro di Mastrangelo & Petrucci. Se volessi per un momento fare ricorso alla stessa retorica complottistica cui talvolta indulgono i due autori, basandomi sull’esame delle voci enciclopediche di cui ho parlato sopra, e di altre ancora che non ho menzionato per motivi di spazio, potrei addirittura sostenere che ci siano elementi per sospettare l’esistenza di una “cricca di destra”. Si potrebbe cioè sostenere che negli scorsi anni ci sia stato in it.wiki un tentativo organizzato da parte di vari utenti, molto caratterizzati ideologicamente, di imporre in varie voci di it.wiki un punto di vista accentuatamente destrorso; e che Emanuele Mastrangelo sia stato per così dire la “punta di lancia” di questa offensiva.
In realtà non credo nell’esistenza di alcuna “cricca”. D’altronde non condivido affatto la visione di Wikipedia di Mastrangelo & Petrucci: secondo loro Wikipedia sarebbe una realtà di per sé “sana”, priva di difetti, di limiti e di contraddizioni, se non fosse appunto per la nefasta “cricca” degli admin di sinistra, un «pugno di furfanti» che spadroneggia, opprime ecc. ecc. Basterà eliminare questa cricca, o casta, ed ecco che in Wikipedia tornerà a regnare l’armonia e tutto funzionerà a puntino.
Riconosciamo in tale concezione una classica idea di destra: quella secondo cui la società (in questo caso la comunità dei wikipediani) può e deve essere «unita, armoniosa, concorde, e se non lo è (più) la colpa è di forze estranee, intrusi, nemici che si sono infilati e confusi in mezzo a noi e ora vanno ri-isolati e, se possibile, espulsi, così la comunità tornerà unita».
Contro tale concezione, che è allo stesso tempo utopica e reazionaria, si deve ogni volta riaffermare una verità molto semplice. In qualsiasi comunità umana si confrontano e si scontrano opinioni, modi di pensare e concezioni del mondo contrastanti fra loro; si crea, anche spontaneamente, una pluralità di aggregazioni, che possono essere più o meno stabili, fra individui che condividono uno stesso modo di vedere; ed esiste inevitabilmente una dialettica fra queste aggregazioni. Vale a dire che in ogni comunità umana esiste la politica.
Non c’è nulla di scandaloso, e non vi è pertanto nessun bisogno di denunciare cricche o complotti ogni volta che in Wikipedia vediamo manifestarsi tale dialettica attraverso schieramenti ben riconoscibili di utenti. Il massimo che si può pretendere è che il gioco sia leale, e avvenga secondo le regole che la comunità stessa si è data. E’ giusto, inoltre, che la comunità dei wikipediani si difenda, con ogni mezzo necessario, contro i giocatori che barano.
Un aspetto di it.wiki può apparire sorprendente, e può forse contribuire alla falsa impressione dell’esistenza di cricche o camarille: gli utenti che vediamo schierati nelle discussioni su it.wiki a proposito di determinati argomenti sembrano pochi e sempre gli stessi.
Per capire questa realtà di Wikipedia, però, più di qualsiasi teoria del complotto può essere utile partire da alcune statistiche, effettuate dagli stessi Mastrangelo & Petrucci (non le ho verificate, ma le ritengo verosimili). Il 15 novembre 2013, gli utenti registrati di it.wiki erano 944.130, ma di essi solamente 7.751 potevano essere considerati attivi (laddove per utente attivo s’intende un utente che abbia effettuato almeno cinque modifiche in un mese: pp. 166 e 186). Di questi utenti attivi un po’ più di cento, vale a dire uno ogni 73, sono gli admin (pp. 166, 227 e 233). Molto spesso sono eletti admin candidati proposti da altri admin (p. 268). Arrotondando fortemente questi dati, Mastrangelo & Petrucci scrivono che solo l’1% degli iscritti è attivo e, di quelli attivi, meno del 2% «si occupa della vita comunitaria» (p. 388).
Si aggiunga a questi dati la considerazione che l’attività di ciascun utente di Wikipedia tende spesso a concentrarsi sui pochi argomenti di suo interesse, e si capirà come mai tante discussioni in it.wiki appaiano come un campo da gioco frequentato sempre dagli stessi giocatori.
Posti di fronte a questa realtà, e alquanto frustrati per il fatto che i giocatori «non-di-sinistra» in it.wiki perdono (ai loro occhi) troppe partite, ecco che Mastrangelo & Petrucci sfoderano il loro asso nella manica. Come a volte negli stadi di calcio, quando il risultato della partita non soddisfa una delle tifoserie, questa pensa bene di risolvere il problema con una massiccia invasione di campo; allo stesso modo Mastrangelo & Petrucci vogliono ribaltare l’esito della partita mediante l’intervento en masse su Wikipedia della «maggioranza (non più) silenziosa».
Le ultime pagine del libro sono una vera e propria chiamata alle armi affinché la “società civile” in tutte le sue espressioni (scuole, mass media, intellettuali di ogni ordine e grado) rivolga la propria attenzione a Wikipedia e inizi a collaborare attivamente alla redazione dell’enciclopedia libera.
Un appello che – al di là delle posizioni politiche di Mastrangelo & Petrucci – mi sento di condividere. I due autori parlano apertamente di lotta per l’egemonia culturale sulle pagine di Wikipedia (ancorché utilizzando una citazione di Gramsci un po’ farlocca, come abbiamo visto sopra). All’uopo, i nostri due autori hanno redatto un intero capitolo di tecnica militare, eloquentemente intitolato «Prontuario di resistenza & guerriglia wikipediana» (p. 321-8).
Consiglierei loro di non essere così ottimisti sull’esito finale. Non è detto che la loro «maggioranza silenziosa» di italiani «non-di-sinistra» (vale a dire di destra tout court) esista veramente, né che abbia la voglia, o le capacità, di dedicare parte del proprio tempo ad una attività volontaria alquanto impegnativa come la redazione delle voci di Wikipedia.
E’, dunque, tutto da vedere se la chiamata alle armi di Mastrangelo & Petrucci risulterà efficace nei confronti dell’utenza di destra cui essi si rivolgono, e se il librò riuscirà nel suo intento di suscitare la lotta per l’egemonia che i due autori auspicano.
Tuttavia, come osserva Sun Tzu, «l’arte della guerra non consiste nel confidare che il nemico non verrà, ma nella sicurezza di accoglierlo adeguatamente». Ritengo in ogni caso auspicabile che tutti noi antifascisti, wikipediani e non, esercitiamo una doverosa attività di vigilanza sulle pagine dell’enciclopedia libera. La quale è una piazza, ancorché virtuale: e, come tutte le piazze, perché le camicie nere non se ne impossessino ha bisogno della nostra presenza.
Ringrazio Martino Prizzi per la preziosa consulenza sul tema del fascismo di confine.

 Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)
Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)
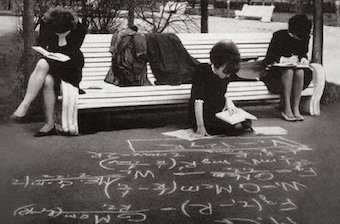

Un interessante caso da studiare è quello della voce “Giovanni Palatucci” e della relativa pagina di discussione.
Per chi non lo sapesse, Giovanni Palatucci fu un funzionario della questura di Fiume tra il 1937 e il 1944. In particolare, ricoprì la carica di reggente della questura durante il periodo dell’ Adriatische Kuestenland, dall’ 8 settembre del ’43 fino alla sua deportazione a Dachau, nell’autunno del ’44. Nel dopoguerra, proprio per il fatto che Palatucci finì i suoi giorni a Dachau, la sua figura si prestò perfettamente ad un’opera di falsificazione storica che lo trasformò nel prototipo del “fascista buono”. Di lui si disse che aveva salvato ben 5000 ebrei, e gli furono dedicate piazze e strade in tutta Italia, tra cui quella che a Trieste conduce alla Risiera di San Sabba, unico campo di sterminio nazista in Italia e oggi museo della Shoah.
Nel 1995 tuttavia lo storico triestino Marco Coslovich cominciò a mettere in dubbio la veridicità del mito di Palatucci. E nel 2008, dopo un lavoro di ricerca decennale, Coslovich pubblicò il libro “Giovanni Palatucci. Una giusta memoria” in cui smontava completamente il mito di Palatucci:gli ebrei salvati da Palatucci non sarebbero stati più di 5, e si sarebbe trattato in ogni caso di favori personali nei confronti di alcuni suoi superiori di grado. L’estate scorsa, alcuni ricercatori del Primo Levi Centre di New York hanno annunciato la scoperta di nuovi documenti, che oltre a confermare le ricerche di Coslovich, attribuiscono addirittura a Palatucci il ruolo di solerte esecutore delle direttive tedesche per la deportazione degli ebrei fiumani, caduto poi in disgrazia per una storia di spionaggio.
Fino all’estate scorsa, la voce wiki su Palatucci aveva mantenuto la sua impostazione agiografica, nonostante gli interventi nella pagina di discussione dello stesso Coslovich già nel 2007, e di Natalia Indrimi (del PLC di New York) nel 2012 ne avessero suggerito la revisione, alla luce delle ultime ricerche pubblicate. L’estate scorsa, quando la notizia delle ricerche del PLC è arrivata al grande pubblico in seguito alla pubblicazione sulla Stampa e sul Corriere di alcuni articoli di Alessandra Farkas, finalmente qualcosa ha cominciato a muoversi anche su wikipedia. Alcuni utenti hanno cominciato a editare delle modifiche, suscitando la reazione di tale Nicola Romani, che insieme a Josè Antonio (citato anche nel post di Salvatore) ha tentato in tutti i modi di blindare la pagina (si vedano la cronologia delle modifiche e la pagina di discussione). L’edit war non è ancora finita, e ad oggi chi legge la voce su Palatucci si trova di fronte al paradosso di una biografia agiografica completamente priva di fonti, seguita da una sezione intitolata “controversie”, ricca invece di riferimenti bibliografici.
Interessante. E’ chiaro che su questo personaggio si è realizzata un’operazione agiografica attraverso la glorificazione di presunti beaux gestes ispirati da ideali con la maiuscola (la Pace, la Dignità umana …). Pare strano allora che, sebbene in possesso di dati storici che smontano simili falsificazioni, certuni si ostinino a perpetuare l’immagine del “buono”.
Non credi che il tentativo di mantenere la pagina di Wikipedia sostanzialmente invariata e neutrale (nell’accezione più negativa), rendendo sfuocate le vicende storiche e cristallizzando il passato all’interno di un quadro immutabile, sia funzionale a sostenere il mito di un’identità nazionale pacificata? Sempre gli “italiani brava gente” insomma.
Che poi è un elemento centrale della retorica di destra.
Beh, direi proprio di sì, visto che ancora nel 2014 la Polizia onora Palatucci in questo modo:
http://questure.poliziadistato.it/Trieste/articolo-6-631-63141-1.htm
Comincio con un paio di note fattuali:
* c’è un errore, quando viene detto “Wikipedia Italia”. “Wikipedia Italia” non esiste infatti il progetto Wikipedia ha più versioni (o “edizioni”) linguistiche, infatti più avanti viene detto correttamente correttamente “it.wiki (la versione in lingua italiana di Wikipedia)”. Il progetto Wikipedia è unico (ed è quello di creare un’enciclopedia libera) e ne esistono diverse versioni linguistiche, non su base nazionale (così come en.wiki, Wikipedia in inglese, non è Wikipedia USA o Wikipedia UK);
* Si possono trovare delle statistiche su Wikipedia – dato che si parlava di verificare i dati – a queste pagine:
** https://it.wikipedia.org/wiki/Speciale:Statistiche (si presti attenzione alla diversa definizione di “utente attivo” usata qui);
** dati più granulari, con anche lo storico ed alcuni grafici: https://stats.wikimedia.org/IT/ChartsWikipediaIT.htm e tabelle: https://stats.wikimedia.org/IT/TablesWikipediaIT.htm
** la “Report Card” di Wikimedia Foundation: http://reportcard.wmflabs.org/
ci sono numerose altre statistiche disponibili, un buon punto di partenza è questa pagina (in inglese): https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Statistics
Passo ora alle opinioni.
La situazione tratteggiata a proposito di Wikimedia Foundation (WMF): «Per esempio, il fatto che Wikipedia appartiene a un ente privato (sia pure senza fini di lucro) qual è la Wikimedia Foundation, ciò che, in astratto, la rende vulnerabile a rischi di tracollo economico o agli appetiti di grandi gruppi capitalistici, che potrebbero in futuro manovrare per appropriarsi di una potenziale fonte di profitti.»
è poco verosimile, secondo me, per i seguenti motivi:
1) Wikipedia non appartiene a WMF, non più di quanto appartenga a chiunque altro nel mondo – fatti salvi i loghi ed i trademark – Wikipedia è rilasciata con una licenza libera ed i dump sono disponibili (qui: http://dumps.wikimedia.org/). Se domani la situazione degenerasse – in qualsivoglia modo e per qualsivoglia motivo – non c’è nulla che impedisca a chiunque di forkare il progetto. Per referenza vedete cos’è successo con Wikivoyage vs Wikitravel (https://it.wikipedia.org/wiki/Wikivoyage#Storia) per cui la comunità ha detto: “ciao, ciao” e si è spostata.
2) Anche allo stato attuale, WMF non controlla Wikipedia. Viene usata la locuzione “run and operate” e non “manage”, proprio per rimarcare che Wikimedia Foundation non interviene sui contenuti ma fa in modo che i server continuino a girare (si veda https://wikimediafoundation.org/wiki/FAQ/en)
3) WMF non è una società quindi non si capisce come i “grandi gruppi capitalistici” potrebbero manovrare per prenderne il controllo. I membri del direttivo di WMF (Board of Trustees, https://wikimediafoundation.org/wiki/Board_of_Trustees) vengono eletti, in parte, dal movimento (2 posti eletti attraverso una community election e 2 posti eletti dai capitoli locali) ed in parte sono nominati dal resto del board;
4) La proprietà dei trademark, almeno in linea di principio, deve essere intestata a qualcuno che si incarichi di proteggerlo, quindi serve che esista un ente, come una associazione o, appunto, una fondazione, a cui venga intestato il detto marchio (questo è uno dei motivi per cui Wikimedia Foundation è stata creata;
5) non so quale potrebbe essere l’alternativa (cioè, se non fosse una fondazione non profit, visto quanto sopra, cosa potrebbe essere?);
6) il tracollo economico è un rischio a cui effettivamente Wikimedia Foundation è sottoposta (come qualsiasi ente/istituzione nel mondo), sta di fatto che vale quanto detto sopra al punto 1.
Scusate la prolissità.
Cristian Consonni
(incidentalmente Wikipediano, membro del direttivo di Wikimedia Italia e membro del Fund Dissemination Committee di Wikimedia Foundation)
Ci tengo a precisare che quelle sopra sono le mie opinioni personali e non sto parlando in nessuna veste ufficiale.
Grazie per le utili precisazioni, di cui naturalmente prendo atto e che non mi pare richiedano ulteriori commenti. Inviterei tutti i commentatori a focalizzarsi sugli argomenti principali del post.
Buongiorno, volevo solo dire un paio di cose su quanto questo post, teoricamente firmato da un terzo, assomigli tantissimo a tanti altri letti qui.
Mi spiego meglio.
Si parte da una recensione, che però serve solo come esempio o come trampolino di lancio per andare su altri temi. I temi sono uguali a quelli di tante altre pagine lette qui. Uguale e prevedibile è anche la dinamica di come si svilupperà questo post, con i diretti interessati che interverranno a loro difesa e saranno letteralmente sepolti da una mole ingestibile di commenti e controargomentazioni. Finché il blog non canterà vittoria contro i fascisti e si ripartirà per un altro giro fra qualche mese.
Ora, è cosa buona e giusta andare a stanare questa roba nera ovunque si annidi, e non vorrei dare l’impressione di pensare il contrario. Però a mio modesto parere qualche controindicazione c’è, e provo a buttare giù in un paio di righe su quali credo siano.
Essenzialmente, il fatto che si comincia a pensare in funzione della lotta, e che dunque si finisce a pensare più o meno con categorie talmente forti da rendere le voci quasi tutte uguali. Io leggo questo lungo testo su wikipedia ed oltre al fatto che mi dice molto più su i fascisti da tastiera che su wikipedia, ci ritrovo temi familiari, tanto che se togliessero l’autore lo potrei tranquillamente attribuire ai WM stessi o ad un qualsiasi altro guest blogger. Il nordest, i fascisti, la battaglia storiografica, il conflitto come segno di salute sociale, le dinamiche di gruppo, manca Furio Jesi ma direi che ci siamo.
Certo, la ripetitività è anche segno di pensiero vero e non occasionale. Però se si esagera, ed io credo che un po’ si esageri, altrimenti non avrei scritto questo commento, crea un’atmosfera settaria che a mio parere danneggia parecchio l’operazione che si vuole fare. Settarismo che si vede tutto nella chiamata alle armi finale, cosa che ho trovato davvero un po’ imbarazzante, per il paragone di un luogo di sapere con uno scontro di piazza. Ma va be.
Sono curioso di vedere come si svilupperà la discussione e la seguirò con interessa.
Ok. Torniamo alla sostanza del post, ora? Dietro questo scritto c’è un grosso lavoro di documentazione, Salvatore ci ha messo tempo e passione, indica un pericolo innegabilmente reale, lo fa con numerosi esempi concreti e linkando tutte le fonti. Forse merita che si parli di questo. Nel merito.
Che su Giap ci siano dei temi ricorrenti è un dato di fatto. Non so se possano dirsi sempre gli stessi, a me pare che siano piuttosto disparati. Quindi parliamo piuttosto di una certa tipologia di post su Giap, delimitiamo. E mi chiedo: da cosa sarebbe data l’atmosfera settaria? Dal fatto che si portino esempi pratici ricollegabili a temi o situazioni di cui ci occupiamo ricorrentemente? Dal tipo di argomentazioni? Io direi che un post come questo può essere ascritto al filone: “La rete non è buona in sé e per sé” o “la rete non è neutra, bensì un campo di battaglia”. Non vedo perché dovrebbe essere settario invitare a una sorveglianza su Wikipedia, laddove è evidente che certi fascistoidi si danno da fare per smussare le voci storiografiche a loro scomode. In realtà dovrebbe essere una pratica comune dei netattivisti che abbiano a cuore l’antifascismo. E’ settario l’antifascismo? Boh, forse di questi tempi lo sta diventando…
Precisazioni necessarie, però io vedo un forte rischio di “meta-discorso”, cioè che invece di parlare di quel che ha raccolto ed esposto Salvatore, si parli di altro: di noi, della questione se siamo settari oppure no, di cosa significhi “settario”, di cosa s’intenda per “ripetitività”, se la dinamica del tal thread somigli o meno alla dinamica del tal altro ecc. ecc. Questo sarebbe svilente per il lavoro di Salvatore e per la tematica che ha avuto il cuore di affrontare.
Non è un “rischio” di metadiscorso, è proprio un metadiscorso – almeno le cose che ho scritto io lo sono. Infatti l’ho buttata lì e vorrei vedere un po’ come si sviluppa la discussione, senza replicare eccessivamente, almeno per qualche giorno.
Beh, se ci fai caso, prima del tuo metadiscorso, i primi commenti erano su un altro caso concreto, il caso Palatucci. Doverosamente segnalato con documentazione, fonti citate, link. E se guardi sotto la mia precisazione al commento di Marco Barone, troverai la linea che stiamo tenendo nei confronti di Wikipedia in quanto tale. Puoi già farti una qualche idea di come ci piacerebbe si svolgesse il discorso, senza troppo “discorso sul discorso”.
Avete ragione a focalizzare l’attenzione e i commenti sul post di Salvatore, che merita grande attenzione per il lavoro che lui ha fatto. Anche il meta-discorso mi sembra però avere un interesse, magari sarà possibile riprenderlo in un secondo momento. Solo un parere la lettore appassionato!
Sono d’accordo, uno dei motivi per cui non seguo più giap è una certa retorica “da battaglia”, mi sembra ormai superata, rischia, nonostante le brillanti menti in gioco, di diventare un giochetto da intellettuali di sinistra.
L’impressione è che gli interlocutori del blog siano sempre gli stessi e che si finisca nel classico pantano sinistrorso, in cui ce la si canta e ce la si suona ma tutto dentro una simpatica gabbia di Faraday.
PS IMHO Wikipedia è senz’altro il più grande risultato della civiltà connessa.
Boris Pahor e giorno del ricordo ed altro
Questo articolo deve seriamente, nel senso letterale di serietà, indurre alla massima riflessione nonché azione.
Chi decide che una fonte storica è attendibile? Chi decide chi è storico e viceversa?
Per esempio alla voce giorno del ricordo, nel settore dedicato alla discussione http://it.wikipedia.org/wiki/Discussione:Giorno_del_ricordo
si scrive :” Per troll anonimo Scotti, Kersevan e altri sono storici che hanno la piena credibilitá internazionali, lo so che magari ad alcuni revisionisti fascisti da fastidio parlare di queste cose, ma il loro parere non puo essere rimosso–Mantenuto (msg) 21:07, 2 mar 2012 (CET) Ma per piacere. Non sono storici e a loro non viene dato nessun credito. Leggiti Wikipedia:Ingiusto rilievo. Se vuoi scrivere di queste cose fallo in Negazionismo delle foibe–93.44.39.70 (msg) 21:11, 2 mar 2012 (CET)”
No, sono storici cerca le loro pubblicazioni….che sia ingiusto rilievo é solo una tua illazione e NON é negazionismo delle foibe perché essi dicono che esse sono esistite”
Recentemente, per l’iniziativa ronchi dei partigiani, siamo andati, con il gruppo, ad intervistare Boris Pahor, lui ha ribadito più volte, cosa che abbiamo archiviato nella nostra video intervista che sarà visibile il giorno 14 giugno 2014 a Ronchi nel convegno storico che realizzeremo, che è stato il primo a mobilitarsi contro il giorno del ricordo e che addirittura ha rifiutato l’invito a cena con il Presidente della Repubblica perché, egli, il presidente, mai ha affrontato seriamente questa problematica.
Pahor ha definito il giorno del ricordo come una legge non europea.
Per la cronaca sostiene anche lui la rimozione della denominazione dei legionari di Ronchi e questa cosa darà a molti sicuramente fastidio.
Ma alla voce giorno del ricordo non si cita lui come oppositore, anzi vi è di peggio. Alla voce dedicata alla sua pagina
http://it.wikipedia.org/wiki/Boris_Pahor
hanno collocato una foto a dir poco volutamente inguardabile ed offensiva..foto che andrebbe rimossa e sostituita con una più degna del calibro di Pahor, che si può condividere o meno come scrittore ecc, ma pubblicare foto di quel tipo…
Anche le foto sono importanti!
Ma si potrebbe anche parlare, sempre con riferimento alla comunità slovena, il caso di San dorligo/Dolina, rinvio a questo mio intervento http://xcolpevolex.blogspot.it/2014/01/san-dorligo-della-valle-o-dolina.html
su wikipedia non emerge nessun riferimento al referendum, vinto tra le altre cose, per il cambio del nome…
queste sono solo primi riflessioni e segnalazioni, ma sicuramente si aprirà un mondo, un mondo di antinazifascismo, antirazzismo ed antidiscriminazioni che porrà in discussione quella che da molti viene definita la più importante enciclopedia di questo nuovo secolo…certo, ma spesso volutamente di parte….ed in negativo!
Però attenzione a non prendersela con Wikipedia in quanto tale: con le ultimissime righe del tuo commento corri il rischio di generalizzare. Mastrangelo e AleR sono stati bannati, segno che con la dovuta attenzione e il rispetto dell’intelligenza delle persone le modalità autocorrettive funzionano, e Salvatore lo dimostra con grande chiarezza. Quello che si propone qui è uno sforzo collettivo di attenzione. Ad esempio, noi WM quando parliamo di Wikipedia consigliamo sempre, per ogni voce, di andare a vedere se c’è stata una discussione e come si è svolta. Ogni voce scritta a più mani, specie se su argomenti “scottanti”, è sempre il prodotto di un negoziato, e plasmata da conflitti. Gestire bene il conflitto, senza rimuoverlo né farsi trascinare da esso, è una delle cose più importanti da imparare. Seguire le vicissitudini di Wikipedia è molto educativo in tal senso.
no, non me la prendo con wikipedia in generale, ma questo post ha offerto una possibilità di riflessione enorme, e pur riconoscendo il lavoro, importante e difficile, che viene fatto da chi si oppone a certe “omologazioni” o “negazioni” od operazioni di discredito, certe nefandezze non sono proprio tollerabili e guarda “caso” sembrano cadere proprio su certi ed argomenti specifici! Comunque accolgo quanto da te ora scritto, sottolineando, che la parte finale del mio commento è figlia di sentimento rabbioso ed impulsivo. Andrò avanti con le ricerche. Ps mi scuso per gli errori di battuta nel precedente commento, anche quelli figli di impulsività.
Il mito della cricca degli admin è al tempo stesso inutilmente allarmista e consolatorio per chi non sa rapportarsi in modo proficuo (ancorché, alla bisogna, conflittuale) con gli utenti di Wikipedia. Gli admin vengono eletti dagli utenti attivi con una procedura simile a quella con cui si eleggono dei responsabili e dei segretari in qualsiasi associazione democraticamente organizzata.
Finché la Wikimedia Foundation riuscirà a resistere a pressioni economiche di vario tipo (che, come insegna la storia, è in questo e in moltissimi altri casi una minaccia costante che grava su ogni “bene comune” in una società basata sul profitto privato), l’unico elemento davvero autoritario in tutta la struttura, che infatti viene spesso criticato come “bug fatale” di Wikipedia, è che Jimbo Wales, il fondatore di Wikipedia nella sua forma attuale, ha dei superpoteri che teoricamente gli permetterebbero di fare quel che vuole. Alcuni vedono in realtà questa curiosa regola come un dispositivo di sicurezza nel caso che il progetto venga dirottato, un po’ come la setta dei Jedi nella Repubblica… ma sappiamo come è andata a finire. :-) Per rasserenare i pessimisti, ricordo che è comunque possibile a chiunque fare un “fork” di Wikipedia, cioè clonarla e farla ripartire da un’altra parte. In effetti è ciò che è avvenuto in questo caso: http://en.wikipedia.org/wiki/Enciclopedia_Libre_Universal_en_Espa%C3%B1ol
Naturalmente, ci sono molti modi più o meno sottili per influenzare l’orientamento di Wikipedia e se c’è una cosa intelligente che ha detto Mastrangelo è che riuscire a controllare Wikipedia ormai significa riuscire a controllare molte altre cose. Quello in cui Mastrangelo sbaglia è credere che si possa fare col vittimismo e l’arroganza dei fascisti o, viceversa, che sia così facile farlo ai malvagi comunisti usando rodate tecniche di “egemonia culturale” erroneamente attribuite a Gramsci. In realtà il modo più semplice e duraturo di influenzare Wikipedia è farsi il culo studiando, intervenendo in modo intelligente, conquistando uno spazio per le proprie idee nel mondo offline; del resto è esattamente la stessa cosa che proponeva il vero Gramsci. Le stesse aziende che cercano periodicamente di usare Wikipedia come vetrina pubblicitaria finiscono spesso per essere piuttosto frustrate nonostante abbiano la possibilità finanziaria di allocare risorse umane specificamente per quello scopo. Abbiamo già ragionato a proposito dei social network e di altre strutture basate sulla partecipazione di massa su come sia possibile con un’intelligente azione collettiva “dirottare” qualcosa che è strutturalmente destinato a un altro scopo; in questo caso è anche meglio di Twitter o Facebook perché Wikipedia è strutturalmente organizzata per uno scopo che io reputo positivo e progressivo, i dirottatori in questo caso sono semmai alcuni portatori di interessi particolari e antisociali (tra cui ci metto pure i nostri amichetti in camicia nera, ma soprattutto certi altri signori in giacca e cravatta).
Parte del motivo per cui non ci sono molte scorciatoie per distorcere Wikipedia sta nel fatto che gli admin sono meno potenti di quanto si creda: la quantità di edit e di utenti è così smisurata che non sono in grado di fare il bello e il cattivo tempo neanche volendolo; sembrano molto potenti solo a personaggi come Mastrangelo che fanno tanto chiasso e si dedicano a parecchie cause perse con l’eleganza di un elefante neonazista in una cristalleria ebraica. Dando la colpa agli admin possono nascondere agli altri e a sé stessi i difetti più profondi del loro modo di intervenire su Wikipedia, che generano spontaneamente una reazione di rifiuto anche tra una vasta porzione di utenti senza privilegi di amministratore. Se l’analogia della piazza ha qualche valore, ho visto più spesso la folla risolvere il problema senza bisogno del servizio d’ordine, o con un ruolo puramente muscolare del servizio d’ordine a coronamento di un consenso che si era già costruito ad armi pari.
Siamo felici che abbiate citato il personaggio di Francesco Misiano.
In merito segnaliamo il volume di Nando Marzano e Fortunato Nocera, “Francesco Misiano- Il pacifista che portava in valigia la corazzata Potemkin”, che pur nella sinteticità del testo, inaugura una stagione di rinnovato interesse per una figura straordinaria alla quale come collettivo stiamo dedicando già ricerche e attenzione.
Per quanto riguarda il dibattito più ampio del revisionismo in salsa neofascista, è utile far notare come in questo ed in episodi simili, come l’attitudine di questi pseudoricercatori sia rivolta verso una distorsione delle fonti spesso utilizzate in chiave parziale.
Ho letto alcuni giorni fa l’articolo di Salvatore Talia. Premetto che mi rincuora molto leggere, in molti passi dell’articolo, considerazioni o perplessità fatte da una persona che non conoscevo ma che alcuni anni fa feci anch’io prima di abbandonare il progetto Wikipedia.
Non conosco i contenuti del libro di Mastrangelo e alcuni contesti su cui basa la recensione di Talia nel merito dei contenuti in materia di Storia e Storiografia. Da ex wikipediano ed ex amministratore, presunto appartenente alla famigerata “cricca”, conosco però molto bene il modus operandi di Mastrangelo e la funzionalità strategica della sua dialettica (dentro e fuori Wikipedia). Conosco anche molto bene diversi contesti e diversi utenti menzionati nella recensione di Talia e, non so a quale livello di approfondimento e di onestà intellettuale, nel libro di Mastrangelo. Non mi concedo assolutamente la velleità di etichettarmi esperto di storia e storiografia, anzi, sono un emerito ignorante, sicuramente più ignorante di un anonimo ingegnere edile, presumo romano, che per alcuni anni è stato un instancabile animatore dei flame e delle guerre di trincea nelle pagine di discussione relative a voci di storia del XX secolo e di nomenclatura geografica della penisola balcanica e sistematicamente sostenitore o sostenuto di un gruppo di sodali che sfrutta un’aberrazione del concetto di consenso per isolare l’interlocutore di turno. Ben tenendosi lontano, stranamente, dagli ambiti tematici di carattere tecnico, tecnologico, scientifico, come ci si aspetterebbe dalla sua cultura primaria su base tecnico-scientifica. No, non sono così esperto e da buon ignorante in storia e storiografia ho in genere contribuito a Wikipedia scrivendo di mosche, moscerini e dintorni. Ma da ex criccaro ed esperto delle dinamiche relazionali, individuali e di grupppo, nell’ambito della comunità di Wikipedia, ne ho viste e lette di cotte e di crude al punto che potrei scrivere un libro anch’io su come viene usata, spesso, Wikipedia.
In questa sede mi limito a citare per somme linee un evento, per dare un’idea della complessità e faziosità dei rilievi descritti in questa recensione. Nel 2011 un utente menzionato in questo articolo e nel libro di Mastrangelo, tale Crisarco, noto gregario della “cricca di Piero Montesacro”, fu coinvolto in una guerra di rollback in quanto, a seguito di una animata discussione, un IP anonimo inserì una voce a suo tempo scritta da Mastrangelo e che, in precedenza, era stata rimossa da Wikipedia per volontà della comunità (secondo ordinaria procedura). Crisarco, applicando la policy di WP relativa al reinserimento delle voci cancellate per volere della comunità, si oppose a questo reinserimento, in contrasto con un gruppo di utenti favorevole al reinserimento, ma si scontrò in questa guerra di annullamenti e al terzo rollback consecutivo fu bloccato da un amministratore per sterile applicazione di una mera regola (blocco dell’utenza al terzo rollback consecutivo in una “revert war”. Crisarco era un utente che, a prescindere dalle buone intenzioni, aveva certamente qualche difetto nelle dinamiche relazionali wikipediane (poco diplomatico e troppo esplicito o, usando un punto di vista differente, poco incline all’ipocrisia strategica). Ne seguì pertanto una segnalazione di problematicità, in cui (carpe diem) si scatenarono diversi sodali “mastrangelisti”. Giacché era mia abitudine – da amministratore – analizzare i contesti a 360° mi stupii del fatto che nel “namespace principale” (ovvero lo spazio strettamente riservato ai contenuti dell’enciclopedia) persistesse un contenuto rimosso per volere della comunità e riproposto secondo una procedura anomala (a prescindere dal presunto “consenso”, parola con cui su WP si fa il bello e cattivo tempo). Chiesi la rimozione della voce e nel frattempo mi preoccupai di fare quello che nessuno aveva ancora fatto, nonostante fossero intervenuti diversi amministratori nella vicenda: chiesi un “check user” (controllo dell’utenza) sull’IP che aveva reinserito il contenuto. Ebbene, il check user rispose positivamente alla richiesta: l’utenza era associata a Mastrangelo, utente bloccato infinito. Ebbene, nonostante fosse un utente “bannato”, come successo in precedenza e molte altre volte in seguito, le azioni commesse dagli IP associati alla sua utenza non venivano annullate, ma restavano in archivio, con il sostegno appassionato di un gruppo di utenti (alcuni menzionati in questo articolo e, come “vittime” del mobbing della “cricca”, nel libro di Mastrangelo). Sconcertato e disgustato da questa superficialità nel trattare l’affaire Crisarco, mi dimisi da amministratore e chiesi il blocco infinito della mia utenza. Poco tempo dopo anche Crisarco fu sbattuto fuori senza troppi complimenti perché ormai marchiato come utenza incompatibile con il progetto. Continuai a seguire dall’esterno la vita Wikipediana, e nel 2012, stanco delle manovre del “gruppo” che vedevo all’indirizzo di alcuni utenti e amministratori, etichettati come criccari o sodali della “cricca”, stanco di vedere le sistematiche violazioni del blocco da parte di Mastrangelo, ma soprattutto stanco della sistematica violenza con cui si imponevano contenuti “revisionistici” e si presidiavano i relativi spazi di discussione ricorrendo ad un mero gioco dell’interpretazione delle regole, ho chiesto di essere riammesso. Purtroppo ho pestato i calli ad alcuni personaggi e sono finito anch’io nella lista nera degli utenti “inutili” e “incompatibili”. Durante un mio blocco (sacrosanto perché dovuto ad un “attacco personale” nei confronti di Theirrulez) venne fatto subito un check user su un IP della mia utenza perché da anonimo chiedevo un riscontro sull’ennesima violazione del blocco di Mastrangelo. Ironia della sorte, il mio blocco venne prolungato. Da lì a qualche mese decisi di abbandonare il progetto e chiesi di rimuovere il mio nominativo dal nome utente perché ormai associato all’infamia grazie alla sistematica azione di mobbing da parte di un gruppetto di anonimi facinorosi che usano Wikipedia come veicolo di propaganda ideologica e revisionista.
Molte volte ripenso con nostalgia agli anni che ho dedicato, con passione a Wikipedia, molte volte ho ripensato in modo critico al mio operato negli ultimi anni della mia utenza travagliata. Ho fatto bene, ho fatto male? L’articolo di Salvatore Talia non fa che rafforzare la consapevolezza dell’opportunità della mia scelta. Peccato, ma prima di pensare al bene di un progetto dalle nobili intenzioni ho preso atto di essere impotente contro la disonestà e ho fatto la mia scelta personale. Ringrazio vivamente Salvatore Talia per il suo articolo.
Giancarlo Dessì,
su Wikipedia Utente:Furriadroxiu, aka Giancarlodessi
Bene,
da come racconta questo episodio Furriadroxiu (*) sembrerebbe che Ignis, l’amministratore che blocca Crisarco, faccia parte della teppa mastrangiolesca, e magari anche Koji, admin a sua volta, che concorda con Ignis.
E non si comprende la reticenza nel citare la voce incriminata, ovvero Guerra Civile in Italia (1943-1945), argomento trattato dettagliamente (ma con una cronologia più precisa di quella ivi proposta) anche nel nostro saggio. Strano che questa reticenza venga proprio da chi si crede che la guerra civile non sia ancora finita e sta ancora giocando al soldato giapponese nella giungla a distanza di settant’anni.
Comunque tornando ad admin, ex-admin, fascisti veri e presunti, vale la pena notare che questa era solo la 7a segnalazione ai danni dell’utente Crisarco. “Fascisti” anche i precedenti segnalatori che hanno contribuito all’allontamento del Crisarco?
https://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Utenti_problematici/Crisarco
Ma d’altronde Furriadroxiu non era forse l’admin che andava a dar manforte all’admin Montesacro dopo che questi aveva suggerito al Mastrangelo un uso… anale dei suoi libri? Forse non ricordiamo bene le regole di wikipedia, ma a noi pareva che un tempo per gli insulti c’era il blocco a vista, non il “tu in un angolo, tu nell’alto, e chi s’è buscato il vaffanculo se muove un unghia lo fulmino”.
Questo famoso Admin Montesacro che oltre alle battute squallide nei confronti del Mastrangelo (probababilmente sicuramente meritate secondo la visione di questo blog) è fonte continua di storie che ben dimostrano la “cappa” definita nel saggio, e che in questa sede si è cercato (finora con scarsi risultati), di smentire. In particolare vale la pena di ricordare una vecchia e brutta storia di omofobia wikipediana, scatenatasi quando l’ignaro utente di turno si mise contro Montesacro e che vogliamo proprio vedere come rientra nei rozzi schemi di “antifà=buono, nonantifà=cattivo” che è il massimo d’apertura mentale da questi pizzi.
E l’ignaro utente di turno era un wikipediano della primissima ora, ex-admin, e soprattutto gay dichiarato.
Vecchia storia del novembre 2007, antecedente all’arrivo di Talia, Mastrangelo, Josè Antonio e Presbite, per dire qualche nome.
Ma c’era già Montesacro – e qualche altro nome noto – e lo scenario era proprio la prima votazione di riconferma ad amministratore di Piero Montesacro.
Una votazione infuocata, in cui molti intervengono in un verso e nell’altro.
A intervenire contro Montesacro è anche questo utente, il quale fa uno degli interventi meglio argomentati. Scrive tra l’altro:
<>
https://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Amministratori/Riconferma_annuale/Piero_Montesacro/1
Antifascista, gay, che si permette di far notare che l’atteggiamento militante e autoritario di un admin forse è fuori dalle regole wikipediane. L’utente in questione viene duramente contestato per le sue parole, in pagina di discussione, ma soprattuto vede contro di lui scatenarsi una campagna di mobbing omofobo a base di insulti che lo spingeranno all’esasperazione e quindi a reazioni scomposte dalle quali è conseguita come da programma una segnalazione di problematicità e conseguente ban per “atteggiamento non collaborativo” (noi preferiamo la locuzione “atteggiamento non collaborazionista”).
E ci crediamo che l’atteggiamento fosse non più tanto “collaborativo”, viste le continue e offensive provocazione subite (roba da Alabama meridionale…)
Quello che è certo è che si è trattato di una bella medaglia di comportamento infame (o “fascista”, come direste voi) per uno dei campioni rimpianti da Furriadroxiu.
Una pagina di infamia di Wikipedia in lingua italiana che si è voluta presto dimenticare per ricostruire una verginità ai “buoni”.
Ecco la “cappa plumbea”. Ecco gli atteggiamenti provocatori che si verificavano e si sono verificati negli anni. Ecco la “cricca”.
Anche questo è Wikipedia in lingua italiana.
Gli Autori.
(*) Si utilizza Furriadroxiu in quanto il nome utente precedente venne cambiato su richiesta, in tutte le occorrenze, con una procedura più unica che rara di “diritto all’oblio”.
Carissimo EM, puoi svicolare quanto ti pare.
1) non ho detto che l’amministratore Ignis fa parte della teppa mastrangiolesca, l’hai detto tu. E non direi mai che fa parte del gruppo dei tuoi sodali. Le mie critiche nei suoi confronti le ho fatte direttamente a lui, in privato, e riguardano solo il suo modo di interpretare il ruolo di amministratore. Il fatto che fosse coinvolto nell’affaire Crisarco è solo una coincidenza.
2) mai mi permetterei di affermare che Koji fa parte della teppa mastrangiolesca. Tant’è che Koji è stato bersaglio nel 2012 di un tentativo di siluramento (in fase di riconferma) da parte di un gruppetto di tuoi fedelissimi estimatori. Non mi sembra il caso di fare i nomi, immagino che alcuni amici del progetto Guerra scatenerebbero l’inferno su WP per le calunnie che sputo in questo spazio. Ancora brucia il fatto che nonostante i miei crimini wikipediani la mia utenza è ancora teoricamente attiva perché non bloccata. Nonostante ci si sia arrampicati sui vetri per dimostrare la mia incompatibilità con wikipedia.
3) Puoi rigirare quanto vuoi la questione sulla “guerra civile” nel merito, la cosa non mi tange. Io ho solo esposto un fatto: tu, da anonimo in violazione del blocco, hai reinserito prepotentemente una voce che avevi scritto. Al di là del merito, hai di fatto violato un blocco. E si sa bene che non fai altro che vantarti, fuori e dentro wikipedia, di violare sistematicamente il blocco e di imporre i contenuti che reputi pertinenti.
Il resto è fuffa mastrangeliana.
C’è un aspetto importante della questione wikipedia che secondo me dovrebbe essere approfondito. Spesso, come si sa, i giornalisti attingono informazioni da wikipedia. Non solo. Anche vari siti commerciali, turistici, e addirittura istituzionali, preparano le loro schede con materiale preso da wikipedia. Così capita che un edit basato su fonti false e/o manipolate si diffonda in modo virale nella rete. E a quel punto il meccanismo di autocorrezione della comunità wikipediana non basta più ad arginare il danno. Faccio un esempio, prendendo spunto dal caso del TIGR citato nell’articolo. L’attribuzione dell’omicidio di Coghelli/Kogoj al TIGR invece che ai comunisti, e l’omissione del fatto che si trattasse di un informatore della polizia, è stata sistemata nella pagina dedicata appunto al TIGR. Questa manipolazione, tuttavia, è passata in qualche modo anche alla pagina wiki su Gorizia, e lì nessuno l’ha ancora sistemata. Da li’, è arrivata qua e qua, cioè in un sito dedicato agli studenti, e in uno dedicato alla promozione del territorio.
La storia dell’umanità è accompagnata dal sistematico processo di plasmare quel bene chiamato Sapere. Plasmare nel senso di costruire, ristrutturare, demolire, liberare, blindare, ecc. In questo sistematico processo, l’Uomo ha partecipato in tutti i livelli di organizzazione: singoli individui, movimenti, gruppi di potere, gruppi di interessi. È fisiologico. Del resto, il Sapere è la linfa vitale dell’umanità. Da esso dipende il modo in cui progredisce o regredisce, il modo in cui interagisce con l’ambiente fisico, il modo in cui viene strutturata la società, la sua organizzazione, la sua dinamica, l’economia. È perciò fisiologico che si intervenga, nel bene e nel male e vario titolo, sugli strumenti di diffusione del Sapere.
Senza andare troppo lontano, negli ultimi decenni è ben noto il tentativo di intervenire sugli strumenti “ufficiali” di diffusione del Sapere. Mi riferisco in particolare alla Scuola, l’istituzione sociale culla della diffusione del Sapere. Basti pensare, senza andare troppo lontano, alla proposta della Carlucci, nel 2011, sull’istituzione di una Commissione d’inchiesta che esaminasse l’imparzialità dei testi scolastici di Storia (e non solo) o al maldestro tentativo della ministra Moratti di rimuovere l’evoluzionismo dai programmi del primo ciclo di istruzione secondaria nel D.lgs. 59 del 2004.
Con il progresso delle ITC e, soprattutto, della comunicazione in rete, la diffusione del Sapere, in modo attivo o passivo, è ormai alla portata di tutti. È perciò inevitabile che si cerchi, da un lato, di proteggere l’integrità dei contenuti, e da un altro, di modificarli. Nel bene e nel male. Soprattutto cercando di intervenire strategicamente sugli strumenti che hanno una maggiore capacità di penetrazione nel flusso.
Wikipedia, nel bene o nel male, è uno di questi strumenti e, sempre più, rischia di diventare fonte d’informazione primaria. Da ex “admin”, impegnato anche nella ricerca e verifica delle violazioni di copyright, ho toccato con mano la potenza (e la pericolosità) di uno strumento come Wikipedia. Cercando fra gli archivi Web ho potuto verificare che spesso l’origine dei contenuti si perde in una spirale di amplificazione in cui il flusso di un’informazione passa da wikipedia alla documentazione esterna e viceversa in un perverso gioco di copiature, citazioni, riformulazioni. Wikipedia è, per definizione, fonte d’informazione di natura compilativa, ma diventa sempre più fonte d’informazione primaria, usata come tale, più o meno consapevolmente, da giovani e adulti, da docenti e discenti, dagli organi di stampa, dalla politica. Quante volte, alla ricerca di una prima informazione, scegliamo la via più semplice, ovvero, cerchiamo su Wikipedia? Negli USA, la Wikipedia in inglese è diventata clamorosamente “fonte” anche nella giurisprudenza.
L’inserimento su Wikipedia di una nota, di un aggettivo, la formulazione di un incipit hanno una potenza devastante nel flusso d’informazione. Ecco allora le battaglie campali, i kilobyte (che nel tempo diventano megabyte) di discussioni, magari fra 3-4 utenti, per decidere se via Fuffella è stata un’azione militare, un attentato, un eccidio, una strage, un “fatto”. Se la Motumbia era uno stato libero occupato dalle truppe fuffiste o una nazione liberata grazie alle forze di liberazione panfuffiste. Se è più corretto chiamare Nbotunsbururo la capitale della Motumbia o usare la denominazione italiana Cotomburgo, ampiamente usata nei testi di geografia degli anni trenta e non “desueto” perché citato nell’opera del Fuffoni del 1994 e riportato tra parentesi in un atlante geografico del 2001.
Queste guerre di trincea su un aggettivo, sulla posizione di una virgola, che possono durare giorni, mesi, anni. Fino a produrre obbobri stilistici che vedono una successione di 10 numeretti (rimandanti a 20 testi più o meno anonimi confinati in biblioteche polverose che nessuno studente o nessun giornalista andrà a verificare), per dimostrare la pertinenza di un banale aggettivo inserito nella prima riga dell’incipit. Il tutto è apparentemente grottesco, soprattutto se immaginiamo che dietro quei 10 numeretti e quell’aggettivo c’è una storia durata 10 mesi di discussioni accese fra 3-4 utenti in prima persona, ma con il coinvolgimento di quattro blog esterni, due canali IRC, 4 segnalazioni di problematicità, il ban di tre utenti e la mancata riconferma di due amministratori e la mancata elezione di un candidato amministratore. Il tutto, apparentemente inutile e all’insaputa del comune lettore-fruitore di Wikipedia, ha uno scopo di lungo termine: l’aggettivo è un cavallo di Troia che introduce un concetto. Un concetto che nel tempo sarà trasferito in una ricerca scolastica, in una tesina, in una tesi di laurea, in una tesi di dottorato, in un trattato, in una relazione di accompagnamento ad un disegno di legge, in una sentenza giurisprudenziale e così via. Fino a far diventare quel concetto di dominio pubblico. Il dittatore diventa statista o lo statista diventa dittatore, l’eccidio diventa un’operazione di polizia o l’operazione di polizia diventa un eccidio, meglio se efferato, l’occupazione diventa liberazione o la liberazione diventa occupazione.
Questo è lo scopo di alcune utenze su Wikipedia. Fuori da Wikipedia il loro concetto resterebbe confinato in un blog frequentato da dieci visitatori al mese. Dentro Wikipedia il concetto diventa prima o poi di pubblico dominio perché sdoganato da un potente strumento di condivisione del Sapere. E attorno a queste utenze si scatenano anonime guerre senza esclusione di colpi.
Errata corrige: chiedo scusa, la proposta della Carlucci, sull’istituzione di una Commissione d’inchiesta che esaminasse l’imparzialità dei testi scolastici di Storia non risalte al 2011 come ho erroneamente scritto, ma al 2001.
Grazie Tuco del commento nel merito sull’impatto e sul ruolo di Wikipedia nel panorama dell’informazione.
Il problema che tu poni è trattato da un’intera sezione del volume ed è alla base del nostro discorso circa il rischio che Wikipedia possa diventare il “ministero della Verità”, ovvero un luogo nel quale l’informazione viene creata, diffusa nei media e quindi trasformata in puntello di se stessa in un circolo vizioso. Elemento orwelliano chiave, che viene in parte tralasciato e in parte derubricato nella presente “recensione”.
Nel libro si parte proprio da alcuni degli esempi di casi già avvenuti ma fortunatamente identificati. Identificati spesso quasi per caso, dopo che i giornali erano diventati a loro volta fonti per l’informazione “falsa” riportata da Wikipedia.
Ovviamente non è possibile dire finora se e quanta informazione “coniata” da Wikipedia sia già passata come moneta corrente senza che ce se ne sia resi conto. E’ di qualche settimana fa la notizia che un paio di professori universitari tedeschi hanno copiato una serie di definizioni per un volume di storia navale.
Copiaeincolla identificato, in cui l’editore, per cautelare il suo buon nome ha bloccato la distribuzione del volume.
Quanti casi come questi si verificano e non vengono alla luce? Impossibile determinarlo.
Il guaio è che a differenza di altri media – che pure possono e vengono continuamente taroccati per un’infinità di motivi che vanno dal dilettantismo alla malignità, dalla distrazione al fanatismo, dall’errore in buona fede alla cecità ideologica – solo Wikipedia ha l’onnipresenza in grado di trasformarla in una vera e propria zecca di conio della “verità” su grande scala, ed è un rischio tanto più grande quanta più bassa è la partecipazione e il controllo collettivo, viste le conventicole che bazzicano un po’ su tutte le Wiki e, peggio ancora, i prezzolati degli uffici P.R. di chi ha il portafogli gonfio.
Ovviamente non abbiamo una soluzione in tasca per questo problema: come per gli altri esposti nel saggio, pensiamo che solo un uso consapevole e una maggiore partecipazione (a 360° gradi…) possa aiutare a ridurre l’entità del problema, ma non ci illudiamo che possa mai essere azzerato. Molto realisticamente siamo rassegnati al fatto che un minimo di guai anche il miglior progetto del mondo non possa non darne. Di sicuro diffidiamo di eventuali soluzioni “miracolose” avanzate da tecnocrati e burocrati che propongano giri di vite, meccanismi automatizzati o quant’altro su questa falsariga. Questo perché tra gli autovelox dietro l’angolo della curva e un maggior impegno nell’educazione stradale, noi voteremo sempre per il secondo.
Questo a prescindere da qualunque casacca politica, vera e presunta. Il ruolo di Wikipedia ha ormai raggiunto, inconsapevolmente, un tale di livello di pervasività che è diventato fondamentale educarne alla lettura consapevole, e se possibile, anche ad una collaborazione matura.
Come dimostrato dal libro (o come ha cercato di contro-dimostrare Talia – ma basterebbe vedere le reazioni al bar di Wikipedia o nelle pagine facebook collaterali…) è sufficiente un pugno di persone per controllare l’enciclopedia. Grazie dell’attenzione, gli Autori.
Nel caso di wikipedia, come del resto nella stragrande maggioranza dei casi in cui viene usato, l’aggettivo-cliché “orwelliano” è tirato in ballo a sproposito, perchè non c’è nessun potere centrale che la controlla. L’antidoto alla circolazione delle notizie farlocche sta nell’allargamento della partecipazione al progetto, e soprattutto nello spiegare al grande pubblico cosa succede in sala macchine. Infatti non basta la partecipazione attiva, la cosa più importante è che chi usa wikipedia come semplice fruitore sia ben consapevole dei suoi meccanismi, del fatto che c’è scontro di idee lì dentro, che c’è politica, come ha scritto Salvatore. Inoltre è falso che sia sufficiente un pugno di persone a controllare wikipedia, visto che con pazienza e lavorando sodo è possibile smascherare le falsificazioni (vedi alla voce TIGR).
Beh, a sproposito o meno, il meccanismo del “ministero della Verità” è quello di produrre informazione (tarocca) che viene ripresa da tutti i media in un circolo vizioso. Ovviamente manca – al momento e per quello che ne sappiamo noi – una “intelligenza” unica dietro eventuali circoli viziosi del genere. Ma il rischio c’è. Tant’è che tu stesso proponi un “antidoto”.
Che guarda caso, è il medesimo, identico e spiccicato che proponiamo noi: maggior partecipazione, maggiore consapevolezza, maggiore responsabilità.
Forse dovresti proprio turarti il naso e leggerti il libro, magari scopriresti che il diavolo non è così brutto come te l’hanno dipinto…
(e finisce pure che mò il promotore di certe idee è Talia e non noialtri… ma dimmi tu…)
Se la vostra descrizione della sala macchine e’ quella di una comunità laboriosa disturbata da una cricca di bolscevichi, siete molto molto lontani dalle nostre analisi, checché tu ne dica.
Può essere utile, visto che se ne sta parlando in giro per la rete, spiegare come mai il post ha questo titolo: Fascinazione Wikipedia. Prima di tutto, il titolo non lo ha scelto Salvatore, che aveva invece proposto “Fasci di luce obliqua su Wikipedia”. Noi abbiamo scelto “fascinazione” perché l’articolo descrive in modo molto chiaro un certo tecno-entusiasmo, una certa utopia organicista nel modo in cui Mastrangelo parla dell’enciclopedia. Noi ci stiamo occupando di fascinazione e sonnambulismo, di ipnosi e suggestione, e del rapporto di tutto ciò col fascismo e coi fascismi; inoltre, da tempo ci occupiamo di tecnoutopie e “feticismo digitale”, e quei passaggi della recensione ci hanno molto colpito. Quindi: “Fascinazione Wikipedia”. Con due giochi di parole: “Fasci/nazione wikipedia”, e cioè: nella retorica di Mastrangelo la comunità wikipediana, la Gemeinschaft nella sua forma non corrotta dalla “cricca”, è descritta nel classico modo in cui la retorica fascista descrive la nazione, e Salvatore lo fa notare. L’altro gioco di parole, meno bello, è “Fasci in azione”, perché è innegabile e perciò sfidiamo chiunque a negarlo, che in questa storia e nei suoi pressi siano in azione persone che coltivano simpatie per il culto fascista dell’azione, per il vitalismo dell’uomo fascista, per il duce e le sue imprese, per i simboli del regime e quant’altro.
Forse non tutte le persone che Mastrangelo tira in ballo ed esalta come grandi utenti WP “non di sinistra” coltivano tali simpatie, chi lo sa. Salvatore non personalizza, né etichetta nessuno. Ma allora costoro non devono chiedersi come mai siano finiti dentro questa disamina (o meglio, non loro, che sono solo dei nickname, ma i loro edit in certe voci): devono chiedersi come mai c’è un libro – per inciso: pubblicato con l’aiuto del segretario della Fondazione Julius Evola, ma è un dettaglio en passant – dove un autore manifestamente di estrema destra, da tempo indaffarato a giustificare storicamente o relativizzare gesta e posizioni del regime mussoliniano, compreso l’uso dei gas nelle aggressioni coloniali, li tira per la giacca e li copre di elogi.
Quello che qui emerge, con esempi fatti anche nei commenti, è che in molte voci di wikipedia sulla storia d’Italia del 900 c’è un robusto, insistito POV-pushing di destra. La testimonianza dell’ex-admin Dessì è preziosa in tal senso. La differenza tra noi e Mastrangelo è che noi non piagnucoliamo additando cricche: per noi la società, ogni società, è sempre caratterizzata dalle contraddizioni e dal conflitto. È la condizione normale di ogni consesso umano.
Grazie, Wu Ming 1. Concordo: la deduzione che alla base di tante mistificazioni vi sia un'”utopia organicista” è il punto a mio avviso cruciale di questo articolo, il suo principale contributo.
Quei tristi personaggi fanno male a sé stessi e agli altri, e sono incompatibili con Wikipedia, perché si pongono in antitesi alla sua natura fondamentale: un progetto di testo collaborativo scritto da chi lo usa e che punta alla verificabilità, non alla Verità; all’eterna critica dei fatti (veri o presunti) e delle opinioni proprie e altrui, non alla codificazione di una “verità ultima (fino alla prossima riedizione)”.
https://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Attendibilit%C3%A0_di_Wikipedia#Filosofia_generale
Messa in termini piú comprensibili per un punto di vista wiki, sono i peggiori “POV pusher” che possano esistere: non solo non condividono i cinque pilastri di Wikipedia e non potranno mai capire la bellezza di una frase come «I for one am passionate about presenting truth neutrally. — TimStarling» (http://meatballwiki.org/wiki/DefendAgainstPassion ); ma per giunta intossicano l’ambiente rendendo difficile o impossibile ad altri avvicinarsi agli scopi del progetto.
In effetti, è sorprendente che da tanta melma l’autore sia riuscito a estrarre un’osservazione tanto utile: da un libercolo nella migliore delle ipotesi irrilevante, autoapologetico e mistificatorio, e da una massa indicibile di noiosissime diatribe, forse riusciamo a capire qualcosa di utile. Serve tuttavia fare un passo ulteriore: invitare piú persone dagli interessi piú variegati ad arricchire la partecipazione a Wikipedia è certamente utile, ma dubito possa essere risolutivo. (Spesso non si ottiene nulla, o si attirano solo poche persone intenzionate a portare faziosità.) A chi dispone dell’intelligenza necessaria, sottoporrei piuttosto delle sfide piú ambiziose.
1) A dispetto di tutti gli sforzi di pochi coraggiosi come i soci Wikimedia Italia, è difficile far capire alla popolazione generale che Wikipedia non è da dare per scontata ma (come e piú di tutto) va letta con spirito critico. Qui serve un’idea geniale, un grandioso progetto educativo nazionale comparabile all’alfabetizzazione di massa compiuta cinquant’anni fa a colpi di programmi televisivi e volontari “l’Unità” al braccio… Come ci si potrebbe riuscire?
2) Nella pagina collegata sopra John Stuart Mill ricorda il «sentimentalismo inutile [di] pensare che la verità semplicemente in quanto tale abbia un qualche potere intrinseco […]». La trasparenza e l’autoregolamentazione di Wikipedia dovrebbero garantire la libertà che Mill propone affinché la verità alla fine emerga, ma ciò basta, specie in argomenti poco presidiati e molto soggetti a falsificazioni e revisionismo come certi periodi storici? Ci sono altre precauzioni da prendere?
3) Tale “sentimentalismo inutile” è molto difficile da sradicare in certe menti fanatiche. La sincera collaborazione su voci wiki è un potentissimo antidoto, ma purtroppo costa moltissima fatica e non funziona per tutti. Dover bloccare un’utenza è una dichiarazione di fallimento; un altro fallimento è vedere buoni utenti che si stufano di fare le balie e se ne vanno. Ci sono antidoti per quegli utenti inguaribili? Si possono immaginare modi per educare piú velocemente e piú efficacemente un numero maggiore di persone?
Le tre questioni sono tutte variazioni su uno stesso tema. La sfida storica che il movimento Wikimedia si è posto dal 2009 circa è quella di aumentare i partecipanti ai progetti Wikimedia come Wikipedia, con una speciale attenzione alle minoranze sottorappresentate, anche per controbilanciare l’eterno rischio di un “pregiudizio sistemico” (systemic bias), che è sempre presente in ogni ambito. Per lo piú i progetti riescono a mantenere un equilibrio e una qualità elevata, ma certe aree sono piú a rischio di altre ed è sempre bene mantenere alta l’attenzione e intensi gli sforzi di riequilibrio, specie dove certi dati demografici fanno sospettare la presenza di grossi problemi. È ben nota la carenza di partecipazione femminile, ma sono altrettanto preoccupanti la carenza di afro-americani e ispanici USA nella Wikipedia in inglese, di arabi israeliani in Wikipedia in ebraico, delle seconde generazioni rumene o cinesi in Wikipedia in italiano… e di umanisti e “storici” (professionisti o dilettanti) un po’ ovunque. Purtroppo finora, nonostante decine di milioni di dollari investiti, anche la Wikimedia Foundation è riuscita a fare ben poco contro tali dispetti della storia, forse piú grandi di noi: ma forse qualcuno qui ha, nel nostro piccolo, qualche idea per fare meglio almeno in alcuni settori di Wikipedia?
forse la mentalita` di wikipedia come cosa data e` talmente radicata che su un piano generale non e` proprio chiaro che chiunque puo` essere generatore di contenuti. Ad esempio perche` le scuole non vengono sensibilizzate ad usare la piattaforma come tavolo di lavoro in modo massivo invece che come fonte di informazione modello biblioteca?
Grazie per l’ottimo lavoro di questo post e per i due commenti a cui mi metto in coda, che mi sono stati particolarmente utili. Da parte mia, ho qualche problema con il Neutral Point Of View (non sono un contributore di wikipedia). Dalla pagina di Wikipedia sul punto di vista neutrale: “Un’enciclopedia assume la sola posizione di un punto di vista neutrale, sul quale tutte le parti interessate possano concordare”. Non riconoscete in questa regola un problema, in contrasto con la visione per cui vediamo la società “caratterizzata dalle contraddizioni e dal conflitto” (dal commento di Wu Ming 1)?
Inoltre, sempre sulla stessa pagina di Wikipedia, si spiega che “voci che mettono a confronto punti di vista differenti non devono dedicare a quelli minoritari uno spazio o un dettaglio pari a quello dato a punti di vista maggiormente supportati”. Visto che a volte i punti di vista maggiormente supportati non mi sembrano i più vicini alla verità, non siamo anche qui di fronte a un bel problema?
Questa frase del commento di Nemo qua sopra secondo me coglie esattamente il punto centrale della questione:
A dispetto di tutti gli sforzi di pochi coraggiosi come i soci Wikimedia Italia, è difficile far capire alla popolazione generale che Wikipedia non è da dare per scontata ma (come e piú di tutto) va letta con spirito critico.
Ora wikipedia e’ integrata in google. Qualunque ricerca si faccia con google, in alto a destra compare lo “strillo” della corrispondente voce su wiki. E il feticismo digitale che permea il nostro rapporto coi motori di ricerca ci sonnambulizza di fronte ai contenuti wiki, regalando spazi di manovra notevoli a chi riesce a controllare i contenuti di certe voci.
Siamo nei dintorni di “Feticismo digitale e sfruttamento nascosto”. Mi piacerebbe sapere, e magari Nemo potrebbe darci un po’ di insight su questo punto, se c’è stato un qualche tipo di accordo tra la fondazione wikipedia e google, o se google si è limitato a parassitare wikipedia. In ciascuno dei due casi, direi che google trae profitto dal lavoro dei contributori di wikipedia, per cui ci troviamo di fronte a un altro esempio di “palizzata di Tom Sawyer”.
No, quello non è un accordo con Wikipedia, è tutto basato sull’algoritmo e si chiama Knowledge Graph: http://www.google.com/insidesearch/features/search/knowledge.html
In pratica cercano di darti già risposte a prima vista di modo che tu non debba nemmeno lasciare la pagina di ricerca (e quindi i servizi google).
[OT] @tuco: parlare di parassitismo non è esatto: senz’altro Google guadagna tantissimo grazie a Wikipedia, ma bisogna anche dire che il grosso del traffico di Wikipedia viene da Google.
La cosa risulta più chiara guardando l’interazione con enti profit. Per quanto mi riguarda, l’esempio principe è StackOverflow, senza il quale il mio lavoro sarebbe ben misero: una volta riconosciuta la sua generale affidabilità, Google ha senz’altro aggiustato i propri algoritmi per valorizzare i risultati StackOverflow, guadagnandoci ma anche facendo guadagnare quest’ultima.
Il caso di WP ovviamente è diverso in quando no profit, ma è innegabile che Wikipedia ci “guadagni” dall’essere molto visibile.
[Non più OT] Le tue considerazioni sono ovviamente corrette: piazzare i propri contenuti su WP (e quindi più o meno automaticamente aggiudicarsi a gratis il primissimo risultato Google) fa senz’altro gola a molti; i più ingenui intervengono a gamba tesa e vedono in breve le proprie modifiche annullate; i più accorti possono influenzare sottilmente il pensiero di migliaia di persone.
Il Knowledge Graph di Google ha prodotto un significativo calo di visite a Wikipedia. http://www.dailydot.com/news/wikipedia-falling-traffic-meaning/
Certo, i contenuti di Wikipedia (perlomeno l’incipit delle voci e i dati strutturati che esse contengono) hanno ora una visibilità molto maggiore, ma il risultato è che la gente legge quelle informazioni basilari direttamente dalla pagina di Google e non va a visitare l’Enciclopedia. Questo secondo me significa un minore coinvolgimento dell’utenza in Wikipedia, quindi una minore comprensione di cosa Wikipedia sia e una minore probabilità che qualcuno decida di entrare nella comunità wikipediana.
Secondo me c’è qualcosa di sbagliato nel fatto che Google presenti dei dati provenienti da una wiki in un modo che non mostra subito all’utente che si tratta appunto di una wiki che può essere modificata da chiunque. In questo modo è ancora più difficile che la popolazione impari a prendere i dati provenienti da Wikipedia cum grano salis, perché per arrivare alla pagina di modifica servono due click invece che uno.
Tra l’altro faccio notare, e così torniamo un po’ più in topic, che quanto più i contenuti di Wikipedia sono riutilizzati in contesti chiusi (non c’è solo Google, ma anche una miriade di siti che replicano Wikipedia sotto forma di “istantanee”), tanto più aumenta il potere degli editor, che diventano i custodi della “fonte del sapere”, e tanto più saranno forti le tentazioni di fare “cricche” per inquinare questa fonte.
Esempio: gli insegnanti che chiedono agli studenti di fare “una ricerchina su Pelizza da Volpedo” secondo me sbagliano, perché in questo modo gli alunni faranno un riassunto scadente di una istantanea della voce di Wikipedia. Sarebbe ben più utile ed educativo che gli insegnanti dessero agli studenti il compito di mettere a posto e migliorare la voce su Pelizza da Volpedo su Wikipedia (o su una wiki pubblica messa a disposizione dalla scuola!).
tuco, il knowledge graph è un’iniziativa autonoma di Google, per quanto Google e Wikimedia Foundation si parlino. Un precedente peraltro c’è, le “community pages” di Facebook ormai parecchi anni fa.
È vero che come detto sopra si è ipotizzato (a seconda delle persone) che cosí Google cannibalizzasse Wikipedia o che invece le desse ancor maggiore visibilità, ma al momento i dati seri non mostrano alcun cambiamento nel numero di visite da Google: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2013_Wikimedia_traffic_trends.pdf
Ci sono innumerevoli studi e discussioni sulle relazioni fra il successo di Google e quello di Wikipedia, ma raramente è utile. Il problema è che gli utenti in grande parte continuano ad agire come spettatori televisivi passivi, anche sui wiki, a dispetto di tutti i tentativi di coinvolgerli: molti incontrano degli ostacoli, ma i piú nemmeno provano. Persino fra chi legge questo articolo, quanti hanno mai letto una pagina di discussione di una voce di Wikipedia? Quanti ne hanno spulciato la cronologia? Quanti sanno che possono cliccare “modifica”, quanti l’hanno fatto almeno una volta, e quanti hanno salvato anche solo una correzione di un refuso?
@Nemo
Scusa, però io la flessione in coincidenza della fine del 2012 la vedo anche nel grafico che hai linkato tu. E il Knowledge Graph è stato esteso a otto lingue proprio il 4 dicembre 2012 (qualche mese prima era stato fatto partire negli USA).
Sono d’accordo in generale sul fatto che i problemi che può avere Wikipedia sono più interni che dovuti a fattori esterni, ma se devo giudicare questa operazione di Google non posso che ritenere che abbia ostacolato la fruizione consapevole di Wikipedia, enfatizzando i contenuti già prodotti a scapito della comunità (e quindi della produzione di contenuti migliori).
Come ho detto, non ho voglia di improvvisarmi analista dei traffici. Non limitarti al grafico, l’analisi che lí fanno è un po’ piú scientifica e la conclusione è che il traffico portato da Google non è variato significativamente.
La coincidenza che tu dici l’hanno notata in tanti ma spesso l’hanno letta all’incontrario. https://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge_Graph ha bisogno di piú dettagli su quali lingue siano state attivate o potenziate e quando, ma l’ultima volta che ho controllato ho visto che le sette lingue introdotte da Google a fine 2012 hanno avuto *piú* visite il mese seguente e il calo è stato su altre lingue. Il tuo argomento può quindi facilmente essere ribaltato…
https://stats.wikimedia.org/EN/TablesPageViewsMonthlyCombined.htm
Grazie Tuco anche per questa seconda osservazione.
Google “sfrutta” Wikipedia tramite il knowledge graph, dopo aver tentato invano anni orsono di creare un’alternativa a Wikipedia denominata knol.
Come Wikipedia sia diventata predominante è rispetto ad altri moloch dell’informazione (ricordiamo Encarta di microsoft) è ovviamente argomento del volume.
Saggio che potrebbe risponderti a queste tue domande forse più efficacemente di un esponente di Wikimedia.
La fondazione che tanto fa per la diffusione delle licenze libere, spesso pecca di un atteggiamento un po’ autoreferenziale verso la sua creatura, non notando spesso i i rischi in cui incorre, specialmente per quanto riguarda la manipolazione dell’informazione.
Se a fine 2013 è stato fatto, grazie a Wikimedia, un repulisti dei contributori di Wikipedia prezzolati, e pur vero che in passato si sono verificati casi di esponenti di Wikimedia che “vendevano” il loro ruolo per consulenze specializzate. Grazie dell’attenzione, gli Autori.
Dobbiamo innanzitutto premettere che ringraziamo Talia per aver recensito il nostro libro e Wu Ming per lo spazio. Francamente non speravamo di riuscire a rompere quel silenzio assordante che finora ha accolto il volume soprattutto negli ambienti dove sarebbe stato più logico se ne parlasse, e Talia, forse involontariamente, ha contribuito in maniera determinante a infrangere la conventio ad excludendum. Ora, finalmente, si può dibattere. Noi gliene ne siamo grati. Un sacco di quelli che si erano sforzati finora di tenere il diavolo nella bottiglia, ci sa che lo aspettano sotto casa…
Lo ringraziamo anche per l'”odiografia” su uno di noi due. Nel libro abbiamo cercato quanto più possibile di evitare riferimenti personali, tanto per una questione di eleganza quanto perché il saggio non è una forma di revanche ma un’inchiesta che parte da molto prima che il Mastrangelo venisse bannato, come si vede dai molti articoli dedicati da entrambi al fenomeno Wikipedia fin dal lontano 2007. E tutti tutte le volte che citiamo botta e risposta wikipediani lo facciamo per esplicare i meccanismi, non certo per antipatie personali.
Ma visto che siamo in ballo, balliamo, anche perché questa odiografia per come è confezionata permette di ribattere a essa in maniera sintetica e definitiva: innanzitutto per il riferimento al pamphlet di Turi, che è un libello del tutto inverosimile e fantasioso (accredita un’affiliazione a una specie di “complotto culturale” forzitaliota del Mastrangelo e di “Storia in Rete” che è la casa di Scajola alla rovescia: un’affiliazione avvenuta a loro insaputa, visto si stanno ancora aspettando i soldi che di solito queste affiliazioni garantiscono! E invece, a giudicare dalla lista degli sponsor sulle pagine di “Storia in Rete”, finora, ceppa…). Secondo poi perché nel voler giocare a fare il Travaglio della situazione che legge le “sentenze”, Talia dimentica di citare i “capi d’accusa” che furono usati nelle due segnalazioni di problematicità contro il Mastrangelo. In entrambi i casi si ricorse ad accuse di “falsificazione di fonti” a loro volta false come una moneta da tre euri: nel primo caso si contestò a EM di aver “malignamente” annoverato fra coloro i quali non sostenevano la volontà di fuga in Svizzera di Mussolini il giornalista e storico Franco Bandini. Contestazione basata sul fortuito rinvenimento su internet di una citazione da un’opera di Bandini degli anni Settanta. Peccato che Bandini dagli anni Settanta alla morte (avvenuta nel 2005) ebbe modo di ricredersi ampiamente sull’argomento e di diventare uno dei battistrada e degli alfieri della tesi opposta dell'”Appuntamento sul Lago”. Insomma, sarebbe come dire che uno è bugiardo se classifica Paolo di Tarso fra i cristiani, perché prima di cascare da cavallo faceva il persecutore dei medesimi… Nel secondo caso vennero addirittura arbitrariamente selezionate alcune citazioni da Gian Enrico Rusconi e altri che – estrapolate dal loro contesto – sembravano contraddire quanto affermato da EM. Peccato anche stavolta che la lettura integrale dei passaggi in questione non solo collimava perfettamente con quanto sostenuto da EM, ma al contrario qualificava il “wikipubblico ministero” di turno come un volgare bugiardo. Quando più di un utente cercò di dimostrare che il mentitore non era Mastrangelo ma il suo prosecutore, i giudici\giuria\boia già pronti col cappio insaponato in mano la buttarono sulla questione “Mastrangelo non gode più della fiducia della comunità” e chiusero la patita con una rapida esecuzione capitale, dimostrando così quel loro considerare la “comunità” come “Cosa Loro”. Et de hoc satis.
Qualcuno ha scritto che per la recensione di Talia “c’è un grosso lavoro di documentazione”. Effettivamente il lavoro è ponderoso. Però, a causa delle lenti colorate dall’ideologia, finisce che tocca classificarlo nella categoria “il ragazzo si applica ma non è intelligente”. Basti citare un esempio: in tutto il pistolotto sulla voce “Battaglia di Tarnova” Talia è costretto a ignorare tutta una serie di dettagli tutt’altro che secondari per far quadrare il cerchio dell’equazione “Mastrangelo = repubblichini”. Il fatto che sia stato proprio lui a inserire come fonti di primaria importanza le ricerche in croato e sloveno (fra l’altro, probabilmente è il primo caso in Italia su questo argomento); che sia stato lui a voler cambiare l’esito della “battaglia” da “vittoria italiana” a “vittoria iugoslava” sulla base delle fonti, man mano che ne uscivano di nuove e non di ragionamenti ideologici; che sia stato lui a voler inserire un dettaglio su certe atrocità fasciste sui civili, poi però dimostratesi inventate di sana pianta da un noto ricercatore molto ideologicamente connotato; infine che si sia speso per un “depotenziamento” del titolo della voce da “battaglia” a “scontri”, cosa che però non si è potuta ottenere in ossequio alle fonti (di entrambe le parti, eh, mica sono solo i filo-repubblichini che fanno di una scaramuccia di confine una stalingrado in sedicesimo!). Tutto ciò – perfettamente riscontrabile nelle discussioni relative – è allegramente ignorato. E dà la cifra della tara da fare a questo “grosso lavoro di documentazione”, che stringi stringi, si riduce a un “è fascista perché ha detto ciao a uno di casapau”.
Fin qui sul metodo. Nel merito della recensione al libro, ci preme rilevare che l’idea di una Wikipedia come blocco granitico e privo di sfumature ideologiche non è che nella testa di chi l’ha scritto. In tutto il libro troverete decine di occasioni in cui ci siamo sperticati per rivendicare il più sacrosanto dei principi wikipediani: il pluralismo dei punti di vista. Un pluralismo che non è derogabile. Ora, è chiaro che come il prete si deve inventare il diavolo per giustificare l’esorcismo e lo psicanalista deve attribuire complessi infantili per giustificare le sedute di lettino, così anche l’antifascismo – a settant’anni quasi tondi da Piazzale Loreto – deve inventarsi fascisti ovunque per dare un senso alla propria esistenza. Ma qua, spiacenti dover deludere Talia, il buco nell’acqua è plateale. Insomma, un motivo – se vi sfottono su e per Nonciclopedia – ci sarà. Fatevi una domanda e datevi una risposta.
Passiamo a Orwell. Talia sembra liquidare con un sorrisino di superiorità il nostro riferimento all’autore di “1984”. Una sottovalutazione che sembra proprio auto-smentirsi quando scrive: “Consiglierei loro di non essere così ottimisti sull’esito finale. Non è detto che la loro «maggioranza silenziosa» di italiani «non-di-sinistra» (vale a dire di destra tout court [altro esempio della capacità del nostro di riconoscere le infinite sfumature di grigio esistenti fra il bianco e il nero… EM&EP]) esista veramente, né che abbia la voglia, o le capacità, di dedicare parte del proprio tempo ad una attività volontaria alquanto impegnativa come la redazione delle voci di Wikipedia”. E che Dobbiamo innanzitutto premettere che ringraziamo Talia per aver recensito il nostro libro e Wu Ming per lo spazio. Francamente non speravamo di riuscire a rompere quel silenzio assordante che finora ha accolto il volume soprattutto negli ambienti dove sarebbe stato più logico se ne parlasse, e Talia, forse involontariamente, ha contribuito in maniera determinante a infrangere la conventio ad excludendum. Ora, finalmente, si può dibattere. Noi gliene ne siamo grati. Un sacco di quelli che si erano sforzati finora di tenere il diavolo nella bottiglia, ci sa che lo aspettano sotto casa…
Lo ringraziamo anche per l'”odiografia” su uno di noi due. Nel libro abbiamo cercato quanto più possibile di evitare riferimenti personali, tanto per una questione di eleganza quanto perché il saggio non è una forma di revanche ma un’inchiesta che parte da molto prima che il Mastrangelo venisse bannato, come si vede dai molti articoli dedicati da entrambi al fenomeno Wikipedia fin dal lontano 2007. E tutti tutte le volte che citiamo botta e risposta wikipediani lo facciamo per esplicare i meccanismi, non certo per antipatie personali.
Ma visto che siamo in ballo, balliamo, anche perché questa odiografia per come è confezionata permette di ribattere a essa in maniera sintetica e definitiva: innanzitutto per il riferimento al pamphlet di Turi, che è un libello del tutto inverosimile e fantasioso (accredita un’affiliazione a una specie di “complotto culturale” forzitaliota del Mastrangelo e di “Storia in Rete” che è la casa di Scajola alla rovescia: un’affiliazione avvenuta a loro insaputa, visto si stanno ancora aspettando i soldi che di solito queste affiliazioni garantiscono! E invece, a giudicare dalla lista degli sponsor sulle pagine di “Storia in Rete”, finora, ceppa…). Secondo poi perché nel voler giocare a fare il Travaglio della situazione che legge le “sentenze”, Talia dimentica di citare i “capi d’accusa” che furono usati nelle due segnalazioni di problematicità contro il Mastrangelo. In entrambi i casi si ricorse ad accuse di “falsificazione di fonti” a loro volta false come una moneta da tre euri: nel primo caso si contestò a EM di aver “malignamente” annoverato fra coloro i quali non sostenevano la volontà di fuga in Svizzera di Mussolini il giornalista e storico Franco Bandini. Contestazione basata sul fortuito rinvenimento su internet di una citazione da un’opera di Bandini degli anni Settanta. Peccato che Bandini dagli anni Settanta alla morte (avvenuta nel 2005) ebbe modo di ricredersi ampiamente sull’argomento e di diventare uno dei battistrada e degli alfieri della tesi opposta dell'”Appuntamento sul Lago”. Insomma, sarebbe come dire che uno è bugiardo se classifica Paolo di Tarso fra i cristiani, perché prima di cascare da cavallo faceva il persecutore dei medesimi… Nel secondo caso vennero addirittura arbitrariamente selezionate alcune citazioni da Gian Enrico Rusconi e altri che – estrapolate dal loro contesto – sembravano contraddire quanto affermato da EM. Peccato anche stavolta che la lettura integrale dei passaggi in questione non solo collimava perfettamente con quanto sostenuto da EM, ma al contrario qualificava il “wikipubblico ministero” di turno come un volgare bugiardo. Quando più di un utente cercò di dimostrare che il mentitore non era Mastrangelo ma il suo prosecutore, i giudici\giuria\boia già pronti col cappio insaponato in mano la buttarono sulla questione “Mastrangelo non gode più della fiducia della comunità” e chiusero la patita con una rapida esecuzione capitale, dimostrando così quel loro considerare la “comunità” come “Cosa Loro”. Et de hoc satis.
Qualcuno ha scritto che per la recensione di Talia “c’è un grosso lavoro di documentazione”. Effettivamente il lavoro è ponderoso. Però, a causa delle lenti colorate dall’ideologia, finisce che tocca classificarlo nella categoria “il ragazzo si applica ma non è intelligente”. Basti citare un esempio: in tutto il pistolotto sulla voce “Battaglia di Tarnova” Talia è costretto a ignorare tutta una serie di dettagli tutt’altro che secondari per far quadrare il cerchio dell’equazione “Mastrangelo = repubblichini”. Il fatto che sia stato proprio lui a inserire come fonti di primaria importanza le ricerche in croato e sloveno (fra l’altro, probabilmente è il primo caso in Italia su questo argomento); che sia stato lui a voler cambiare l’esito della “battaglia” da “vittoria italiana” a “vittoria iugoslava” sulla base delle fonti, man mano che ne uscivano di nuove e non di ragionamenti ideologici; che sia stato lui a voler inserire un dettaglio su certe atrocità fasciste sui civili, poi però dimostratesi inventate di sana pianta da un noto ricercatore molto ideologicamente connotato; infine che si sia speso per un “depotenziamento” del titolo della voce da “battaglia” a “scontri”, cosa che però non si è potuta ottenere in ossequio alle fonti (di entrambe le parti, eh, mica sono solo i filo-repubblichini che fanno di una scaramuccia di confine una stalingrado in sedicesimo!). Tutto ciò – perfettamente riscontrabile nelle discussioni relative – è allegramente ignorato. E dà la cifra della tara da fare a questo “grosso lavoro di documentazione”, che stringi stringi, si riduce a un “è fascista perché ha detto ciao a uno di casapau”.
Fin qui sul metodo. Nel merito della recensione al libro, ci preme rilevare che l’idea di una Wikipedia come blocco granitico e privo di sfumature ideologiche non è che nella testa di chi l’ha scritto. In tutto il libro troverete decine di occasioni in cui ci siamo sperticati per rivendicare il più sacrosanto dei principi wikipediani: il pluralismo dei punti di vista. Un pluralismo che non è derogabile. Ora, è chiaro che come il prete si deve inventare il diavolo per giustificare l’esorcismo e lo psicanalista deve attribuire complessi infantili per giustificare le sedute di lettino, così anche l’antifascismo – a settant’anni quasi tondi da Piazzale Loreto – deve inventarsi fascisti ovunque per dare un senso alla propria esistenza. Ma qua, spiacenti dover deludere Talia, il buco nell’acqua è plateale. Insomma, un motivo – se vi sfottono su e per Nonciclopedia – ci sarà. Fatevi una domanda e datevi una risposta.
Passiamo a Orwell. Talia sembra liquidare con un sorrisino di superiorità il nostro riferimento all’autore di “1984”. Una sottovalutazione che sembra proprio auto-smentirsi quando scrive: “Consiglierei loro di non essere così ottimisti sull’esito finale. Non è detto che la loro «maggioranza silenziosa» di italiani «non-di-sinistra» (vale a dire di destra tout court [altro esempio della capacità del nostro di riconoscere le infinite sfumature di grigio esistenti fra il bianco e il nero… EM&EP]) esista veramente, né che abbia la voglia, o le capacità, di dedicare parte del proprio tempo ad una attività volontaria alquanto impegnativa come la redazione delle voci di Wikipedia”. E che riecheggia con un certo auto-compiacimento l’agghiacciante (citiamo a memoria) “i prolet sono animali, Winston. I prolet non si ribelleranno mai, né fra mille né fra un milione di anni”. Forse saremo degli illusi, ma fra il SocIng e i Prolet preferiamo stare con questi ultimi. Se Talia preferisce il primo forse è perché gli piace vincere facile, ponziponzipopopo.
In realtà i nostri riferimenti a Orwell seguono due canali paralleli: il primo, quello che piace meno a Talia perché denuncia un “re nudo”, è quello dell’esistenza di una cricca che utilizza mezzi alla “1984” (psicopolizia, bispensiero etc.) e slogan alla “Fattoria degli Animali” (tutti gli wikipediani sono uguali, ma qualcuno è più uguale degli altri) per silenziare i non allineati o quantomeno per offrire quanta più resistenza possibile al cambiamento verso versioni plurali, oggettive e sostanzialmente non-ideologiche delle voci “calde” (capiamo che “plurale” e “oggettivo” sono attributi poco comprensibili a chi vede tutto in chiave ideologica, ma vi preghiamo di fare uno sforzo di immaginazione per raffigurarvi un mondo dove la verità non ce l’avete in tasca voialtri).
E sul silenziamento dei non allineati (magari anche antifascisti dichiarati da parte di altri antifascisti) non mancano esempi, come quello citato dello scomposto mobbing omofobo.
Infine, ribadiamo quanto già detto in altra sede su Miyazaki. In quanto affezionatissimi ammiratori del Maestro (Maestro pacifista e socialista) ci fa male ogni volta che un suo film viene mistificato e arruolato d’ufficio in questa o quella fazione. Il tentativo di arruolare “Porco Rosso” fra i fanatici nostrani dà la cifra stilistica e ideologica di chi lo compie. Tutti conoscono il “meglio porco che fascista” di Marco Pagot. Troppi però dimenticano che il film di Miyazaki, come tutta la sua opera, non è mai improntata all’odio antropologico verso gli antagonisti. Pagot e Ferrarin restano amici e il secondo, che vola con un aereo sotto il “deprecato simbolo”, salva il protagonista che lo saluta con un “ciao camerata”, cosa che avrà fatto venire più di un malore in sala. Tirare dunque in ballo Miyazaki per puntellare una campagna d’odio ideologico irriducibile e senza quartiere è quanto di più sbagliato si possa fare. Penseremmo a malafede se non bastasse come spiegazione proprio l’accecamento che l’odio ideologico provoca a chi lo pratica. E se proprio vogliamo citare il Maestro, la frase che più si attaglia a questa situazione è la chiusa de “La principessa Mononoke”: quel バカには勝てん, “non si può vincere contro gli stolti” ovvero, non c’è partita contro chi continua a perseverare ciecamente nella reiterazione dei propri errori. E l’ideologia è la prima causa di accecamento.
Come ci ricorda lo stesso Maestro:
<>
Tralasciando fuffa, finta neutralità, captatio benevolentiae e quant’altro, rispondo su un punto, cioè sulla cosiddetta “battaglia di Tarnova”. Il fatto stesso che quella voce ci sia è una precisa scelta politica, perchè quella “battaglia” fu in realtà un episodio del tutto marginale, la cui memoria sopravvive solo nella pubblicistica dei nostalgici di Salò e tra i feticisti delle armi e delle divise (purchè di eserciti dell’ Asse). Per quanto riguarda la lunghissima pagina di discussione, è proprio il “frame” della discussione ad essere ideologicamente orientato. In quella discussione vari utenti si sono scannati per anni per decidere quale bandierina mettere per i partigiani, quale per i combattenti della X Mas, eccetera. E’ questo “frame” a essere “di destra”, anche se è accettato pure da quelli che in quella discussione si schierano “a sinistra”. Quel frame impone che si tratti di stabilire per quali interessi nazionali combattevano gli uni e gli altri. Mentre con tutta evidenza si trattò di un episodio (a dir poco marginale) di una guerra europea (mondiale) combattuta dagli alleati contro il nazifascismo. Come nel resto d’Europa, priorità e necessità concrete travalicavano il piano nazionale, basti pensare al fatto che la X Mas era inquadrata nelle forze armate tedesche – insieme ai collaborazionisti domobranci e cetnici – e che l’intera zona della “Venezia Giulia” dal settembre ’43 era territorio del Terzo Reich. Paradossalmente, e forse al di là delle loro stesse intenzioni, sono proprio i fascisti di oggi a ricordarci quali fossero i termini della guerra che si stava combattendo allora. Infatti quando imbrattano il monumento ai partigiani caduti nella zona di trnovo tra il ’41 e il ’45,, lo fanno disegnando svastiche e inneggiando a Hitler.
Caro Tuco, ti rispondo personalmente sulla questione “Tarnova” perché credo di essermi fatto una bella cultura sull’argomento, proprio grazie al lavoro su quella voce.
Premessa necessaria: la voce non nacque per un motu proprio del sottoscritto, ma dietro richiesta, tant’è che dovetti faticare non poco a trovare materiale oltre quello che già possedevo sulle forze armate della RSI.
Quello che tu affermi circa il fatto che la battaglia sarebbe solo un feticcio da nostalgici della Decima in Italia è sbagliato. In Iugoslavia e nei paesi successori la “battaglia” di Tarnova (poi ti spiego le virgolette) è un episodio considerato, anche perché nonostante le alte perdite fu una sconfitta inflitta alle forze italotedesche di cui gli eredi della resistenza iugoslava vanno fieri.
E qui ci tengo a rivendicare (tanto per smentire un bel po’ di scemenze lette da ‘sti pizzi) che fui io personalmente a introdurre nella voce le fonti di parte partigiana in croato e sloveno, fui io a spostare progressivamente, man mano che col lavoro sbucavano fuori nuovi elementi, l’esito della battaglia dal reducista “vittoria italiana” a “vittoria iugoslava”, e già che ci sono, rivendico anche di non aver avuto la minima esitazione a voler inserire un riferimento di un noto ricercatore dichiaratamente antifascista a certe atrocità fasciste commesse sui civili (vedi più oltre, però).
Lo scannamento di cui tu parli per la “bandierina” è tutt’altro che un banale flame da fanatici di modellismo militare o da nostalgici del bel tempo andato, ma riguardò la non secondaria considerazione dell’appartenenza organica dei reparti formati da italiani che combattevano con le divisioni partigiane iugoslave. E’ importante non foss’altro per la categorizzazione dell’evento storico. Come sapresti se avessi letto il libro oltre alla recensione, il fatto di categorizzare il sapere con un “indice degli indici” è uno dei principali atout di Wikipedia. Per questo anche un dettaglio da nerd che giocano coi soldatini può avere la sua importanza.
Ora ti spiego quelle virgolette su “battaglia” di cui sopra. Le ho messe perché con me sfondi una porta aperta sull’episodio “a dir poco marginale”. Al di là delle considerazioni di merito, in generale si parla di “battaglia” in termini di storia militare quando ci sono combattimenti fra unità della dimensione di un reggimento in su. Per combattimenti fra reparti si parla generalmente di “scontri”.
Se ti leggi la discussione della voce ho anche cercato di proporre la questione, ma siccome il termine prevalente tanto nella letteratura italiana quanto in quella iugoslava è “battaglia”, come wikipediani non si poteva far altro che tenerci questo nome.
Concludo con un ultimo accenno a un aspetto tutt’altro che secondario che è emerso proprio grazie a quelle discussioni che secondo te non furono importanti.
Nel dibattito molto serrato e a tratti violento che c’è stato su quella voce noi wikipedisti riuscimmo a ottenere due risultati che dimostrano come l’Enciclopedia – al di là d’ogni suo scopo iniziale – si sia evoluta a un livello che era inaspettato.
Nel primo caso il lavoro d’inchiesta di un wikipedista – Presbite – riuscì a impedire la pubblicazione di un dato storico FALSO (ancorché accreditato da un ricercatore di una certa fama): si tratta di quelle “atrocità fasciste” di cui sopra che io avevo inserito a carico delle truppe della RSI e che invece si rivelarono un’invenzione del ricercatore in questione. Normalmente un wikipedista non dovrebbe fare troppa esegesi delle fonti (figuriamoci ricerca originale per confermarle o smentirle…) ma in questo caso si decise che il fatto era troppo palesemente tarocco perché potesse essere riportato.
Nel secondo caso PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA – dove l’argomento era rimasto appannaggio di neofascisti e nostalgici assortiti – si dava un resoconto neutrale e oggettivo di quell’episodio, sostanzialmente riducendolo nelle sue proporzioni da “Termopili della Xa MAS” a banale scaramuccia di frontiera, ma anche enucleando la progressiva distorsione della memoria effettuata dai reduci, che avevano trasformato una legnata inferta dalle divisioni partigiane iugoslave in una specie di “vittoria” che in realtà non ci fu mai se non nei proclami della propaganda. Ovvero, Wikipedia aveva FATTO RICERCA. La comunità, non certo volendolo, aveva prodotto informazione nuova, aveva fatto assumere a un fatto storico (un fattarello, siam d’accordo) una connotazione del tutto diversa da quella che aveva avuto fino ad allora sulla letteratura italiana di riferimento.
EM
La “battaglia di Tarnova” non è oggetto di nessuna celebrazione in Slovenia, nè lo è stata in Jugoslavia, tanto è vero che non c’è nessuna targa che la ricordi, mentre c’è un monumento alle migliaia di partigiani caduti nei quattro anni di guerra nella zona di Trnovo. La voce “battaglia di Tarnova” non esiste in nessuna delle lingue della ex Jugoslavia. Una ricerca con google per “bitka za trnovo” restituisce 261 occorrenze; per “bazoviški junaki” 2960; per
“bitka na neretvi” 110.000. Come dire, mi sa che la Neretva ha un pochino più peso. Poco, eh, non tanto. Eppure la voce italiana sulla battaglia della Neretva è lunga un quinto di quella sulla “battaglia di Tarnova”. Le “fonti slovene” che hai inserito sono due capitoli di due tesi di laurea. Nella prima tesi c’è una pagina e mezza sulla battaglia di Trnovo, inclusa una cartina. Nella seconda tesi, i dati sono tratti da un libro di Jože Šušmelj. Fammi capire: ti vanti di avere introdotto fonti slovene e poi citi la tesi invece di citare il libro da cui sono tratti i dati? All in all, non mi pare che tutto ciò indichi un particolare interesse della storiografia slovena per quell’episodio. Che si sia discusso per anni sulla “battaglia di Tarnova” per poi concludere che si tratta di un non-argomento è surreale. Non so con chi tu creda di avere a che fare, ma ti assicuro che qui sei capitato male, molto male.
Tesi di laurea, poi. Nemmeno di dottorato. E nessuna delle due è una tesi di storia: una in scienze sociali, l’altra in scienze umanistiche. E dedicano alla presunta “battaglia” poche pagine. Queste sarebbero le “fonti slovene e croate” che Mastrangelo ha meritoriamente inserito ecc. ecc., probabilmente raccattate giostrando alla bell’e meglio tra google e google tranzlejt. Lo dico anch’io: qui certe cose non le puoi propinare. Qui sloveno e croato si parlano. Qui la storia del confine orientale la conosciamo. Sei capitato male davvero.
Il punto, comunque, è che di “fonti” così, e anche più sdozze di così, le pagine della Wikipedia italiana dedicate a fascismo e dintorni sono piene zeppe, a suo tempo ficcate dentro dal grande storico (che qui prova a fare il mellifluo mentre su FB scrive, virilissimo, “se mi girano le corna scatta la querela”) e oggi difese da utenti… nazionalpatriottici. Bonificare quelle voci non sarà semplice, ma è fattibile, e certe “pezze d’appoggio” si dissolvono al minimo fact-checking.
Ancor più facile è verificare se un libro esista davvero. A questo proposito c’è da chiedersi come mai l’utente Presbite, che per anni ha presidiato voci come “TIGR” e altre sulla storia del confine orientale, e sembra così puntiglioso, non si sia mai accorto che il libro “Assassini della storia” era stato inventato di sana pianta da un utente, AleR, con cui collaborava spesso e alle cui richieste di sostegno in discussioni accese rispondeva lesto e pronto a spaccare il capello “in ottantaquattro”. Quel libro falso non era un capello, era un tronco, un tronco marcio e fetente, eppure – toh! – Presbite non lo vide né parve sentirne il lezzo. Strano.
Buon giorno a tutti. A me della captatio benevolentiae non me ne frega una beata fava. Per cui dico chiaro e tondo che per quel che mi concerne – e cioè per i riferimenti a me personalmente fatti – l’articolo di Talia è merda secca.
Così come è merda secca l’alato commento di Wu Ming 1 qui sopra.
E lo dimostro.
I fatti dovrebbero prendere il sopravvento sulle opinioni, giusto Wu Ming 1? Dovresti saperti destreggiare con le fonti tu, dico bene? E allora prova a fare una verifica della veridicità del fatto che io abbia “presidiato” la voce sul TIGR. Controlla qua: https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=TIGR&offset=&limit=500&action=history
Domanda: quante volte l’utente “Presbite” (cioè io) ha scritto sulla voce “TIGR”? Risposta: Z-E-R-O. Nemmeno UNA volta!!! Cioè: la voce – così come s’è sviluppata nel corso della sua storia – non è stata scritta da me NEMMENO PER UNA SINGOLA PAROLA.
E questo sarebbe “il controllore”. Questo sarebbe il “fascio” che monitora questa voce e ne dirige il traffico. Questo è il tizio che inserisce contenuti “fasci” nella voce sul TIGR. Uno che non ha scrittto – e lo ripeto – NEMMENO UNA SINGOLA PAROLA nella voce.
Tutto il profluvio di cazzate che si possono poi scrivere a latere di quanto sopra (tipo: “Presbite non si è accorto che c’era un libro farlocco nelle fonti!”) derivano da questa prima, grande, incommensurabile cazzata.
Compreso il fatto di esser identificato come “fascio” o robe del genere, sulla base di meno di dieci esempi su circa 18.000 edit che io ho fatto in WP, presi alla cazzo di cane e stravolti financo nel loro contenuto con sapienti taglia/cuci che farebbero inorridire un qualsiasi studentello del primo anno di storia.
In altre parole: il lavoro sulle fonti effettuato dal Talia fa ca-ga-re (per quel che riguarda i riferimenti al sottoscritto).
E buona camicia a tutti.
Il 25 gennaio 2013, qui, Presbite scrive:
«io invece sommessamente ti faccio rilevare che la voce TIGR sta fra i miei osservati già da lunga pezza. E fin da quando ho iniziato a intervenire, ho notato esplicitamente lo stato precario di questa voce, invocando per evitare problemi che si procedesse attraverso un’attenta analisi delle fonti. E’ stata fatta ‘sta cosa? Manco per il piffero!»
Meno di due mesi dopo, il 16 marzo, nella discussione dove si decidono le sorti di AleR scoperto a inventarsi le fonti, Presbite scrive il contrario:
«Lo confermo e ribadisco: senza che ”nessuno” dicesse niente. Io non l’avevo fra gli osservati, d’altro canto non parlando lo sloveno non mi sento in grado di scrivere secondo quel che richiedo a me stesso in termini di competenza.»
Perché Presbite scrive l’esatto contrario di quel che affermava poche settimane prima?
Forse perché se in quel contesto ribadisse di aver tenuto a lungo la pagina TIGR sotto osservazione, farebbe la figuretta di chi non si è accorto di una falsificazione peraltro grossolana?
Proviamo a vedere cos’è successo nel frattempo.
Il 12 settembre 2012 l’utente Theirrules contatta Presbite nella sua pagina utente e scrive:
«Segnalo: c’è un tentativo di far passare il TIGR come un’organizzazione patriottica, ovviamente facendo perno sull’antifascismo, con il risultato che l’ultrnazionalismo che ne permeava le azioni e i metodi terroristici (attentati dinamitaridi, omicidi) vengono oscurati. Un parere sarebbe gradito. Ciao! —- Theirrules yourrules 16:31, 19 set 2012(CEST)»
Come si vede, Theirrulles chiede aiuto a Presbite dando per scontato che sia un conoscitore del TIGR, disposto a difendere insieme a lui la voce contro chi «fa perno sull’antifascismo». I due si conoscono, e Theirrules dà per scontata un’intesa.
Presbite, dal canto suo, risponde alla chiamata con autentico entusiasmo e, nella pagina di discussione sulla voce TIGR, alza una barricata di commenti lunghissimi. Di fatto, imperversa e monopolizza la discussione per tutto l’autunno 2012 e per quasi tutto l’inverno 2013. Nella pagina, il nome “Presbite” ha ben 58 occorrenze.
“Non toccare mai” (cit.) la pagina stessa e al contempo riempire di sé la discussione, opponendo un’estenuante resistenza alle modifiche proposte e argomentate da altri utenti: questa è una definizione da manuale del “presidiare una voce”.
Tra le altre cose, Presbite scrive:
«Ciò che ritorno a dire è: a me non pare che abbiamo afrontato adeguatamente la prima fase (accumulo delle fonti), ma che dipendiamo troppo da vari articoli internettiani, azzardando ipotesi ricostruttive non adeguatamente fontate. La qual cosa a me – personalmente – non sfagiola poi così tanto. Ad ogni modo, se tu sei convinto di avere le fonti sufficienti per modificare in modo importante questa voce fa’ pure, rispettando ovviamente le nostre regole. Soprattutto quella relativa alla citazione delle fonti. Occhio però: ti avverto subito che sono assai scorbutico e spacco il capello non in quattro, ma in ottantaquattro…– Presbite msg 20:31, 7 nov 2012 (CET)»
Alla luce di quello che si è appena appurato sulla voce “Battaglia di Tarnova”, è un passaggio molto buffo. Del resto, qui vediamo Presbite usare come fonte sul TIGR un blog, questo. E a un certo punto sembra ricorrere come fonte alla propria testimonianza oculare (!):
«E io ribadisco: se i testi da cui tu prendi queste carabattole affermano effettivamente quello che tu affermi, allora per quello che riguarda l’episodio specifico sono da prendere e gettare nel cesso. Abbi pazienza: tu sai dove si è verificato l’assalto? L’hai mai visto come l’ho visto io? E se l’hai visto o hai un minimo di idea dei luoghi, come puoi pensare che sia corretto dire che i colpi siano stati sparati a “elettori in fila a un seggio”? Ma quale seggio? (…) Presbite 10:57, 22 gen 2013»
Ancora: se si parla di attenzione alle fonti, insistere sul fatto che si sia dato a Presbite del fascista, quando in tutto il post di Salvatore qui su Giap ciò non avviene neanche di passaggio, è un altro esempio di distorsione. In questo caso la falsificazione è palese perché non c’è da andare a consultare la biblioteca comunale di Opicina, basta leggere poche righe sopra.
Intanto, nell’inverno 2013, discutendo della voce TIGR, si scopre che Assassini nella storia è un libro inventato da AleR. Sulle prime Presbite fa lo gnorri:
«Io non lo vedo come “mistero”. IMHO questo testo non ha da esser qui dentro. Potrebbe trattarsi benissimo di saggio autoprodotto, ma al di là di ciò l’autore è totalmente ignoto. Per me si può espungere tranquillamente, fermo restando il principio generale da me già enunciato: leggiamo prima le molteplici fonti, e dopo formuliamo il testo da mettere in NS0, quando i nodi della vicenda del TIGR saranno ben evidenziati e almeno in parte risolti.– Presbite (msg) 14:50, 25 gen 2013 (CET)»
ma qualcuno gli fa notare:
«Presbite, vedo che non hai colto il punto. AleR ha citato come fonte un libro, “Assassini nella storia”, che sarebbe stato stampato dalla Editgroup quando la Editgroup ancora non esisteva. Capisci qual è il problema?– TBPJMR (msg ) 14:40, 26 gen 2013(CET)»
«Presbite, forse (dico “forse”) stanno cercando di dirti che potrebbe (dico “potrebbe”) essere un caso di fonte inventata, con tutto quello che ciò comporta su Wikipedia.»
Presbite, a quel punto, lascia il commento più breve della sua carriera d’utente WP:
«Ma va?– Presbite (msg) 13:47, 28 gen 2013 (CET)»
E si ritira dalla discussione.
…Per ricomparire dove si discute del ban ad AleR.
E qui comincia un’altra avventura :-)
Sì, sì, Wu Ming 1. Tutta ‘sta marea di parole non riesce a scalfire manco di striscio l’univa verità vera: io NELLA VOCE non ho scritto UNA PAROLA. La fuffa che spargi qui sopra a stracazzo di cane come il Talia ovviamente è totalmente distorsiva.
Io – e mi tocca ripeterlo per la quarta volta – non ho scritto UNA SINGOLA PAROLA all’interno della voce.
I meccanismi attraverso i quali ne sarei addirittura “il controllore” sono delle pippe mentali.
Avendo scritto 123 voci in itWiki, tu e tutta l’allegra ocmbriccola dei raccontaballe qui sopra (specifico che parlo sempre in riferimento a me stesso) avete amplissima possibilità di DIMOSTRARE che il sottoscritto ha inserito argomenti fascistoidi o tematiche fascistoidi nell’enciclopedia.
Le balle stanno a zero, Wu Ming 1: se sei capace di sottoporre a verifica ciò che io ho scritto allora accomodati. Ho scritto soprattutto di storia del confine orientale: non sei un esperto sul tema? Qui non è pieno di esperti della questione? Prego: accomodatevi tutti quanti.
Prendete le voci che io ho scritto e sottoponetele ad ampia critica.
Datevi da fare, invece di pippare la grande calumet dell’acqua nel mortaio.
Prendete in mano quel cazzo di libri, e fate quel che Talia propone: difendete Wikipedia dai fasci.
Altrimenti, di che cazzo stiamo parlando? Della psicopolizia? Di che cazzo parliamo io e te, Wu Ming 1? Di quel che sta scritto il giorno 3 marzo 2010 in una talk, rispetto a quel che sta scritto il giorno 21 aprile 2013? Di queste ca-ga-te è fatto il tuo ragionamento (e quello di Talia)?
Un intervento così da troll su un sito come Giap non mi sembra che aiuti a tenere alto il livello del dibattito e sentendomi sia giapster sia wikipediano mi sento un po’ in imbarazzo. Ci sono degli intellettuali di rilievo del panorama culturale italiano che ospitano sul loro sito una riflessione sul Progetto (naturalmente, con lo stile e il punto di vista che è loro proprio), che aprono le porte a una discussione con la comunità di Wikipedia… e vorremo mica perdere l’occasione per venire qua a sbracare e a inanellare turpiloquio e provocazioni come se considerassimo Wikipedia una nostra proprietà personale su cui nessuno può pronunciarsi? Eppure la licenza con cui è rilasciata l’Enciclopedia parla chiaro: neppure ciò che uno scrive dentro Wikipedia con la sua firma sotto è una sua proprietà personale! Se è una cosa di tutti, tutti devono sentirsi non solo autorizzati ma addirittura *invitati* a parlarne.
Per fortuna non è questo l’atteggiamento maggioritario tra chi opera su Wikipedia e se il libro di Mastrangelo & co. mette proprio uno come Presbite tra i contributori da cui prendere esempio… qualche domanda me la faccio. Incredibile anche che una reazione del genere non sia avvenuta rispetto al libro di Mastrangelo che viene pubblicizzato con toni apocalittici contro il Progetto dipinto come quasi irrimediabilmente corrotto e dominato in modo orwelliano da una cricca stalinista. Basti dire che la pagina Facebook del libro si chiama “Wikipedia1984″… A me *questo* fa incazzare, semmai. E comunque pur incazzandomi sono d’accordo con l’approccio di Salvatore: recuperiamo questo libro che nessuno ha notato dall’angolo più buio di qualche libreria di destra e parliamone, perché è così che si affrontano le questioni.
Ora, per chiarire i termini della questione ai profani: anche un contributore minore di Wikipedia come il sottoscritto sa benissimo che non intervenire mai sulla voce ma scatenarsi con 58 commenti aggressivi contro qualsiasi modifica, dopo essere stato chiamato a farlo da un altro utente su basi ideologiche preconcette, è proprio il modo di tenerla in scacco. Anche espressioni come “prendete quei cazzo di libri e provateci” sono molto indicative di una certa concezione criticata nel post, che ho visto messa in pratica molte volte sia nella Wikipedia in italiano sia in quella in inglese: conquista e occupazione militare di voci, con i piantoni armati di citazioni farlocche messi a presidiarla come i due scemi che si danno il turno a Predappio alla tomba del bungee jumper.
L’elemento che trovo equilibrato e al tempo stesso potente del post di Salvatore è invece che non vagheggia una Wikipedia epurata dagli utenti politicizzati e dai conflitti politici, ma neppure mostra di intenderla come una rissa in cui ciò che conta è urlare più forte e/o avere gli agganci giusti. È un tema ricorrente in ciò che scrivono i Wu Ming e in ciò che si scrive qua su Giap che “il campo di battaglia è ovunque”, le contraddizioni e i conflitti fanno andare avanti il mondo, ma da bravi marxisti molti di noi ritengono che parte del processo dialettico della realtà sia il momento della sintesi, che non è mediazione o cancellazione del conflitto, ma suo frutto.
Ciò che trovo interessante di Wikipedia è che ogni voce sia modificabile all’infinito ma abbia comunque una versione unica: non si può fare la versione fascista di una pagina e la versione comunista di una pagina, ne esiste una sola. Questa è la ricetta del conflitto, ma è anche l’aspirazione alla sintesi. Il modo in cui agiscono quelli che presidiano le pagine e fanno gli azzeccagarbugli è un tentativo di espungere il conflitto (quindi la realtà materiale, quindi, in prospettiva, la tendenza alla verità) da Wikipedia. Noi, invece, vogliamo praticarlo e incorporarlo.
Lungi da me l’intenzione di troncar l’ali alla tua sacrosanta indignazione, Presbite, ma potresti dirmi qualcosa di più sull’espressione “pippare la grande calumet dell’acqua nel mortaio”?
Incontro questa locuzione oggi per la prima volta e sono molto interessato a scoprirne significato e origine.
Grazie in anticipo.
Ecco come furono trovate, discusse e inserite le famose “fonti slovene”. Presbite tira fuori con google una tesi di laurea, Mastrangelo prova a tradurre con gogol tranzlejt, e rimane shockato dal fatto che secondo gli autori sloveni la “battaglia” non si concluse affatto con una vittoria dei nazifascisti. Alla fine però scrive:
Una riflessione a margine mi sovviene da questo confronto impietoso fra le fonti italiane (di parte e non) e quelle iugoslave. Che le prime, scrostate da retorica e apologie varie se e quando necessario, sono mediamente attendibili, coincidono coi documenti (fotografie, monumenti etc.) e in ultima analisi superano la prova del nove, mentre le altre si devono prendere cum grano salis. Naturalmente se inserire anche queste fonti può servire ad ammorbidire una certa rigidità verso le fonti italiane (che sembra essere legata più al nome degli autori che non al merito di quello che scrivono) ben venga.
PS Le fonti italiane di cui parla Mastrangelo sono quelle della pubblicistica dei reduci della R.S.I..
Questi non sanno lo sloveno e il croato, trovano le “fonti” nella prima schermata di google, le”traducono” come viene viene con google tranzlejt, ma fanno “confronti impietosi” tra storiografia slovena e italiana. Bravi tutti. Altissimo livello. Autentiche promesse della ricerca.
Basti vedere che qua
traducono “zavzetje”, che vuol dire conquista, con “investimento”.
sarebbe interessante se presbite ci spiegasse come mai in questa occasione non si è sentito in dovere di “spaccare il capello in ottantaquattro”.
Tuco, forse se ti fossi sforzato un po’ di più avresti notato anche un certo Stanko Petelin fra le fonti citate, né a questo punto abbiamo voglia di star qua a spiegarti che dall’altra parte della frontiera l’episodio è inquadrato più correttamente nell’ambito in una campagna militare, mentre da noi è preso singolarmente per i succitati motivi di “epica reducistica”, da qui la differenza di occorrenze se lo cerchi singolarmente… Ma siccome voialtri la storia del confine orientale la sapete bene, che ve lo spieghiamo a fare? #voiricordatetutto, giusto?
A WuMing1 ci corre obbligo di far notare che quello che lui scambia per “mellifluità” e Tuco “captatio benevolentiae” e una ragazza più sotto sarebbe sarcasmo. E’ evidente che siamo stati troppo sottili noi, a meno di aver di fronte degli ottusi totali, cosa che non può essere. Un ottuso totale, per esempio, è uno che commenta un libro senza averlo letto e senza essere Flaiano. Oddio, forse abbiamo scelto l’esempio sbagliato…
Nel merito di “Tarnova”, semplicemente derubricare la voce “Battaglia di Tarnova” a paragrafo di altra voce non avrebbe senso, proprio perché ci sono fonti italiane che ne parlano. Il paragone con altre voci battaglie, ancora una volta, non ha senso nella prospettiva wikipediana: un Pokemon su Wikipedia potrà avere la stessa dignità e lo stesso spazio dedicato a un Nobel per la pace come Albert Schweitzer.
Ne consegue che dei meccanismi interni di Wikipedia non avete capito un beneamato. Bocciati. Non possiamo che rimandarvi alla lettura (di prima mano, non tramite digesti\recensioni) del nostro libro. Dovete bere l’amaro calice, insomma o tenervi la vostra supponente ignoranza in materia.
Tarnova è grande rispetto a voci con eventi paragonabili, ed è cresciuta proprio per darne una visione neutrale. Altrimenti sarebbe facile ridurla (grazie ad uso strumentale di fonti italiane) alle “Termopili della Repubblica di Salò”.
Lo sappiamo che a voi farebbe comodo farla tornare a quello standard, perché sia attaccabile e quindi cancellabile (sì #voiricordatetutto, ma è sempre meglio fare un po’ di selezione di ciò che va ricordato e ciò che va passato al tritadocumenti prima, vero?). Purtroppo non è così: le fonti citate, nonostante il vostro berciare su tesi o non tesi, sono accettabili per il livello dell’episodio storico, e non sarà certo ripetere a pappagallo che #voiricordatetutto come mantra per autoconvincervi a modificare la dura realtà. Vivere sotto la campana di vetro dell’ideologia è comodo. Ma presto o tardi dovrete crescere e uscirne.
Quello che è incredibile è che perfino nella discutibilissima ottica della vostra visione ideologica del mondo una voce di Wikipedia che va a depotenziare e demitizzare quello che è un moloch del reducismo repubblichino dovrebbe essere salutata con interesse. Invece siete talmente fossilizzati che avete reazioni da pugile suonato. Se leggete “Decima MAS” è peggio del gong: scatta la guardia alta e il gioco di piedi un-due un-due…
PS. “Investire” ha anche un’accezione nel linguaggio militare. Ma leggere la Treccani prima di postare no?
In quest’altra citazione virgolettata tratta dalle famose fonti slovene (in questo caso un anonimo sito croato)
“Il nemico ha subito una pesante sconfitta: il battaglione fascista a Tarnova è stato quasi distrutto e i resti del battaglione dovettero ritirarsi a Gorizia. Tarnova è di nuovo nelle nostre mani”
guarda caso si dimenticano di tradurre che secondo la fonte furono i tedeschi a dover ritirare i resti del battaglione a Gorizia. Dimenticanze freudiane?
Una delle frasi di Stanko Petelin citate in voce è questa:
“Il nemico ha subito una pesante sconfitta: il battaglione fascista a Tarnova è stato quasi distrutto e i resti del battaglione dovettero ritirarsi a Gorizia. Tarnova è di nuovo nelle nostre mani”
Peccato che, come ha osservato Zora, chi ha tradotto e inserito la frase si sia dimenticato di tradurre e inserire il passaggio in cui Petelin dice che furono i tedeschi a dover ritirare i resti del battaglione a Gorizia.
Per il resto, è esilarante che adesso Mastrangelo si ponga come quello che ha depotenziato il mito della “battaglia di Tarnova”, quando basta guardare come l’aveva scritta quella voce – con tanto di proclama del principe Junio Valerio Borghese e di inno del battaglione Fulmine – prima che qualcun altro gli facesse notare che forse aveva un po’ esagerato.
Nemmeno il coraggio di mantenere la propria posizione.
In effetti, a leggere tutta la discussione qui e su WP dietro a quella verbosissima voce sul 19-21 gennaio ’45 a Tarnova (che sembra cruciale quanto lo sbarco in Normandia) sembra – per usare una metafora – che Mastrangelo sia stato prima con la X Mas nel presidio di Tarnova, per poi passare disinvolto coi partigiani non appena questi lo hanno attaccato facendolo saltare.
Mi sono laureato in storia contemporanea con Joze Pirjevec, decisamente uno dei massimi storici sloveni, ho fatto corsi di perfezionamento post-laurea in storia contemporanea a Lubiana e ho partecipato a diversi convegni organizzati sia dall’università di Lubiana che quella del Litorale (Capodistria-Koper) sulla seconda guerra mondiale, ho collaborato con l’università di Fiume, ho letto pubblicistica sul periodo in sloveno e croato, ma di questa fantomatica battaglia di Ternova che gli autori sostengono essere un “episodio considerato in Jugoslavia e nei paesi successori” non ho mai sentito parlare.
Purtroppo è saltata la citazione da Miyazaki che chiudeva il precedente post. La riporto:
“I’m not an agnostic or anything, but I don’t like a society that parades its righteousness. The righteousness of the U.S., the righteousness of Islam, the righteousness of China, the righteousness of this or that ethnic group, the righteousness of Greenpeace, the righteousness of the entrepreneur…. They all claim to be righteous, but they all try to coerce others into complying with their own standards. They restrain others through huge military power, economic power, political power or public opinions.”
Mastrangelo & Petrucci: mi spiace deludervi, ma temo proprio che, se il vostro saggio ha avuto pochissima risonanza prima della mia recensione, la cosa non sia dovuta a chissà quale congiura del silenzio ai vostri danni, bensì più semplicemente al fatto che si tratta di un libro di qualità piuttosto scadente. E non mi riferisco alla veste tipografica, molto ben curata e che dimostra una notevole fiducia (mal riposta) accordatavi da chi ha patrocinato e condotto l’operazione editoriale. Parlo proprio del contenuto. A dirla tutta, se fossi nei panni di De Turris o dei manager della Bietti, sarei molto seccato per la sonante patacca che siete riusciti a rifilare loro.
Un merito reale il vostro libro ce l’ha, e ve l’ho riconosciuto: è il primo studio uscito in Italia avente ad oggetto Wikipedia, cioè un fenomeno rilevantissimo e degno di parecchia attenzione, che inspiegabilmente ne ha riscossa finora troppo poca da parte del mondo accademico e culturale in senso lato. Purtroppo il vostro tentativo si configura come una grande occasione mancata.
Per produrre uno studio approfondito sarebbe servito un ben maggiore impegno scientifico, rigore metodologico e una seria preparazione di base che, a quanto pare, non avete. Esempi se ne potrebbero trovare parecchi. Lo scivolone su Gramsci l’ho già segnalato nel corpo della mia recensione. Qui aggiungo un altro esempio della vostra leggerezza metodologica. Ad un certo punto, per spiegare il fenomeno del formarsi (a vostro dire) di una casta orwelliana di inamovibili e potentissimi admin, tirate in ballo Roberto Michels e la sua “ferrea legge delle oligarchie”. Poche pagine dopo, proponete una serie di riforme in senso “democratico” delle regole di it.wiki (alcuni parlerebbero di misure di tipo populista); riforme che, secondo voi, dovrebbero appunto impedire il formarsi di oligarchie. Il tutto senza nemmeno accorgervi della contraddizione: Michels chiamava “ferrea” la legge sociologica che riteneva di aver scoperto, in quanto secondo lui tale legge era immodificabile, non ammetteva eccezioni di sorta ed era del tutto illusorio pensare di sfuggirle. Per Michels era tutt’al più possibile sostituire a un’élite di autocrati un’altra, formata da persone diverse, ma con le stesse caratteristiche antidemocratiche. Ma non penso sia questo il vostro progetto, vero?
Quanto alla presunta “odiografia” nei suoi confronti, Mastrangelo si sbaglia. Non ho nulla di personale contro di lui; in un paio di occasioni in cui ci siamo confrontati direttamente sulle talk pages di Wikipedia (ancora non mi spiego bene come sia stato possibile, visto che in teoria lui era già stato bannato; ma vabbé), abbiamo discusso in modo, credo, abbastanza pacato e senza nessun astio. Magari le discussioni su Wikipedia fossero tutte così!
E’ vero, ho voluto dare delle informazioni sull’attività di Mastrangelo, del resto non utilizzando qualifiche di mio conio, bensì citando una fonte che su Wikipedia sarebbe considerata autorevolissima (il prof. Gabriele Turi, a differenza di Mastrangelo, è uno storico, è stato docente presso l’università di Firenze ed ha un curriculum accademico di tutto rispetto). Questo perché, dopo la sua espulsione da Wikipedia, Mastrangelo ha cercato di costruirsi una reputazione di martire del libero pensiero, perseguitato dalla “cricca” mediante accuse false di manipolazione delle fonti.
Come spiego nel mio pezzo, leggendo i dibattiti relativi appare chiaro che Mastrangelo non è stato bannato per una singola falsificazione di fonti, e neanche per una serie ben determinata e circoscritta di manipolazioni. E’ stato bannato per il suo comportamento complessivo dentro it.wiki, che gli ha fatto perdere la fiducia della comunità e ha fatto venir meno la presunzione di buona fede nei suoi confronti. Quello che lui ha subìto, infatti, non è un processo penale, dove il capo d’imputazione dev’essere contestato fin dall’inizio all’imputato e non può mutare nel corso del procedimento. Le regole di Wikipedia dicono che la segnalazione di problematicità è riservata “agli utenti registrati che, ignorando ogni avvertimento, mettono in atto comportamenti in grado di danneggiare Wikipedia”. Nel suo caso è accaduto che dopo la segnalazione sono emersi molteplici elementi che hanno dimostrato un fatto molto semplice: il fatto che Mastrangelo volesse usare Wikipedia per fare propaganda politica e ideologica. Prego, a questo punto, di tornare al mio articolo e di rileggere i punti da 1) a 5). Questo atteggiamento di fondo di Mastrangelo è dimostrato dal tenore politicamente orientato dei suoi interventi nell’Enciclopedia ed è confermato dalla sua attività fuori di Wikipedia, eloquentemente caratterizzata dal prof. Turi.
Tra parentesi: trovo incredibile che gli amici di Mastrangelo rimasti in it.wiki ancora oggi cerchino qualunque occasione per chiedere la “revisione del processo” e la riconsiderazione delle “prove a carico” di Mastrangelo. Come se il problema fosse sul serio quello di appurare se lo storico tale, alla pagina tale del tale libro, ha veramente scritto che Mussolini aveva appuntamento a Gravedona il 27 aprile del ’45 con un emissario dell’imperatore Ming, che lo avrebbe condotto a bordo di un astronave sul pianeta Mongo per continuare la lotta contro il bolscevismo intergalattico. Allo stato attuale degli studi storici, se anche Mastrangelo trovasse cento citazioni “autentiche” a supporto della tesi che Benito Amilcare cadde eroicamente in uno scontro a fuoco con Flash Gordon, il suo tentativo di imporle in una voce di Wikipedia lo qualificherebbe lo stesso come poco interessato al progetto enciclopedico.
Inoltre: non ho affatto detto che per voi Wikipedia debba essere un “blocco granitico”; ho detto che, nella vostra visione, Wikipedia dovrebbe essere una comunità priva di contraddizioni interne, dove i diversi punti di vista si compongono sempre e comunque in armonia. Infatti il conflitto lo vedete portato dentro da “furfanti” che si sono impadroniti del potere.
Due parole su Miyazaki e Orwell. Le vostre considerazioni sul Maestro giapponese sono interessanti, ma anche disperatamente off topic in questa sede. Chiunque può vedere che non ho inteso affatto “arruolare” Miyazaki e che di lui, della sua poetica, dei suoi film ecc. non si parla minimamente nel mio articolo. Ho soltanto preso spunto da uno stralcio di discussione in it.wiki, da cui emerge una particolare “sensibilità” da parte di alcuni utenti per i quali l’antifascismo in quanto tale sembra essere un problema. Voi, piuttosto, dovreste avere qualche remora ad arruolare Orwell nella vostra crociata anti-antifascista. Permettetemi di avere qualche dubbio sull’ipotesi che in Spagna nel 1937 voi e il grande scrittore inglese vi sareste ritrovati a combattere dalla stessa parte. Sed de hoc satis, come dite voi.
Fammi capire: il problema adesso qui dentro e’ che wualcuno scrive “cazzo” e “pippare”? E che siamo, alle orsoline? Volete un colloquio fra gentlemen, tipo club inglese? Dopo aver ospitato questo po-po di cesso d’articolo di Talia, che da’ del fascio a destra e a manca a cazzo di cane? Parlando poi con uno che non sa nemmeno contare (non ho scritto 58 interventi in talk: quello e’ il numero di frequenze del nome “Presbite” nella pagina)? Resta il dato di fondo: volete spaccare il cul al sottoscritto fascistone? Venite a riscrivere le voci che ho scritto. Il resto sono vac-ca-te. PS “dal” calumet. Se ancora non si capisce, lo riscrivo in altro modo che di gran fuffa si parla qui dentro (almeno per quel che riguarda me). A proposito: non ho letto il libro di Mastrangelo. Ecco perche’ non me la sono presa con lui. Sono uso ad informarmi, prima.
Non ce ne sbatte niente di quante parolacce si usino, non è quell’aspetto a connaturare un comportamento da troll. Il problema è naturalmente l’intenzione che sta dietro a un commento. Se uno interviene su Wikipedia o su Giap con l’obiettivo di offuscare una discussione e mandarla in vacca o in stallo e in questo modo impedire che una voce dica la verità sui fascisti del 1943-1945, nel caso di Wikipedia, o del 2011-2014, nel caso di Giap, si sta comportando da troll.
Un sistema efficace che si può utilizzare è quello di “spaccare il capello in ottantaquattro”, simpatica espressione dello stesso Presbite su Wikipedia (su Giap avrebbe detto “frantumare la minchia in ottocentoottanta-fottuti-quattro”). Per esempio si può dire che l’interlocutore non sa contare perché dice che gli interventi di Presbite in discussione sono stati 58, quando in realtà sono stati 37 (ho appena controllato), perché oltre ai 37 suoi interventi ci sono state 21 menzioni. Tecnicamente, ha ragione Presbite, ma la sostanza non cambia.
Oppure, altro dispositivo retorico interessante: Talia è cauto nel dare del fascista a questo o quell’utente, inclusi quelli che palesemente lo sono, a partire dalla scelta dell’alias. Eppure tutti gli utenti che sono stati criticati nel post si sono inalberati dicendo “Mi hanno dato del fascista!”, mentendo e tentando di spostare la discussione sul loro vittimismo. Qualcuno di loro ha pensato di dire “Io non sono fascista, in realtà la penso così e cosà e non ho mai avuto niente a che vedere con ambienti di estrema destra”? No. Quindi: fare una caricatura semplificata delle posizioni altrui, strillare forte, non andare sul merito.
Potremmo dire che il modo di agire degli inquinatori fascisti e sciovinisti su Wikipedia è l’equivalente del trollaggio, adattato alle condizioni “inospitali” là esistenti che rendono la vita difficile a chi voglia trollare in modo becero come si può fare con una certa facilità sui social network o su molti blog. In pratica, è un camuffamento da persone perbene anche se un po’ “fissate” e con idee “insolite” di cui parlano per allusioni: è una tecnica in cui i neofascisti sono diventati esperti da molti decenni.
Comunque, continuiamo a stare sul merito per cortesia e non nutriamo troll che sembrano già ben pasciuti. Mi sembra notevole e bello che questo post stia già innescando un lavoro costruttivo sulle voci, magari proprio partendo da quelle 123 che Presbite ci sfida a controllare. E quel che è emerso su Basaglia non fa ben sperare sui reperti che potremo trovare sporcandoci di più le mani… Se questa discussione porterà nuovi editor competenti e ragionevoli a it.wiki, è già un bel risultato per il Progetto e lasciamo pur rosicare i roditori.
Questioni più o meno personali a parte, la discussione su questo articolo su it.wiki mostra fin dai primi interventi come la filosofia di Wikipedia sia vulnerabile all’illusione della neutralità. Un grosso numero di interventi si butta head first in un bell’argomento ad hominem da manuale: i Wu Ming sono sinistri e quindi tutto quello che dicono (o ospitano sul blog) è screditato a priori. Qualcuno arriva a dire che ora che Salvatore Talia ha ufficialmente preso posizione, non è più possibile considerarlo un utente “neutrale”, come se una cosa simile potesse esistere.
L’idea che esistano persone (idee, posizioni) di sinistra, altre non-di-sinistra e altre ancora neutre è senza dubbio il risultato di una vittoria storica delle destre più infami, se ne ha un esempio ogni volta che assistiamo al fenomeno: branco di teste rasate con svastiche aggredisce ragazzino chiamandolo comunista di merda, poi interrogato il branco dichiara che no, la politica non c’entra niente ed era meramente una questione personale, una normale rissa fra giovani (di cui alcuni con svastiche che attaccano in branco uno mentre è solo).
A volte per la frustrazione mi chiedo se non dovremmo fare la stessa cosa, che so, magari Chiara, Claudia, Mattia e Niccolò dovrebbero provare a dire che i compressori gli stanno sui coglioni per ragioni personali e la politica non c’entra niente, ma ovviamente dubito che funzionerebbe.
La stessa discussione mostra il dente scoperto anche in un altro modo: diversi degl’intervenuti denunciano la chiamata alle armi dell’autore del post, in ciò palesando il pregiudizio secondo cui antifascisti vuol dire comunisti faziosi che danneggeranno Wikipedia.
Mentre leggevo questo post e quella pagina, ho pensato questa cosa: un buon analogo è il caso di alcune voci sensibili per quanto riguarda le truffe pseudoscientifiche: anche lì accade spesso che una voce subisca interventi da parte di chi cerca di rendere presentabile una truffa che si appella alla neutralità, anche se in quel caso, in genere, la ragione vince con meno fatica. Ebbene: nessuno (credo) si sognerebbe di accusare di chiamata alle armi uno che, in un blog, invitasse chi odia le pseudoscienze a vigilare.
“Dobbiamo innanzitutto premettere che ringraziamo Talia per aver recensito il nostro libro e Wu Ming per lo spazio. Francamente non speravamo di riuscire a rompere quel silenzio assordante che finora ha accolto il volume soprattutto negli ambienti dove sarebbe stato più logico se ne parlasse, e Talia, forse involontariamente, ha contribuito in maniera determinante a infrangere la conventio ad excludendum.”
Cinque righe di incipit frignone ed è solo il primo commento al post da parte degli autori del libro. Andiamo bene…
S. Talia fa bene a rilevarlo, il topos del vittimismo è davvero un’attitudine destrorsa ricorrente.
http://www.treccani.it/vocabolario/vittimismo/
Non c’è affatto vittimismo nel nostro commento d’esordio, solo del sarcasmo e una effettiva constatazione.
La constatazione che Wikipedia in lingua italiana e che Wikimedia Italia piuttosto che tentare una recensione critica come è stato fatto su Giap (o meglio, tentativo di recensione, che non condividiamo e che contestiamo in molti punti, ma di cui prendiamo atto, e di cui cogliamo comunque l’aspetto positivo, così come la possibilità di replicare in questi lidi (anche se nei commenti da blog il rischio di finire in un girone a 5 Stelle è alto)) hanno preferito fare silenzio.
L’assordante silenzio dopo che in chat fra wikipediani si leggeva di “recensioni collettive” etc.etc. eppure mesi dopo ancora nulla, evidentemente una consegna del silenzio fra certi esponenti di WP c’è stata, a meno di considerare normale che l’unico volume attualmente circolante su Wikipedia non venga citato manco di striscio nelle pagine di discussione.
Non è vittimismo, è realtà dei fatti. Con una punta di sarcasmo.
Con la qual cosa abbiamo capito che la realtà dei fatti deve adattarsi all’ideologia, da queste parti, ma non è che anche il sarcasmo è da considerarsi atteggiamento fascista?
Questo, naturalmente, non è vittimismo.
«Ma uffa, tutti mi dicono che faccio del vittimismo! Proprio a me che non faccio mai mai mai la vittima!! Perché non lo dite anche agli altri che fanno i vittimisti? Eh?»
“L’assordante silenzio dopo che in chat fra wikipediani si leggeva di “recensioni collettive” etc.etc. eppure mesi dopo ancora nulla, evidentemente una consegna del silenzio fra certi esponenti di WP c’è stata […]”
Giusto, il vostro non è vittimismo. Cambio subito il link:
http://www.treccani.it/vocabolario/complotto/
Nota disambigua: anche il mio è sarcasmo.
In un commento interno, Salvatore scrive questo:
«Poche pagine dopo, proponete una serie di riforme in senso “democratico” delle regole di it.wiki (alcuni parlerebbero di misure di tipo populista); riforme che, secondo voi, dovrebbero appunto impedire il formarsi di oligarchie.»
Mi sembra che questo sottotema sia molto importante per confrontarsi al di là dei conflitti su questa o quella voce, perché parla di una visione più generale sulla formazione di cultura tramite la collaborazione online e l’uso di strumenti aperti.
Sarei curioso di sapere in sintesi quali siano le riforme che propongono.
Caro Vanetti, noi siamo disponibilissimi ad aprire un dibattito sulle nostre proposte.
Ma in mezzo a questa canèa è impossibile discutere con qualche profitto, quindi ti invitiamo in altra sede.
Qui quello che c’era da dire è stato detto.
Grazie a Talia e agli anonimi scrivani cinesi per la pubblicità aggratis.
A Wu Ming state solo a rosicà
è da due anni che dovete da fà
er libbro bianco
er libbro d’inchiesta
a tesi de laurea
e ‘nvece, arivati ar dunque
ve siete fatti fregà
da du stronzi qualunque
Dopo quest’offesa gratuita ai romani e al loro vernacolo, e dopo che dei due “Autori” è stato dimostrato quel che c’era da dimostrare (come suol dirsi: “constatato il livello”), possiamo bannarli anche da questo blog. Non vorremo mica essere da meno di Wikipedia!
La differenza tra Wikipedia e Giap è che qui Mastrangelo non potrà intrufolarsi e scrivere di nascosto anche dopo essere stato cacciato.
«Ma in mezzo a questa canèa è impossibile discutere con qualche profitto, quindi ti invitiamo in altra sede.»
Be’, la canea l’avete fatta voi e gli amici vostri, intendiamoci. Comunque vabbe’, ho capito: troll fino in fondo, neanche se uno vuole capire come la pensate siete capaci di rispondere in modo intellegibile. Perlomeno in questo siete coerenti.
A questo punto girerei la domanda a Salvatore che mi sembra più capace di articolare un discorso: che riforme propongono i due troll?
Volevo lasciare un piccolo contributo sul modus operandi di alcuni degli utenti citati nel (meticoloso e ben scritto) post di Salvatore, che mettono in luce in particolare la necessita’ di vigilare sui contenuti di Wikipedia.
Alla voce “Eccidio dell’ospedale psichiatrico di Vercelli”, che e’ taggata come voce di qualita’, creme de la creme, quindi, si legge come Franco Basaglia, il noto psichiatra, si trovasse nelle truppe fasciste della “colonna Morsero” nel ’45. La cosa mi ha abbastanza stupito, anche perche’, conoscendo bene la pagina Wikipedia su Basaglia, non me ne ricordavo affatto. Noto subito che la fonte per l’informazione di cui sopra e’ il libro del buon Vespa, “Vincitori e Vinti”, grande esponente nostrano del revisionismo padronale. Ora, tralasciando il fatto che tale libro, che io ne sappia, non sia una monografia su Basaglia, la cosa interessante la si legge nella pagina discussione: colui che propone l’aggiunta di questo pezzo su Basaglia e’ l’utente Theirrules, citato da Salvatore. Notare come non c’e’ la benche’ minima discussione sulla legittimita’ di questa fonte, nemmeno un commento: il capello non si spacca in ottantaquattro, in questo caso, ma piuttosto ci si fa’ la permamente. Jokes aside, la modifica viene ufficialmente effettuata il 1 Maggio 2012: l’utente se ne fa onere, “essendo peraltro già presente nella biografia di Basaglia”. Ebbene, se si va alla pagina di discussione di Basaglia, si vede che l’utente Piero Montesacro, citato da Salvatore nel post, fa notare un conflitto di fonti, che sostengono invece la figura di un Basaglia antifascista e prigioniero nella Repubblica di Salo’, e inducono alla rimozione del pezzo controverso in bibliografia. Fin qui, controllo delle fonti, nulla di strano. Qual e’ il punto? Il punto e’ che quest’ultima modifica risale al 5 Novembre 2011, cioe’ piu’ di 6 mesi prima di quella di Theirrules. (Notare anche dalla cronologia della pagina di Basaglia come il presunto passato fascista appare nella biografia grazie all’appoggio di altri utenti citati da Salvatore). Il tutto avviene senza intoppi alcuni e senza la benche’ minima discussione su fonti e quant’altro, che invece si scatena nel caso del porco antifascista. Un double-check sarebbe stato doveroso, soprattutto dopo tutto l’autocomplimentarsi interno alla discussione stessa dell’altissima qualita’ della pagina.
Intanto, ad oggi, su una pagina di qualita’ di Wikipedia si puo’ leggere che Basaglia era un repubblichino. Occhio non vede, cuore italico non duole, e’ il caso di dire.
Molto interessante. La voce l’ha creata Presbite, quello che vaglia sempre le fonti “spaccando il capello in ottantaquatro”, e la discussione è salda nelle mani sue e di TheIrrules.
Quella pagina, oltre ad essere stata creata da Presbite, è stata proposta dallo stesso Presbite come “voce di qualità”, edit futiz di Theirrules su Basaglia incluso.
Pagina di qualità caldeggiata da quel Pequod ( o Pequod76), che nella propria pagina utente rimpiange che non ci sia una pagina su Roberto Fiore a causa di una controversia legale: “Sul mainspace di it.wiki ci sono 1 123 026 voci (si cresce al ritmo di circa 10.000 voci al mese). Purtroppo manca ancora la voce su Roberto Fiore (vd. qui) e quella su Antonio Angelucci (vd. qui e qui). Dato lo spessore politico dei due personaggi, spero ci lascino fare quanto prima.”(cit. dalla pagina utente del suddetto)
Ah, dimenticavo: come segnalato oggi sul tuider, nella pagina utente di Pequod fa bella mostra di sè un banner con scritto “WC visto cricca” :D
Qualcuno parlava di vittimismo più sopra…
Ciao vhreccia, sono il Pequod wikipediano che citi. Sono già stato scambiato per “nostalgico” da alcuni membri della redazione de “I siciliani giovani”, per cui evidentemente è colpa della mia pagina utente. Mi pare comunque strano che auspicare che esistano voci dedicate a Fiore e Angelucci possa rinviare ad un qualche debole nei confronti di questi personaggi, se uno poco poco li conosce. Alcune voci vengono oscurate per timore di controversie legali. Così è per Fiore e Angelucci. Da wikipediano la cosa mi dispiace. Questo non significa affatto che questi due signori mi piacciano. Il riferimento al loro “spessore politico” è puramente scherzoso. Rimane quindi confermato che la “cricca” non esiste… ed è rossa. :D
Perdonatemi l’off topic: Carlo Gubitosa, in “Wikipedia post mortem”, sul n. 1 de “I siciliani giovani” mi rimproverò di aver scritto nella voce dedicata a Titta Scidà di una vergognosa vicenda di calunnia nei confronti del rimpianto magistrato catanese. Vedi https://it.wikipedia.org/wiki/Giambattista_Scid%C3%A0 (la vicenda Lo Puzzo). Secondo loro non parlare affatto di questa faccenda (cosa che invece lo stesso Scidà molto coraggiosamente fece nel suo blog) era la migliore ricetta “antimafia”. Buon pro gli faccia. Io ne ho scritto. Nel rimproverarmi questa scelta Gubitosa ha ritenuto di mortificare la mia utenza, cogliendo questa presunta palla al balzo di Fiore-Angelucci. In uno scambio che ho avuto via mail private con Riccardo Orioles non mi è stato mai chiesto scusa. Ti assicuro, non voglio che mi chiedi scusa, non c’è problema. Solo ci tengo a precisare che ti stai sbagliando sul mio conto. Gubitosa scrisse di me: “si definisce estimatore di personaggi come il fascista Roberto Fiore”. Mi associò anche a vigliacchi fascisti e nemici dell’antimafia (http://www.isiciliani.it/wikipedia-post-mortem/2/#.U31CRSjb7ao). Capirai che per me fu troppo. Non mi hanno chiesto scusa e non hanno mai precisato in che termini scrissi a Orioles, protestando con il massimo garbo l’abbaglio di Gubitosa. Anche in questa sede ci tengo a dire: non sono fascista nemmeno a mia insaputa. Il bell’articolo e progressivo di Gubitosa sta ancora in internet…
Mi pare anche strano affermare che io abbia “caldeggiato” la voce sull’eccidio dell’ospedale psichiatrico di Vercelli. Tu forse non immagini che “guerra civile” ci sia stata a quei tempi su it.wiki. Proprio perché, come Talia, credo nella possibilità di un confronto leale, insieme ad altri, segnatamente l’utente Sandro_bt, mi sono sforzato di approcciarmi alla certificazione di qualità di quella voce nei termini più tecnico-pediani possibili. Ma ha ragione chi ravvisa nel concetto di neutralità in Wikipedia una delicata aporia.
Perché c’è stata una guerra civile su it.wiki? Perché, contrariamente a quanto prudentemente non scrive Talia, una cricca di destra c’era eccome su it.wiki. Nell’ottica wikipediana ovviamente non fa problema che fossero di destra, fa problema che il loro approccio sia stato quello descritto: vittimismo e atteggiamento da branco, giocodiruolismo allucinatorio, lotta alla vulgata partigiana, pov pushing mellifluo o grossolano, a seconda dei casi. Qualcuno coniò anche un nome per questo gruppo: le “truppe cammellate” (nome collettivo e quindi sicuramente generico e in parte ingeneroso). Che facevano le nostre truppe cammellate? Semplice: beatificazione post storiografiam di fascisti ed elencazione-raccapriccio di tutte le formiche ammazzate dai partigiani nei loro trasferimenti. La storia negata, il negazionismo della storia. La sostituzione della storia con la memorialistica. Fare tutto ciò che è possibile (fonti farlocche, fonti citate a metà o al doppio) per “sistemare” le voci. La riabilitazione del sangue dei vinti, secondo un modulo che ha avuto fortuna per tanti Natali della storiografia-strenna negli ultimi decenni di questa Nazione.
Oggi non ci sono più su it.wiki le tensioni di allora e ciò certo non perché le voci siano state sistemate. Non posso che guardare con favore e simpatia ad uno sforzo per riparare alle tante macellerie storiografiche e revanchiste combinate dai nostri “sconfitti dalla Storia”. Già solo leggere l’articolo di Talia è stato come una boccata d’aria: mi sono detto “Finalmente!”. Io non mi aspetto né auspico una riscrittura “a parte sinistra” di quelle voci: mi aspetto solo che da it.wiki venga eliminata tanta spazzatura subdola infilata da utenti desiderosi di aggiustare la Storia. Quindi grazie a tutti coloro che si vorranno impegnare per migliorare la qualità delle voci di it.wiki, anche se dovesse uscirne che i partigiani hanno fatto una vera strage (efferata) di formiche.
Ciao Pequod, io invece ti chiedo scusa subito per la mia avventatezza. Già su twitter, parlando con PapaEnEu, che mi faceva notare la pagina sospesa per questioni legali, avevo replicato “@PapaEnEu sì, avevo visto. Resta il fatto che quelle parole fanno un po’ senso, poi magari era ironico e io non ho colto”. Il dubbio m’era venuto, però ammetto d’esser stato fuorviato dalle parole della tua pagina utente. Mi scuso ancora con te, con chi ci ospita qui sopra e con gli altri giapster, il factchecking doveva essere più accurato, e in futuro lo sarà, ché sentirsi dare del fascio non è bello per niente e forse non mi scuserò mai abbastanza.
Ma no, figurati, pace fatta! :)
Ora faccio un accrocco sulla mia pagina utente, così eviterò nuovi problemi.
Un caro saluto e grazie per la tua correttezza.
Da: Mario Colucci – Pierangelo Di Vittorio, Franco Basaglia, Bruno Mondadori Editore, Milano 2001, pag.1:
“Franco Basaglia nasce a Venezia l’11 marzo 1924, da una famiglia agiata. Secondogenito di tre figli, trascorre un’infanzia e un’adolescenza serene nel caratteristico quartiere veneziano di San Polo. Conclusi gli studi classici, nel 1943 si iscrive alla Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università di Padova. Qui entra in contatto con un gruppo di studenti antifascisti e, a seguito del tradimento di un compagno, viene arrestato e detenuto per sei mesi, fino alla fine della guerra. Esperienza che lo segna profondamente e che rievocherà anni dopo parlando del suo ingresso in un’altra istituzione chiusa: il manicomio.”
Presbite voleva che si facesse inchiesta sulle pagine che ha fatto lui. Bene, si è cominciato.
Dal libro della figlia Alberta Basaglia che ricorda i racconti della nonna Cecilia (quindi la madre di Franco Basaglia):
“Anno 1944, Franco partigiano. Quando i fascisti arrivarono per prenderlo, lui era già in fuga sui tetti. A Venezia è possibile saltare da una casa all’altra.”
p. 17 di “Le nuvole di Picasso” di Alberta Basaglia, Feltrinelli, 2014
Questa è una cosa che non riesco a capire. Una cosa è il tentativo di arruolare, postume, figure come Tolkien, scrittore di opere fantasy conosciute (almeno per sentito dire) praticamente da tutti ma le cui idee sono ignote ai più–una cosa squallida e pidocchiosa, ma comprensibile. Altra cosa arruolare Basaglia: i più, credo, non l’hanno mai sentito nominare, e quindi non capisco che valore abbia fingere di averlo in squadra; chi lo conosce almeno in parte, però, dovrebbe ben strabuzzare gli occhi a leggerlo repubblichino. Che senso ha?
No, in casi simili a questo la strategia non consiste nell’arruolare (Basaglia fu di sinistra, rivoluzionario, compagno di strada dei movimenti e di Sartre, Foucault, Guattari), ma nello screditare, nel dire che quella generazione di antifascisti fu una generazione di traditori, di voltagabbana, di fascisti che divennero antifascisti per opportunità. Nel caso di Basaglia è diffamazione pura, ma spesso è odioso e pretestuoso anche contro chi – magari a sedici anni! – repubblichino lo fu davvero poi fece tutt’altra vita e tutt’altre battaglie. “Il Borghese” negli anni Settanta ci costruì un intero libro, un pamphlet non proprio esile intitolato “Camerata dove sei?”, prova a digitare il titolo su Google e constata il livore.
Su wikiquote – Franco Basaglia:
“Quando entrai per la prima volta in una prigione, ero studente in medicina. Lottavo contro il fascismo e fui incarcerato. Mi ricordo della situazione allucinante che mi trovai a vivere. Era l’ora in cui venivano portati fuori i buglioli dalle varie celle. Vi era un odore terribile, un odore di morte. Mi ricordo di aver avuto la sensazione di essere in una sala di anatomia dove si dissezionano i cadaveri. Quattro o cinque anni dopo la laurea, divenni direttore di un manicomio e, quando entrai là per la prima volta, sentii quella medesima sensazione. Non vi era l’odore di merda, ma vi era un odore simbolico di merda. Mi trovai in una situazione analoga, una intenzione ferma di distruggere quella istituzione. Non era un problema personale, era la certezza che l’istituzione era completamente assurda, che serviva solamente allo psichiatra che lì lavorava per percepire lo stipendio alla fine del mese. (da Conferenze brasiliane, 1979)”
Certo che in quanto a rimestatori di panzane siete veramente una bella combriccola. E nemmeno capaci di leggere una cronologia delle pagine wikipediane.
Qui sopra l’alato Wu Ming scrive che la voce sull’eccidio dell’ospedale psichiatrico di Vercelli sarebbe stata creata da me (Presbite).
Balla cosmica.
La voce (si veda qui: https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Eccidio_dell%27ospedale_psichiatrico_di_Vercelli&dir=prev&action=history) è stata creata il 5 settembre 2007 da un anonimo IP.
La prima volta che io ho fatto un edit su questa voce era esattamente il 7 gennaio 2011, quando la voce già “pesava” 16.790 byte.
Ragazzi: se la vostra capacità di rivedere le voci wikipediane è pari alla vostra attenzione ai particolari dimostrata qui dentro, allora è meglio che stiate a casa vostra, a gridare al lupo al lupo fra di voi: in WP fareste solo dei gran danni.
Dimenticavo: ovviamente anche la dinamica della storia dell’inserimento della notizia su Basaglia dimostra al 100% che non avete la minimissima idea di cosa sia Wikipedia, come si lavori sulle voci ecc. ecc.
E adesso mi spiego.
La voce sull’eccidio dell’ospedale psichiatrico di Vercelli non è una voce scritta DA ME. Questo è evidente, nonostante le balle propalate qui dentro.
E’ una voce che è stata scritta – alla fine di un vero e proprio scontro sulle fonti durato mesi e mesi – da un gruppo di una decina di contributori, i quali hanno portato ognuno le loro fonti.
Visto che non avete evidentemente la minimissima idea di che cazzzo sia scrivere su Wiki, date un’occhiata alla talk della voce e controllate di persona quanti scazzi, quanti confronti, quante voci si sono rincorse per scrivere al meglio possibile questa voce.
C’è una cazzata dentro? Può essere! Può esser sempre possibile che una cazzata sia scritta lì dentro, come in qualsiasi enciclopedia (compresa la Treccani).
C’era la “supervisione” di qualcuno su questa voce? Ma quando mai? Ma chi può scrivere una cazzata del genere? Solo chi ha l’intento di spalar merda “a prescindere”. Guardate la lista di chi ha SCRITTO la voce, e fatevi un’idea da soli.
La voce è passata attraverso un vaglio (ovviamente non avete la minima idea di cosa sia ‘sta roba, fino a quando non inizierete a scrivere su WP), attraverso una procedura di segnalazione in quanto Voce di Qualità, ed oramai è stabile da mesi e mesi.
Ripeto: c’era una cazzata dentro? Intanto noto che non c’è più. Evviva! Il fascismo ha peso! Abbiamo tolto le tre righe e adesso la voce è P-E-R-F-E-T-T-A!!!
Questa cazzata a chi va imputata? A chi l’ha scritta, in primis. C’è qualcuno che non se n’è accorto? Certo! Chi è questo qualcuno? Le almeno venti persone che hanno scritto in talk.
Detto questo, mi tocca anche dire che ovviamente tutto questo squillar di trombe sul fatto che “spezzeremo le reni a Presbite” e che questo “è solo l’inizio”, è la classica trombonata.
Ripeto: io ho scritto DA CIMA A FONDO 123 voci. L’elenco lo potete agevolmente trovare.
Da grossissimi esperti di questioni relative ai confini orientali d’Italia, accomodatevi, mettetevi a S-T-U-D-I-A-R-E, rilevate il grado di “fascistudine” portato da me nell’interno del NS0 (cosa sia l’NS0 ve lo fate spiegare al bar di WP) e CORREGGETE LE VOCI.
Tutto il resto sono le solite, inqualificabili, incommensurabili caz-za-te.
PS Fra pochi giorni DIMOSTRERO’ come il vostro alato contributore/guest blogger/commentatore Tuco abbia manipolato o ignorato delle fonti all’interno di una voce di Wikipedia. Sarà lui poi a dirci se l’ha fatto apposta o meno. E allora mi aspetto una bella articolessa della minchia sui danni che Giap produce nelle imberbi menti dei giovincelli italioti.
Perfetto, i due commenti subito sopra questo forniscono un esempio tipico del modo in cui si muove Presbite su wikipedia e, con altri pseudonimi, in altri luoghi del web: “spaccare il capello in ottantaquattro” su un dettaglio minore per non rendere conto del suo comportamento complessivo.
Esaminando la cronologia della voce sull’eccidio di Vercelli, si constata che dal 2011 in avanti le revisioni di Presbite sono state circa cinquecento. Tecnicamente, non è stato lui a scrivere la primissima, striminzita versione della voce, quindi non ne è il genitore biologico, ma l’ha adottata da piccola, l’ha cresciuta come una figlia portandola da 16.000 a 79.000 battute, infine l’ha iscritta al concorso di bellezza e ha fatto pressioni perché fosse incoronata reginetta, riuscendoci.
Chiunque legga la pagina di discussione si accorge che, dopo una serie di edit wars, la voce l’ha presa saldamente in mano Presbite, che ha coordinato il lavoro di riscrittura. Alla fine del lavoro, Presbite si è assunto la responsabilità di proporre quella pagina per la vetrina, inclusa la porcata su Basaglia, lasciata dov’era nonostante altre fonti, ben più attendibili, la rivelassero come notizia falsa.
Stavolta Presbite non può dire, come ha provato a fare (senza convincere nessuno) nel caso del TIGR, che la voce non era tra i suoi “osservati”, che non ci ha mai messo mano ecc. Lo scrupoloso Presbite, che “spacca il capello in ottantaquattro” sulle fonti contrarie al suo POV, stranamente non si accorge che il suo amico AleR si inventa un libro di sana pianta, che il suo amico TheIrrules inserisce un’informazione falsa su “Basaglia repubblichino”, e chissà di quante altre cose non si è accorto.
Perfetto: il commento qui sopra dimostra direttamente e compiutamente il mio assunto: su oltre 18.000 edit se ne prende UNO che non ho nemmeno fatto io (!!!) e mi s’infilza dicendo che QUESTA sarebbe una mia reponsabilità.
E questa incommensurabile c-a-z-z-a-t-a sarebbe invece “rendere conto del suo comportamento complessivo”.
Volete che io “renda conto del mio comportamento complessivo”?
Allora – e mi ripeto – prendete ciò che IO ho scritto.
Basta con queste stronzate da giudizio polpottiano, Wu Ming! Basta con le rincorse delle bave di lumache!
Se sei capace di farlo, prendi in mano le mie 123 voci (quelle che ho scritto IO), prendi in mano i miei 18.000 edit e ANALIZZALI nel loro complesso.
Tutta questa fuffa che propali qui dentro fa letteralmente vomitare.
Un’inchiesta consiste in questo: nell’esaminare le voci di Wikipedia, le loro cronologie, le pagine di discussione, e risalire alle fonti. Da oggi in poi saranno molte più persone a farlo, e quando l’intelligenza collettiva si mette al lavoro, verifiche che a una sola persona richiederebbero tempo ed energie, vengono fatte quasi all’istante.
In un rapido rimbalzo tra Giap e Twitter, grazie allo storico e italianista inglese John Foot che da cinque anni fa ricerche su Basaglia, si è scoperto che Vespa ha preso la notizia falsa su Basaglia da un libro del notoriamente affidabile “foibologo” di ultradestra Marco Pirina. Il libro è 1945-1947: guerra civile: la rivoluzione rossa, la citazione è qui.
In pochissimo tempo si è fatto il double-check che Presbite & soci non fecero all’epoca nonostante la segnalazione di Piero Montesacro, e si è ricostruito il percorso della notizia tossica. Chissà, forse TheIrrules ha citato Vespa-che-cita-Pirina perché citando direttamente Pirina (i cui fantasiosi elenchi di “infoibati”, “martiri giuliani” e “vittime del comunismo” sono stati smontati nel dettaglio da Claudia Cernigoi) avrebbe rivelato troppo la matrice ideologica di tale “notiziola”.
Si diceva: un’inchiesta serve a questo, e da oggi molte più persone la faranno, perché nel nostro piccolo abbiamo acceso un riflettore sulla questione. Quindi anche le voci che Presbite invita a vagliare saranno vagliate, al pari di tante altre con cui non c’entra niente, che non ha generato né adottato lui. Perché costui non deve montarsi la testa: nonostante i patetici, sboccati e sbracati tentativi di mettersi al centro dell’arena e atteggiarsi spettacolarmente a vittima (a destra è sempre il ruolo più ambito), questa non è un’inchiesta su di lui, e nemmeno solo sui suoi edit, ma su Wikipedia, la storia, la memoria storica, la documentalità.
A me frega nulla della crociata che s’ha intenzione di far partir da qua. Frega invece che l’articolo cheua sipresenta in pompa magna sia definito – perquel che mi concerne – per quel che e’: una merda. Mi metto al centro perche’ Talia m’ha messo al centro, per cui prendetevela con lui. E dimostrare che il tipo abbia scrito delle stronzate, e che ci sia qualcuno cme te che le difende scrivendo altre stronzate, dimostra una cosa: che non c’e’ altro che fuffa, per quel che mi riguarda.
Detto questo, faccio una facilssima previsione: fra un anno intero verremo qui e noteremo che nonostante lo sforzo twitteriano & co, le 123 voci scritte da me rimaranno sostanzialmente intonse.
Il che dimostrera’ vieppiu’ la qualita’ infima dellz ricerca di Talia.
E adesso Wuminghiani vi lascio. Se sarete capaci di aprire qualche libro ed entrare in wikipedia, ci rivdledremo li’ dentro sui temi che mi sconfiferano.
Permettetemi di dubitarne alquanto.
E poi, vogliamo dire un’altra cosetta su questo po-po di articolo scritto dal Talia? Su questa fantasmagorica ricerca per la quale addirittura qualcuno qui sopra loda l’impegno? Si provi ad analizzare le “prove” dell’esistenza d’un sentimento antislavo in wikipedia. Quelle segnalate dal Talia. Di chesi tratta? Di due interventi in talk nemmeno cagati (uno contrastato da me, ma ovviamente il Talia manipolatore nemmeno si degna di segnalarlo) ed un nome d’una voce, quella di Edvard Rusjan, che in itWiki e’ chiamato Eduardo nel titolo e solo nel testo della voce anche Edvard.
Di fronte a queste po-po di evidenze , non c’e’ che dire: l’antislavismo e’ una colonna di wikipedia! (fra parentesi: volete trovar veramente delle tracce di antislavismo? Andate sulle voci dedicate all’esodo istriano e ai massacri delle foibe. Talia non ci arrivera’ manco per il cavolo, ma qua e’ strapieno di espertoni, dico bene? Fate leggere le voci agli espertoni, cosi’ finalmente ci si mette assieme a modificare queste voci/cloaca).
E adesso veniamo alla parte divertente. Chi e’ che avalla in talk il doppio nome di Rusjan Edvard/Eduardo? Chi e’ sto vergognoso razzista mangiaslavi? L’amichetto di Giap che si chiama Tuco! Il vostro amato guest blogger, nonche’ commentatore di punta!
Presto, Wuminghiani: un bel capestro anche per lui!!
Per chi segue la discussione: nella talk su Rusjan io ho scritto questo:
Edvard (o Eduardo) Rusjan fu cittadino austriaco di nazionalità slovena (padre sloveno e madre italiana), così come Umberto Saba, fino al 1918, fu cittadino austriaco di nazionalità italiana. Giacomo Leopardi, morto nel 1837, quindi ben 24 anni prima che le Marche diventassero parte del Regno d’Italia, fu cittadino dello Stato Pontificio di nazionalità italiana. Srečko Kosovel fu cittadino austriaco, poi italiano, poi jugoslavo, di nazionalità slovena. E così via. Ho notato che AleR, prima di essere bannato, aveva combinato un po’ di pasticci con le nazionalità dei cittadini dell’ impero austroungarico, e non solo. Bisognerà controllare, un po’ alla volta. –TBPJMR (msg) 21:20, 4 apr 2013 (CEST)
in risposta a a questo:
Era un aviatore Austriaco, non esisteva nessuno stato sloveno nel 1911, per fare un esempio è come voler definire un personaggio come Francesco Baracca non Italiano ma Romagnolo, mettendo in evidenza la sua origine regionale a discapito di quella nazionale. –AleR (msg) 08:56, 17 nov 2009 (CET)
Allora: l’amico qui sopra da’ del troll a me. Perche’ lui e’ capace di interpretare le intenzioni. Non solo: afferma che tale intenzione e’ neofascista. I neofascisti addirittura sono specialisti di tali “intenzioni”. Fantastico tutto cio’: nemmeno ai tempi della santa inquisizione.
Il punto e’ molto semplice: non sono fascista, non lo sono mai stato, ne’ lo saro’ mai. Non ho mai frequentato gli ambienti neofascisti.
Tutto cio’ lo scrivo perche’ l’inquisitore qui sopra scrive che se non neghi, allora sei. Limpido esempio di logica conseqienziale orwelliana.
Detto questo, aggiungo che non ho scritto nessuna riga in nessuna voce wikipediana che sia definibile come fascista. Sfido chiunque a dimostrare il contrario.
Alla fine della fiera, la questione e’ molto semplice: se un articoli come quello di Talia e’ pieno – come e’ pieno – di inesattezze, omissioni e manipolazioni, il problema non dovrebbe essere di chi ha subito la manipolazione.
Ma visto che delle manipolaziini di Talia non frega nulla a nessuno, mi vuoi anche togliere il gusto di scrivere che uqeste sono delle vaccate, e che gran partr delle circonvoluzioni da tale articolo derivate sono delle vaccate anch’esse?
Visto che qui dentro un tale po-po di alati commentatori non riesce a dimostrare la mia fascitudine per tabulas, posso almeno mandarvi afffanculo? Almeno poco poco?
Nel bannare Presbite, prendiamo atto che ha seguito il consiglio del “Domenicale” di Dell’Utri, cfr. colonna destra di questo blog, sezione “Hanno detto di noi” :-)
Nel frattempo, si stanno trovando manipolazioni di fonti ad opera di questo utente in diverse voci sulla storia del confine orientale. Vorrà dire che, vista la manifesta incapacità di esprimersi con argomenti e astenersi da ingiurie, sbroccamenti e strawman, le discuteremo senza di lui.
Salve,
Vorrei dire innanzitutto che non conoscevo il funzionamento della wikipedia e ho trovato quindi molto interessante l’articolo di Talia. Ne prenderò spunto per vedere se nelle voci di es.wiki si trovano degli atteggiamenti simili (ho già visto che c’è parecchia discussione riguardo i toponimi in catalano o galiziano, come in it.wiki sui toponimi slavi).
Per quanto riguarda le voci sulla storia del confine orientale create da Presbite, ho trovato una voce chiamatasi “Croatizzazione”. In questa, viene scritto quanto segue:
“Si completò così quello che alcuni storici come il francese Michel Roux hanno definito la “pulizia etnica” degli Italiani in Dalmazia, usando gli iugoslavi metodi simili a quelli del Manuale Cubrilovic contro gli Albanesi di Iugoslavia.[51]”
Andando al link di quella affermazione [51] vedo che è tratta dal sito lefoibe.it, cui a sua volta si riferisce al “Dossier Foibe ed Esodo, curato da Silvia Ferretto Clementi, Consigliere Regionale della Lombardia. (www.ferretto.it)”.
Quello che non riesco a trovare è che il tale storico Michel Roux abbia parlato di “pulizia etnica degli italiani in Dalmazia”. Per carità, premetto che non ne so proprio niente di queste vicende e spero non star sparando una cazzata. Ma visto che nella voce inglese c’è stata una discussione accesa tra utenti (tra i quali il tale Theirrulez) sulla verità dei fatti o, meglio, la mancanza di fonti, mi permetto di buttarla lì, nel caso qualcuno ne volesse approfondire.
È comunque scioccante (sebbene già spiegato da Talia) come questi utenti quasi monopolizzino le tante discussioni. È stato affascinante trovarli anche nella pagina di discussione sul luogo di nascita di Marco Polo, :)
Saluti e, come al solito, mi scuso per gli errori grammaticali ed ortografici che mi siano sfuggiti :/
Amen.
Direi che qua il trollaggio fosse voluto per ottenere il ban da Giap e poi lamentarsi (solito vittimismo che abbiamo già commentato). Non so in quale posto al mondo puoi mandare tutti affanculo ripetutamente ed essere lasciato libero di reiterare la provocazione senza avere neanche una mezza risposta per le rime. Sicuramente non si può fare su Wikipedia.
Il ban era comunque necessario per evitargli un embolo, la quantità di errori di battitura e la sovreccitazione fuori controllo mi sembra sintomatica e richiedeva una terapia precauzionale. Saint-Just veglia anche su chi non lo rispetta.
Sia lasciato ai posteri il facile compito di verificare quanto ogni ragionamento che mi attribuisce Presbite sia inventato di sana pianta. Gli stessi potranno verificare con facilità chi sia arrivato qua sopra con la bava alla bocca e chi abbia cercato ripetutamente di allargare un attimo il discorso e non alimentare flame inconcludenti. Anche perché Presbite, nonostante quel che lui crede, non è l’oggetto di questo post.
Mah. Su Mastrangelo penso che ci siano pochi dubbi, pochi dubbi davvero sulla sua agenda ideologica. Non sono convinto per quanto riguarda Presbite, la cui frustrazione mi sembra logica conseguenza di essere stato etichettato come fascista. Ed infatti lo dice chiaramente, di non essere fascista. Questo enorme flame si sarebbe, credo, potuto risolvere evidenziando subito la questione chiave: è o non è uno con una chiara agenda ideologica? Poi nel proprio blog ognuno banna chi crede opportuno bannare. La discussione, personalmente, l’ho trovata parecchio sgradevole e secondo me basata su parecchie incomprensioni.
Varrà la pena di ribadire ancora una volta che nessuno ha dato a Presbite del fascista. Mastrangelo lo cita come il suo idolo, ma non gli dà del fascista (credo). Talia lo cita come uno citato favorevolmente da Mastrangelo, ma non gli dà del fascista.
Quel che si può semmai affermare è che secondo Talia (e, per quel che vale, anche secondo me) in molte voci che riguardano il confine orientale spesso varie correnti di pensiero sciovinista italiano, slavofobo e anticomunista si danno convegno e collaborano nel presidiare le voci con una foga e una determinazione degne di miglior causa. Non tutte queste correnti di pensiero sono esplicitamente e tecnicamente fasciste.
Per certi versi mi preoccupa di più un pregiudizio italocentrico su it.wiki, che rischia di diventare un bias sistematico per ovvie ragioni linguistiche, che le cagatine occasionali che possono depositare i fascisti veri e propri. La baruffa permanente che si svolge sulla pagina “Crimini di guerra italiani” (https://it.wikipedia.org/wiki/Crimini_di_guerra_italiani), impedendo alla pagina di raggiungere una forma stabile e affidabile, è un buon esempio.
Sapere che per un croato, uno sloveno, un albanese, un libico, un somalo o un etiope visitare it.wiki e contribuirvi può essere un’esperienza respingente, è qualcosa che mi mette molto a disagio e contraddice lo spirito universalistico di un’enciclopedia libera.
L’utente di Wikipedia “Presbite”, insieme ad altri coi quali lavora da anni (alcuni esibiscono fin dal nickname chiare simpatie fasciste: “José Antonio”, ad esempio) ha lavorato su molte voci di Wikipedia ed è intervenuto in molte discussioni.
Prima l’articolo di Salvatore e poi la discussione hanno proposto svariati esempi di come costoro hanno lavorato, e altri esempi continuano ad arrivare. Ciascuno può leggerli, verificarli e farsene un’idea, come può farsi un’idea di come Presbite ha scelto di confrontarsi.
Se poi qualcuno vuole tritare e banalizzare tutto ciò, riducendolo a “incomprensioni” [con Presbite], boh, chi legge si farà un’idea anche su questo.
Certo, stupisce veder ripetere gli “argomenti da uomo di paglia” di Presbite, o veder usare a sproposito la parola “flame”. Qui tutti hanno mantenuto una calma sovra-olimpica e hanno continuato imperturbabili nei loro ragionamenti, prendendo in considerazione fonti, facendo esempi, linkando, risalendo alle origini di alcune falsificazioni, decostruendo frottole.
Per inciso, ci risulta che già tre utenti con cui Presbite ha collaborato strettamente siano stati presi in castagna e bannati da Wikipedia. Altri, invece, sono ancora attivi.
La “chiara agenda ideologica”, poi, è un falso problema.
Si può avere una agenda ideologica e al tempo stesso sottoporre le fonti al vaglio. Ma Presbite sottopone a un vaglio iperpuntiglioso solo le fonti che non confermano il suo POV, mentre lascia passare libri inventati di sana pianta e notizie false e diffamatorie come quella su Basaglia.
Ecco, si può avere un’agenda ideologica e non falsificare o manipolare le fonti. Ma Presbite – stiamo per dimostrarlo – prende libri e ne estrapola il contrario di quel che c’è scritto sopra.
Si può avere un’agenda ideologica e non fingersi ciò che non si è. Ad esempio, fini conoscitori della storiografia slovena quando in realtà non si sa lo sloveno e le “fonti slovene” citate sono in realtà due tesine raccattate su Google.
Una curiosa conversazione tra “estremidestri” risalente al 2011 dove si parla degli exploit dell’utente “Barba Nane” e, tra le altre cose, si ammette candidamente che la rielezione ad admin di Piero Montesacro – autentica “bestia nera” degli anti-antifascisti attivi su Wikipedia – fu sabotata usando identità false (“sockpuppet”). Non sappiamo quanto sia affidabile quel che si dicono i due personaggi, ma ci sono elementi di cui tener conto, e che mostrano chiaramente il tipo di dinamiche esposte nell’inchiesta di Salvatore.
Personaggi notevolissimi, discussione interessante, e saltano fuori anche vecchie conoscenze…
Mi sa che il mobbing, o il bullying, nei confronti di Montesacro — una vera e propria “guerra sucia” durata anni e conclusasi nel dicembre 2011 con le sue “dimissioni” dal progetto per sfinimento — è una delle vicende-chiave di tutta questa storia di merda. Vicenda che vale la pena ricostruire.
Ringrazio Salvatore per il corposo lavoro che ha fatto e insieme a lui tutti i giapsters intervenuti per il lavoro fatto ma anche per la riflessione sulla necessità di un interesse critico nei confronti di WP.
Sono uno di quegli utenti “passivi” come probabilmete ce ne sono a milioni in Italia, fatta eccezione qualche piccola modifica (una delle quali trovata casualmente da WM2), e non ho mai percepito le potenzialità (e i rischi) che un progetto come questo potesse avere. Preziosa anche la testimonianza di “gian” in questo senso.
Diciamo che l’unica volta che ho avuto la percezione che qualcosa non andasse è stato quando ho consultato la pagina “Gladio Rossa- Apparato paramilitare del PCI” (dopo aver iniziato a leggere il libro “Stragi e Mandanti” di Bolognesi e Scardova che, per uno della mia generazione, ho trovato utile).
Su questa pagina, si incontrano tra gli autori delle fonti anche Vespa e un Fabrizio Cicchitto, pare l’onorevole, stando ai collegamenti diretti del nome sulla pagina (anche se tra le opere della sua pagina relativa su WP, questa non figura). Ci sono anche fonti di una qualità diversa. Sarebbe, credo, interessante approfondire il discorso per vedere quanto e cosa ci sia di inesatto, perchè si potrebbe osservare che certi contributi della pagina sembrerebbero voler fornire una sostanziale giustificazione della nascita dell’altra Gladio. Per quel che mi riguarda l’unica che possa essere definita tale e l’unica che sia effettivamente passata da compiti difensivi a offensivi in maniera sistematica.
Dato che non sono uno smanettone e WP sotto questa luce mi è nuova mi sto confrontando per la prima volta con le funzioni cronologia e discussioni e vorrei sapere se e come si possa fare il “Check user” (controllo dell’utenza) descritto da gian, sugli IP anonimi.
Ah, aggiungo una cosa che ho trovato proprio ora, ovvero che i tentativi di spalleggiamento “a chiamata” sono ritenuti “inappropriati” da Wiki.
“Il meatpuppetry si concretizza nel tentativo di “reclutamento” di utenze al fine di alterare il consenso.”
Chi di cricca ferisce..
Ecco, appunto, è per questo che sopra invitavo alla cautela sull'”invitare piú persone” ecc. Appena possibile, il lavoro di verifica e segnalazione degli errori deve spostarsi su Wikipedia stessa se si vuole essere ben accolti ed efficaci.
Sul check user, per definizione si applica solo agli utenti registrati, perché gli altri mettono già in piazza il loro indirizzo IP. Inoltre, si usa per verificare specifichi sospetti sulle utenze, non per generiche investigazioni. Ciò detto, le istruzioni sono in https://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Check_user per l’appunto.
Il meatpuppeting è tollerato in un solo caso: non deve essere pubblico. Infatti i veri meatpuppet evitano di uscire allo scoperto.
Ci si coordina di persona, via mail, via chat su canali riservati, ecc.
Solo gli ingenui si coordinato via blog o via social network. Oppure lo fanno via blog mantenendo un anonimato e senza lasciar trapelare il contesto in cui si interviene.
Diversi utenti di wikipedia in italiano che gravitano intorno a determinate voci di storia contemporanea o, più in generale, delle voci del “Progetto:Guerra” sono (o erano) frequentatori di un canale IRC riservato (anche se ufficialmente aperto a tutti) dedicato alla collaborazione sulla scrittura di voci su Wikipedia e staccato dal cananle IRC ufficiale degli utenti di it.wiki.
Non faccio nomi perché non vorrei scatenare filippiche su Wikipedia. So già che il carissimo amico “Il Demiurgo” (un nickname che è tutto un programma) ha colto la palla al balzo per contraddire sulla discussione al bar di wikipedia (senza contradditorio) i miei due unici post su questo blog. Non se ne lasciano sfuggire una… (scusate l’ironia).
Chiedo scusa se finora mi sono eclissato. Da domenica il processore del mio computer è passato a miglior vita e per almeno una settimana sarò tagliato fuori dal Web.
Ho recuperato a stento poco fa le credenziali di accesso del mio account su Giap e ne approfitto per rispondere al quesito di oske in merito alla funzione Check user dei progetti Wikimedia.
Come è ben noto, questi progetti tutelano il diritto alla privacy: per registrarsi è sufficiente scegliere un nickname e una password. Non è richiesto nient’altro. La stessa email è facoltativa ed è finalizzata al recupero delle credenziali di accesso.
Chiunque abbia un minimo di competenza sulle piattaforme Web 2.0 potrà fare 2+2 e capire che una tutela di questo genere può permettere a chiunque di registrare un numero indefinito di utenze. D’altra parte il “sockpuppetting” ovvero la registrazione di utenze multiple, non è una violazione della policy dei progetti Wikimedia, purché non si abusi di questa facoltà.
A tutela dell’integrità del progetto è perciò istituito un servizio di controllo sulle utenze, il “check user” che permette di individuare eventuali abusi del sockpuppetting. I check user sono un numero limitato di amministratori di comprovata fiducia da parte della comunità che hanno la possibilità di accedere ad informazioni riservate associate a ciascuna utenza e ciascun IP, in gran parte desumibili dalle intestazioni HTTP delle loro connessioni in scrittura: il provider, l’IP, il browser e il sistema operativo usato, ecc. Incrociando questi dati con un’analisi del contesto è possibile risalire con un certo grado di rilevanza alla correlazione fra due utenze apparentemente distinte.
Trattandosi di un’indagine delicata, che richiede l’accesso a dati riservati, il check user è usato quando c’è il forte sospetto che due o più utenze stiano giocando sporco o che un utente bloccato stia violando il blocco. I check user usano questo strumento su richiesta (da parte di altri amministratori e da parte di qualsiasi altro utente registrato) e solo se viene contestualizzata la richiesta. Null’altro viene trapelato sulle utenze “indagate”. Il responso può essere positivo (le utenze sono correlate senza alcun dubbio), negativo (le utenze non sono affatto correlate), incerto.
Spero di essere stato chiaro.
Un avviso: non si tratta di uno strumento invadente, per cognizione di causa posso affermare che i check user sono utenti serissimi e rispettosi della privacy. Io stesso sono stato oggetto di check user in un contesto che, guarda caso, riguardava la mia patetica battaglia contro i mulini a vento di cui si parla in questa pagina.
Se qualcuno è incuriosito potrei fare riferimenti più espliciti, si tratta di una delle tante chicche relative allo strapotere della famigerata cricca. Io, ex wikipediano impazzito, beccato alla prima violazione del blocco perché denunciavo da anonimo una violazione del blocco da parte della vittima “E.M.” aka “Gli autori”, altresì ignorata. Alla faccia della cricca. Ripeto, potrei scrivere un libro anch’io.
«PRESBIOPIA» SU WIKIPEDIA: L’INCENDIO AL NARODNI DOM DI TRIESTE
Questo è un esempio del modo in cui Presbite e alcuni suoi amici lavorano sulle fonti. La questione riguarda l’incendio del Narodni Dom da parte dei fascisti triestini nel 1920.
Nei giorni successivi all’incendio, i comunicati della questura e la stampa locale cristallizzarono una versione dei fatti che faceva acqua da tutte le parti. Secondo tale versione, durante il comizio del capo fascista Giunta uno “slavo” avrebbe accoltellato un italiano, colpevole di aver pronunciato slogan patriottici. Per reazione, le persone che ascoltavano il comizio si sarebbero spontaneamente incolonnate in un corteo diretto verso il Narodni Dom, che però era protetto da un cordone di soldati. Dal Narodni Dom gli “slavi” avrebbero lanciato delle granate, uccidendo un soldato. A quel punto i soldati avrebbero cominciato a sparare, e un fantomatico arsenale nascosto all’interno dell’ edificio sarebbe esploso causando l’incendio.
Tale versione è stata smontata da numerosi storici, sia sloveni che italiani. In particolare, tutta la storiografia seria dà ormai per acquisito che si trattò di un’azione premeditata, perpetrata dai fascisti con la complicità dei militari. La maggior parte degli storici italiani e sloveni che hanno studiato l’episodio tendono a considerare azioni di provocazione da parte degli squadristi anche l’accoltellamento mortale di Nini durante il comizio e il (presunto) lancio di una o più granate contro la folla che assediava il Narodni dom (con il chiaro obiettivo di attribuirne la responsabilità agli “slavi” e di infiammare la folla).
La presenza di un arsenale all’interno dell’edificio invece è esclusa praticamente da tutti gli storici seri.
Il 31 agosto del 2008 Presbite ha inserito questo passo nella voce “Narodni Dom”, dicendo di aver utilizzato come fonte un libro della storica slovena Milica Kacin-Wohinz:
Nel corso di un comizio organizzato dai fascisti triestini venne accoltellato mortalmente il cuoco dell’albergo Bonavia, Giovanni Ninni. La responsabilità di questa uccisione viene ancor oggi attribuita alternativamente ai fascisti stessi – l’uccisione sarebbe quindi stata un errore – o ad un gruppo di sloveni – sembra che Ninni fosse stato ucciso perché aveva gridato frasi a sostegno dell’italianità della Dalmazia. La morte del giovane fu l’episodio che diede il via ai disordini, che compresero il danneggiamento di negozi gestiti da sloveni, l’assalto di alcune sedi di organizzazioni slave e socialiste e la sassaiola contro la sede del consolato jugoslavo di via Mazzini. Le squadre fasciste – sotto la guida di Francesco Giunta – raggiunsero quindi il Narodni dom, che in quel momento era chiuso e circondato da oltre 400 fra soldati, carabinieri e guardie regie inviate a difesa dell’edificio dal vice commissario generale Crispo Moncada. All’appressarsi della folla, dal terzo piano dell’edificio vennero lanciate due bombe a mano, seguite da una scarica di colpi di fucile: fu ucciso l’ufficiale Luigi Cassano e ferite otto persone, al che i militari che circondavano l’edificio fecero fuoco verso di esso, mentre i dimostranti forzarono l’ingresso ed appiccarono il fuoco. Tutti gli ospiti del Narodni Dom riuscirono a salvarsi, ad esclusione di Hugon Roblek e di sua figlia, che per salvarsi si gettarono dalla finestra: il Roblek morì mentre la ragazzina si ferì gravemente
In realtà Kacin-Wohinz attribuisce senza dubbio l’uccisione del Nini a un fascista. Dice che dopo l’accoltellamento Randi salì sul palco annunciando alla folla che uno “slavo” aveva accoltellato un italiano, e che a quel punto Giunta incitò la folla a dirigersi verso il Balkan. Ma sull’incendio del Narodni Dom Kacin-Wohinz dice anche molto altro. Chi sa lo sloveno può leggere questo articolo pubblicato sul Delo nel 2010, che riprende quasi parola per parola ciò che c’è scritto nel libro del 2005 citato da Presbite. Il problema è che la parafrasi che ne fa Presbite si limita alla sola parte del testo in cui Kacin-Wohinz espone i fatti. Omette invece la parte in cui l’autrice, sulla scorta delle ricerche storiche di Schiffrer, Silvestri e altri, smonta l’interpretazione della questura e della stampa italiana, e parla di azione premeditata, di provocazioni e di coordinamento tra fascisti e militari. Questa omissione ha permesso ad altri utenti (AleR,
Pequod, Jose Antonio…) di modificare un po’ alla volta il testo, di cancellare delle frasi e di aggiungerne altre, fino a stravolgerlo completamente, senza però eliminare il riferimento a Kacin-Wohinz – il tutto sotto gli occhi distratti di Presbite. La furbata consiste nel fatto che l’indicazione della fonte, fin dall’inizio, è accompagnata da queste parole: “Si veda per una ricostruzione più dettagliata M.Kacin Wohinz”.Il 26 luglio 2011 la descrizione dell’incendio si era così trasformata:
Per protesta contro gli incidenti di Spalato i fascisti triestini organizzarono una manifestazione nella piazza principale di Trieste. Nel corso del comizio, mentre parlava il segretario cittadino Francesco Giunta, fu accoltellato mortalmente il cuoco dell’albergo Vanoli, Giovanni Nini[5]. La responsabilità di questa uccisione fu da alcuni attribuita ad uno slavo che avrebbe assassinato Nini mentre questi si era interposto in una colluttazione fra questo slavo e un ufficiale del Regio Esercito[6].La morte del giovane fu l’episodio che diede il via ai disordini, che compresero il danneggiamento di negozi gestiti da sloveni, l’assalto di alcune sedi di organizzazioni slave e socialiste e la sassaiola contro la sede del consolato jugoslavo di via Mazzini. Le squadre d’azione fasciste – sotto la guida di Giunta – raggiunsero quindi il Narodni dom, che in quel momento era chiuso e circondato da oltre 400 fra soldati, carabinieri e guardie regie inviate a difesa dell’edificio dal vice commissario generale, Francesco Crispo Moncada. All’appressarsi della folla, dal terzo piano dell’edificio vennero lanciate due bombe a mano, seguite da una scarica di colpi di fucile contro la folla[7]: fu ucciso l’ufficiale dei Carabinieri Luigi Casciana e ferite otto persone, al che i militari che circondavano l’edificio risposero al fuoco. Poco dopo questi eventi il fuoco divampò.Tutti gli ospiti del Narodni Dom riuscirono a salvarsi, ad esclusione di Hugen Roblek – che in alcune fonti è indicato come custode dei locali. Roblek si getto da una finestra e morì sul colpo mentre la figlia che si lanciò con lui pur ferendosi gravemente si riuscì a salvare. L’incendio distrusse completamente l’edificio: per qualche testimone l’intervento dei vigili del fuoco fu impedito dagli squadristi; per altri invece l’intervento dei vigili del fuoco ci fu e riuscì ad impedire al fuoco di attaccare gli edifici circostanti. Secondo alcune fonti il rapido propagarsi dell’incendio con numerosi scoppi fu favorito dal fatto che gli slavi celavano all’interno del Narodni un arsenale di esplosivi ed armi.[8].
Notare che non si capisce più perché il fuoco divampò. Inoltre il cuoco Nini, che per Kacin-Wohinz fu ucciso da un fascista, ora risulta ucciso da uno “slavo”. E infine ricompare il fantomatico arsenale. Siamo tornati alla versione della questura, proprio quella smontata da Kacin-Wohinz e altri. Ma il tutto ora è “coperto” dalla citazione furba di… Kacin-Wohinz.
Quindi io avrei artatamente modificato la voce Narodni dom? Un altro effetto collaterale della mia pagina utente?
Per favore, circostanzia quanto affermi del sottoscritto. Ti ringrazio.
Purtroppo la tua presenza attiva nell’editing collettivo di una voce dove proprio in quella fase si stava pesantemente manipolando una fonte con il risultato di giustificare un crimine fascista ti ha fatto finire per errore nel calderone. Il tuo profilo utente, che tu stesso riconosci essere facile da fraintendere, ha fatto il resto. Mi scuso, e se è possibile, chiedo che il tuo nome venga cancellato dal mio commento.
Grazie anche a te per la tua correttezza.
Il mio commento sopra è troppo breve, per cui mi permetto di ribadire “grazie” – e non vuole essere cazzeggio.
Lo saprete già, ma su it.wiki è sorto un dibattito su questa recensione. E si notano, lampanti, vecchi sistemi di ragionamento, vecchi metodi… anche utenti di buona levatura intellettuale mi sembrano intrappolati nella logica della neutralità wikipediana, che certo mi sembra asintoticamente sensata, ma che è anche una ideologia impossibile, fatto che mi sembra particolarmente evidente quando si discute di temi caldi (e di storiografi caldi), come è stato evidenziato da Furriadroxiu qui. Il punto è forse che non è l’assunzione in proprio che dell’istanza della neutralità può fare il singolo utente a produrre contenuti neutrali, ma l’istanza della saggezza della folla, che è un’istanza quantitativa. In questo panorama, il volontario scopre che il proprio pov è un vero problema solo se, appunto, si ha in mano un agenda. Se uno non l’ha, ha solo da saper scrivere bene, da saper integrare adeguatamente i temi attraverso una adeguata intelligenza delle fonti terze e autorevoli. I wikipediani dovrebbero essere solo dei “passacarte”, che arricchiscono l’enciclopedia attraverso la rielaborazione di tutte le fonti autorevoli che hanno sotto mano, compatibilmente con il loro tempo libero. Per questo tutti coloro che in ragione di questa recensione affluiranno a it.wiki con in mano non agende ma libri, articoli, fotografie, booklet di album discografici e una buona dose di probità, rappresentano solo una benedizione per il progetto, che lamenta una cronica scarsezza di utenti. Se fossimo di più, forse anche i cammellati ne uscirebbero meglio.
Tutto ciò mi suggerisce una considerazione: anche se a me sembra del tutto evidente che it.wiki abbia patito e patisca l’operato mellifluo di diversi pov pusher revisionisti, con una agenda incompatibile con i pilastri wikipediani (perché tesa a fissare una verità, peraltro piuttosto malconcia), euristicamente è molto più potente l’assunto di Talia: non importa e non è utile andare a sfruculiare lobby e lobbine. Sul piano wiki, paga molto di più badare solo al merito dei contenuti. Allora, per chi ne è capace, sarebbe bello interessarsi anche di pov ed enfasi “rossa”, andando a limare agiografie maoiste, staliniane, titiane, polpottiane… Questo, ovviamente, se si reputa wp meritevole di un contributo come progetto in generale.
Chiunque sia in buonafede capisce che una “chiamata alle armi” può essere o meno compatibile con i pilastri wikipediani: se infatti si difendono i pilastri, la cosa è giusta e condivisibile. Se invece si tratta di una chiamata alle armi in difesa di una verità “de sinistra” (o “de destra”!), non va bene. Esistono peraltro armi scariche e mani nude che menano. L’arma è nella testa.
A richiamare l’esistenza di una cricca di destra si ottiene solo una sfilza di excusationes non petitae da gente che si irrita a sentirsi dare del fascista (quando peraltro non è stato fatto!). Basta unire i puntini. Per quel che vale, tanto è solo un fatto della coscienza. Sempre che avere opinioni personali non sia ormai un affronto politico. Su it.wiki ci sono utenti non fascisti che, pure, hanno una allergia fortissima per il comunismo o per Tito, ad esempio. Altri che erano “biologicamente” di sinistra e che, secondo un malinteso intendimento del concetto di neutralità, si sono caricati della responsabilità di parificare il peso specifico del sangue di quei morti. Poi ci sono fascisti sic et simpliciter, però con occhiali e calamaio.
La tentazione sarebbe quella di “convertirli”, nel senso di spiegare loro perché avere un’agenda su Wikipedia è tanto errato, tristo, avvilente, quanto entusiasmante è trovarsi nel fair play di fronte a tradizioni ideologiche anche opposte. Ma è perfettamente inutile: Edward e Jane Murdstone sono quello che sono e in paradiso non ce li potremo mai portare.
Quando il giro d’Italia venne bloccato a Pieris e Trieste aggredita dai fascisti…
leggendo la pagina di wikipedia sui fatti di Pieris del 1946, domina una sola versione, che è quella fatta propria dal nazionalismo italiano, non si parla delle aggressioni fasciste accadute a Trieste ai danni della comunità slovena e contro gli antifascisti, in relazione a quei fatti e neanche della probabile provocazione che avrebbe determinato il tutto, qui ho scritto un breve intervento http://xcolpevolex.blogspot.it/2014/05/quando-il-giro-ditalia-venne-bloccato.html
Tempo fa ho creato Manypedia. Potrebbe essere utile per controllare specifiche pagine.
Ad esempio a
http://manypedia.com/#|it|Squadrismo|en
si vede che i 5 utenti con piu’ edit a questa pagina sono Barbicone (con 366 edit) Jose Antonio (263) Salvatore Talia (73) Emanuele Mastrangelo (62) Marte77 (20)
http://manypedia.com/#|it|Fascismo|en
Emanuele Mastrangelo (208) Piero Montesacro (94) Mv (85) Bramfab (81) Francomemoria (50)
http://manypedia.com/#|it|Francesco_Misiano|ru
Delfort (30) Salvatore Talia (8) Jose Antonio (6) Emanuele Mastrangelo (5) AttoBot (4)
http://manypedia.com/#|it|Battaglia_di_Tarnova|ru
Emanuele Mastrangelo (229) Pigr8 (34) Demiurgo (24) Il Dorico (23) 188.152.57.74 (22)
http://manypedia.com/#|it|Attentato_di_via_Rasella|sv
Piero Montesacro (123) Demiurgo (77) Emanuele Mastrangelo (46) Ribbeck (36) Vituzzu (28)
queste semplici statistiche ci dicono che nelle pagine menzionate in questo articolo effettivamente “Emanuele Mastrangelo” e’ (era…) bello presente.
COME TI DIFFAMO #BASAGLIA SU #WIKIPEDIA
Per capire in che modo Basaglia sia diventato repubblichino su wikipedia grazie a Theirrules e con l’imprimatur di Presbite, ecco lo storify dell’inserimento in wiki della “notizia”.
6 agosto 2011: nella talk di Presbite Sandro_bt chiede se si può “chiudere” sull’ eccidio di Vercelli. Theirrules chiede qualche giorno di tempo dicendo di avere una notiziola interessante da inserire.
11 agosto 2011: Theirrules annuncia nella talk della voce “Eccidio di Vercelli” di aver trovato una fonte che indica Basaglia come repubblichino della colonna Morsero. La fonte è un libro di Bruno Vespa, “Vincitori e vinti”.
4 novembre 2011 Jose Antonio inserisce nella voce su Basaglia la “notizia” su Basaglia repubblichino, indicando come fonti Bruno Vespa e Marco Pirina.
L’inserimento viene subito perfezionato da Theirrules.
5 novembre 2011: Piero Montesacro smonta la bufala portando in talk come fonte autorevole la monografia su Basaglia di Colucci e Di Vittorio.
Provvede anche a rimuovere dalla voce “Basaglia” la falsa notizia su Basaglia repubblichino.
1 maggio 2012: Theirrules inserisce la falsa notizia su Basaglia repubblichino nella voce sull’ eccidio di Vercelli,
asserendo falsamente che tale notizia sia già presente nella voce su Basaglia.
21 luglio 2012: Presbite propone di avviare la procedura per il riconoscimento della voce sull’ eccidio di Vercelli come voce di qualità.
20 agosto 2012: la voce sull’eccidio di Vercelli viene riconosciuta voce di qualità col voto favorevole del proponente Presbite, di Jose Antonio, di Arturolorioli e del “referee” Adert.
La storia di questa bufala dimostra con un esempio concreto che i famosi meccanismi autocorrettivi di wikipedia non sono sufficienti a preservare il progetto dall’uso strumentale che alcuni utenti ne fanno. Infatti la bufala su Basaglia repubblichino, dopo essere stata smascherata e cacciata fuori dalla porta, è stata fatta rientrare alla chetichella dalla finestra, dalle stesse persone che l’avevano fatta entrare la prima volta. Ci è voluto Giap, cioè una segnalazione dall’esterno, perchè la bufala venisse di nuovo cacciata fuori da wikipedia.
Ciao, posso suggerirti di usare i “link permanenti” invece che copiare semplicemente l’indirizzo della pagina? Lo puoi fare dal menu “Strumenti” a sinistra della pagina.
Ad esempio https://it.wikipedia.org/wiki/Discussione:Eccidio_dell%27ospedale_psichiatrico_di_Vercelli#Altre_fonti.2C_altre_info&oldid=61200612
In questo modo se in futuro la discussione venisse archiviata in una sotto-pagina il link rimarrà funzionante. Purtroppo facendo alcune prove sembra che l’unico modo per avere un link permanente alla sezione specifica della pagina, funzionante, sia usare gli URL non puliti:
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Discussione:Eccidio_dell%27ospedale_psichiatrico_di_Vercelli&oldid=61200612#Altre_fonti.2C_altre_info
Il link permanente alla versione può comunque essere utile in molte altre occasioni, come si è visto ampiamente in questo caso.
qualche wikipediano può aggiornare la pagina di Ronchi d.l con la vicenda #ronchideipartigiani?
questo il link http://www.wumingfoundation.com/giap/?p=15535
ivi inclusi i commenti che aggiornano della situazione in itinere! E’ questa una operazione antifascista importante, che ci ha scatenato contro le furie reazionarie tanto previdibili e scontate quanto noiose e ripetitive nel difendere la loro maledetta falsità storica! Grazie.
per i wikipediani che ci leggono. La pagina di Ronchi dl dopo la segnalazione su GIAP è stata aggiornata così:
“Nel dicembre del 2013 un comitato di cittadini ha ottenuto la revoca della cittadinanza onoraria a Mussolini.[10] Lo stesso comitato ha iniziato a raccogliere le firme per una petizione popolare, che chiede la cancellazione della dicitura “dei Legionari” e la sua sostituzione con la dicitura “dei Partigiani”, con riferimento al ruolo svolto dai ronchesi nella lotta di liberazione (si veda la sezione “Onorificenze”)[11]
Inesattezza:
La cittadinanza onoraria è stata revocata il 14 aprile 2014 http://xcolpevolex.blogspot.it/2014/04/dal-14-aprile-2014-ronchi-e-un-comune.html e non a dicembre 2013; io ero presente quel giorno!
per correttezza andrebbe segnalato l’intervento su GIAP http://www.wumingfoundation.com/giap/?p=15535
da cui è partito il tutto.
Grazie!
Documentazione esistente sul “conflitto reale”, in attesa di miglioramento: https://meta.wikimedia.org/wiki/Conflict-driven_view_of_wiki
In base a quale fonte su #wikipedia si legge che la “foiba” di Basovizza è monumento nazionale?
Da una ricerca effettuata, con i motori di ricerca normativi disponibili, il DPR del 1992 è introvabile, sarà che non esiste? E se esiste perché non è prodotto ad oggi da nessuna parte? E senza DPR un sito non può essere definito e dichiarato monumento nazionale
http://xcolpevolex.blogspot.it/2014/07/il-pozzo-minerario-foiba-di-basovizza-e.html
[…] un post di Giap (il blog su cui scrive il collettivo di scrittori Wu Ming) che mi pare illuminante: http://www.wumingfoundation.com/giap/?p=17162 […]