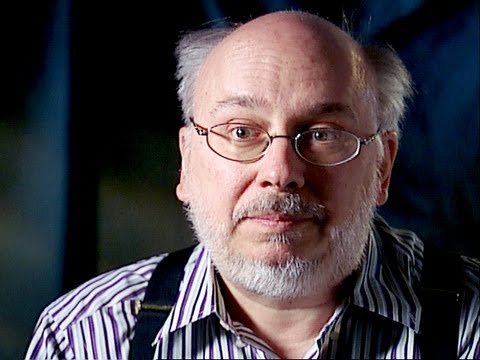
Non è un’allegoria “tamariana”, tipo “Lenin in Inghilterra” (cfr. Mario Tronti, Operai e capitale, 1966) o “Picard e Daton su El-Adril” (cfr. Star Trek: The Next Generation, Darmok, 1991). No, il significato della frase è letterale: Henry Jenkins viene a Bologna. Mercoledì 27 giugno, alle h. 11 am, terrà una conferenza al Salone Marescotti del DAMS, via Barberia 4. Riportiamo il comunicato stampa:
«La sezione Cinema del Dipartimento di Musica e Spettacolo e il gruppo di lavoro del convegno internazionale Media Mutations organizzano, mercoledì 27 giugno 2012, ore 11.00, Salone Marescotti, un incontro con Henry Jenkins (University of Southern California), dal titolo “How Content Gains Meaning and Value in the Era of Spreadable Media”.
Negli ultimi anni, l’industria culturale ha riaffermato con forza la priorità dei contenuti (il contenuto è sovrano, è stato il loro slogan). Oggi è però diventato sempre più complesso definire cosa siano precisamente i contenuti culturali. Non si tratta più, infatti, di prodotti professionali consumati dalle audience. Piuttosto, sempre più spesso, le pratiche in atto incrementano il ruolo delle audience nella creazione di contenuti e facilitano un cambio di prospettiva rispetto al valore e al significato di questi materiali. La conferenza di Henry Jenkins, che prende le mosse da un suo libro in uscita dal titolo Spreadable Media: Creating Value and Meaning in a Networked Culture (curato assieme a Sam Ford e Joshua Green), offrirà alcune riflessioni sull’ecologia dei media che si sta delineando in questi anni, dove le audience giocano un ruolo sempre più attivo e significativo nell’interpretare, creare, e remixare i contenuti mediali. Jenkins si soffermerà sul fatto che i modelli industriali dominanti – Web 2.0, viralità, passaparola – non sono più adeguati a descrivere il ruolo dei pubblici nella messa in forma dei contenuti culturali.
Di tutti i cambiamenti nell’ambiente mediale negli ultimi due decenni, forse il più grande è stato proprio quello relativo ai meccanismi di circolazione, con il passaggio da una distribuzione controllata dalle corporation (modello top-down) ad un, ancora emergente, sistema ibrido in cui ognuno di noi può avere un ruolo sempre più centrale nel modo in cui si diffondono i contenuti mediali. Quali problemi emergono quando il modello di circolazione grassroots dei contenuti viene posto al centro della nostra attenzione? Come cambiano i rapporti tra mass media e cultura partecipativa?»
.
***
Sei-sette anni fa, fummo non i primi ma sicuramente tra i primi a far conoscere in Italia le analisi di Jenkins (allora docente al MIT, oggi all’USC) sulla “cultura convergente”, la dimensione partecipativa delle culture popular contemporanee, l’intelligenza collettiva e la cooperazione sociale nelle comunità dei fan, le narrazioni transmediali etc. Ci sembrava necessario introdurre quegli elementi, per allargare gli orizzonti rispetto al dibattito nostrano – provinciale, ripetitivo, asfissiante – sulla “cultura di massa”, con la sua perenne oscillazione dal polo “apocalittico” a quello “integrato”. Tra le altre cose, scrivemmo la prefazione all’edizione italiana del più importante libro di Jenkins, Cultura convergente (Apogeo, 2007).
A distanza di qualche anno – anche in Italia e complice il boom dei social network – molti dei concetti che allora parevano astrusi (o validi solo per certe nicchie di consumatori mediali) non fanno che descrivere le prassi quotidiane di milioni di persone. La partecipazione del “pubblico” è stata riconosciuta e sollecitata in ogni modo (si pensi al giornale on line che ci ha più volte esortati a fotografarci con un cartello che dicesse questo e quello) e la formazione di “comunità”, “cerchie” e “tribù” di fan e consumatori è incorporata sin dall’inizio in molti prodotti culturali.
A un certo punto, delle teorie di Jenkins e altri iniziarono a circolare “vulgate” impoverite e annacquate, usate per fare l’apologia dei processi in corso. Soprattutto, usate per prescrivere anziché descrivere: tutto va ben madama la marchesa sentiamo come la pensa Luca Sofri la rete è libera e bella io sto con Matteo Renzi e Candido L’Innovazione un nuovo social dedicato alle start-up di questo deve occuparsi una vera sinistra moderna guardami come sono coraggioso quando dico che Lady Gaga è un genio Giorgio Gori è un genio uff ancora con queste storie se fosse per voi comunisti sentiamo che ci dice Matteo Bordone comunque la Banda della Magliana è sexy cos’hanno da rompere il cazzo ‘ste femministe che non scopano fateci vedere la gnocca chissà come se la caverebbe Renatino in un talent se non ti spari dieci serie TV intere al mese non puoi dirti un intellettuale Ricci è un genio non si discute poter vedere La pupa e il secchione è una questione di libertà che c’è di male nei libri di cucina i fan hanno sempre ragione sei tu che sei vecchio non hai le palle per stare in rete kguyiul òlkàpièp dstsgxgr aads ty ò
A conti fatti, il pendolino tra discorso apocalittico e discorso integrato continua a muoversi inesorabile: un processo è buono (e tu che lo critichi sei uno sfigato) o cattivo (e tu che ci stai dentro sei un venduto).
Certe teorie innovative sui media sono state usate per sdoganare merda “a sinistra” (le virgolette sono d’obbligo) in maniera indiscriminata, senza mantenere un barlume della critica – letteralmente: la capacità di tagliare, scindere, discernere – che tali teorie contenevano in origine. Ora che il mortifero sballo – complici la crisi che picchia col martello austeritario, il flop di Zuckerberg in borsa, la saturazione dei social network e cazzi vari – sta finendo, forse un rinnovato livore apocalittico sarà l’antidepressivo per la fase “down”. Chissà, forse le analisi di teorici come Geert Lovink o collettivi di attivisti come Ippolita (consigliatissimo il loro ultimo libro Nell’acquario di Facebook), che da anni mettono in guardia sui rischi di una perniciosa “ideologia del web” e sulle “recinzioni” operate dai grandi social network, verranno annacquate per produrre un discorso disfattista sulla rete. Nei grandi media, in una certa misura, è già successo con la banalizzazione delle posizioni di Jaron Lanier (spacciato per “apocalittico”) e con l’uso di Evgenji Morozov (malgré lui) come autore-prezzemolo (anche lui “apocalittico”). Per non parlare del Nicholas Carr di Google-che-rende-stupidi.
Intendiamoci, Henry Jenkins non è un anticapitalista: è un fan, è animato da un’autentica passione per le culture pop che analizza… Tuttavia, di certo non si limita a elogiare piattamente quel che accade. Prima di tutto, fa inchiesta: sviscera, approfondisce, intervista una plètora di persone, non smette mai di prendere e condividere appunti sui processi produttivi e sulla messa in valore del general intellect dei fan. Non è un marxista, ma molte sue osservazioni sono preziose per la critica dell’economia politica della cultura pop del XXI secolo. A volte, ai nostri scettici occhi europei, può sembrare solo un entusiasta, ma quando fa sul serio si guarda bene dal confondere potenza e atto: di ogni fenomeno mette in luce i possibili, le potenzialità. E come tutti i veri fan, “fa le pulci” (nitpicking) alla cultura che lo affascina.
Ma perché si finisce sempre per schierarsi con gli apocalittici o con gli integrati? Secondo noi accade perché – repetita iuvant – la cultura viene feticizzata, ovvero rappresentata in un modo che occulta e rimuove i rapporti sociali che la plasmano. Quando parliamo di “cultura” – o di “tecnologia”, e invero di qualunque altra cosa – parliamo sempre di rapporti sociali: il rapporto tra chi sfrutta e chi è sfruttato, tra chi possiede e chi no, tra chi domina e chi resiste al dominio. Se ci fosse più coscienza di questo, si capirebbe che nella cultura non vi è nulla che non sia in tensione, che non sia basato sul rapporto tra un dominio e una resistenza. Il dominio può sembrare assoluto, ma c’è sempre una resistenza, per quanto flebile o soltanto potenziale. C’è sempre il possibile di una resistenza, anche nella pratica apparentemente più subordinata e acquiescente. Per questo ogni processo è al tempo stesso positivo e negativo. Apocalittici e integrati rimuovono questa contraddizione.
Mesi fa abbiamo irritato un tot di gente quando abbiamo proposto di considerare “lavoro” l’attività degli utenti di un social network che, tessendo relazioni e fornendo contenuti gratis, fanno fare soldi alla corporation proprietaria del mezzo. Abbiamo scritto che quel lavoro, non essendo pagato, è tutto pluslavoro. Forse la descrizione era sbavata, o forse l’immagine è stata presa troppo alla lettera. Forse si ha un’idea troppo ristretta di cosa sia lavoro, o forse c’è della coda di paglia, visto che – chi più e chi meno – sui social network ci stiamo tutti. In ogni caso, di tutta la nostra riflessione sul feticismo delle merci digitali, quella definizione, “pluslavoro”, è la parte che più ha suscitato reazioni anche dure. Il nocciolo di quella suggestione, ad ogni modo, era: sui social network noi produciamo (segni, relazioni, dati…) e quel produrre è sempre parte di un rapporto di capitale. Rapporto tra assoggettamento e liberazione, tra capitale fisso e capitale variabile, tra sfruttamento e resistenza del lavoro vivo, tra dominio e ribellione (già attuale o ancora solo potenziale). Sui social network, e più in generale in rete, ogni interazione è permeata da tale conflitto – anche quando non sembra.
Questo conflitto non è una questione di stare-dentro o stare-fuori: non c’è un “fuori”. Ogni conflitto tra poteri e resistenze è una questione di tempi: tempi che il capitale impone e che la fantasia dei resistenti deve saper rallentare, interrompere, mettere in crisi. Questione di tempi, come nel vecchio slogan operaista “Resistere un minuto più del padrone”. Questione di tempi, come per la conquista delle otto ore, e se vi sembran poche, provate voi a lavorar.
Ogni fenomeno culturale è in tensione, momento di una relazione tra potere e resistenza, conflitto la cui posta in gioco è il tempo. Crediamo che solo tenendo in mente questo si possa avere un’immagine il meno possibile feticizzata della rete e della cultura che vive grazie a essa. E si possa ragionare sui processi senza essere apocalittici né integrati.
E’ con questo sguardo che noi leggiamo (anche) Henry Jenkins. [WM1]

 Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)
Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Appena 2 settimane fa è morta Elinor Ostrom, che aveva vinto il nobel per l’economia proprio studiando i Commons e le strategie per preservarli da vecchie e nuove forme di Enclosures. Soprattutto laddove statalizzazione e privatizzazione non bastano o, peggio, sono dannose. Negli ultimi anni la Ostrom, con Charlotte Hesse, aveva ben teorizzato come la conoscenza e i saperi dovessero esser considerati “beni comuni”, e come la loro circolazione dovesse essere lasciata libera e non imbrigliata. Le risorse comuni devono essere, secondo Ostrom ed Hesse, inquadrate come sottraibili e non sottraibili. La conoscenza è un bene non sottraibile per eccellenza perché entrarne in possesso non priva la collettività di parte del bene, anzi la accresce. Mi sembra uno dei migliori studi quel libro “La conoscenza come bene comune”, in cui è ben spiegato anche come Internet debba esser considerato un bene comune globale, e direi che in questa fase gonfia di retorica in Italia – in cui ci si deve intossicare di analisi e narrazioni su “popoli viola”, “popoli della rete” e movimenti “né di destra né di sinistra, ma liberi perché condividono tutto in rete” (leggi Grillo) – approfondire questi aspetti è per noi importantissimo. Jenkins è un ottimo stimolo e se fossi a Bologna seguirei con attenzione l’incontro. Linko un mio articolo sulla Ostrom, magari interessa a qualcuno http://www.controlacrisi.org/notizia/Conoscenza/2012/6/13/23452-e-morta-elinor-ostrom-nel-2009-aveva-vinto-il-nobel-per/
Mai sostenuto di essere un bravo fotografo, anzi. La foto che ho scattato oggi a Jenkins e Boccia Artieri fa cagare :-P
https://twitter.com/GBA_mediamondo/status/217226329878306816/photo/1
perfetto il discorsetto da “sinistra” “post-moderna” televisiva nostrana impregnata di locura
Son tutte cose che ho sentito dire davvero :-)
anche io purtroppo, ma leggerle tutte in fila fa impressione
Un primo resoconto della conferenza di Henry Jenkins a Bologna, scritto da Alberto Sebastiani:
http://caffeletterario-bologna.blogautore.repubblica.it/2012/06/27/jenkins-e-la-cultura-partecipativa/
Abbiamo registrato l’evento e nei prossimi giorni renderemo l’audio disponibile. Alla relazione è seguito un dibattito parecchio interessante e *politico* in modo molto diretto, durante il quale Jenkins – rispondendo in modo giustamente problematico a una domanda sullo “user generated content” come lavoro non retribuito – ha anche citato Marx! Fuck yeah.
E io che mi trovavo d’accordo col vostro post sul feticismo digitale! mi parevano più dati di fatto che opinioni… un vecchio repubblicano (in Romagna ne troviamo qualche migliaio ancora viventi, monitorati dal WWF) mi ha quasi insultato perché vedo la raccolta differenziata come un lavoro e non come un gagliardo passatempo, e conseguentemente rivendico un pagamento proporzionale a quanta spazzatura riciclo, ovvero uno sconto sulla bolletta, cosa, tra l’altro, già messa in pratica più o meno validamente in alcune parti d’Italia, così mi hanno detto.
[…] Ecco la registrazione della conferenza tenuta da Henry Jenkins al DAMS di Bologna il 27 giugno scorso. Per facilitare l’ascolto, proponiamo un breve compendio del suo discorso. […]
Anche nella stessa Romagna, a dire il vero: bisogna però conferire direttamente in isola ecologica.
Sì, ma l’obiettivo dovrebbe essere quello di non far pagare i rifiuti differenziati raccolti nel porta a porta, chè se tutti li portassero all’isola ecologica si sprecherebbe del gran petrolio per assenza di coordinamento.
Pubblico qui perchè non ho trovato altro luogo idoneo per farlo. Pubblico qui perchè questo messaggio è rivolto tanto a voi quanto (purtroppo virtualmente parlando) anche ad Henry Jenkins e al suo pensiero.
http://www.youtube.com/playlist?list=ELu5yG7t2Wg_E&feature=plcp
Lost in Google è un prodotto mediale molto particolare. Unisce abilità tecniche e ideali cinematografici ad un’acuta (e finora unica almeno per quelle che sono le mie conoscenze) visione, comprensione ed utilizzo dei nuovi e ancora poco esplorati linguaggi dei nuovi media.
Se poi a far bene tutto questo sono dei ventenni italiani, la cosa si fa ancora più interessante.
Vi invito a vedere tutte e cinque le puntate per poterne capire il senso fino in fondo
Sono davvero curioso di sapere cosa ne pensate.
P.S. la quinta puntata non è indicizzata nell’elenco del link precedente, per cui eccovela qui: http://www.youtube.com/watch?v=UWfsasWQpo8