
«Abbiamo tutti un’amica, un compagno, un amante, una parente, un vicino di casa, una collega che fino a pochi anni fa era inequivocabilmente di sinistra, ma da qualche tempo ha la mania di leggere dei blog un po’ ambigui, di seguire pagine Facebook che ci lasciano perplessi, di citare cazzari patentati come se fossero importanti pensatori controcorrente, di fare discorsi che riecheggiano quelli di Salvini ma in versione “comunista”…»
Uno spettro ci porta in volo nei luoghi della lotta di classe, dove si vede che certi discorsi “marxisti” contro l’immigrazione non solo di marxista non hanno nulla, ma sono una truffa ai danni delle lavoratrici e dei lavoratori. Di tutti i lavoratori: immigrati e autoctoni.
–
di Mauro Vanetti
indice della seconda puntata
6. Terza notte
7. Lenin No Border
8. L’ultima notte
9. La «bella sinistra di una volta» vi schifava uguale
10. Poscritto
6. Terza notte
Ormai aveva preso un po’ di confidenza. Si era fatto già trovare per strada, appoggiato a un muro.
— Bravo! Arrampicati — urlò il fantasma di Marx, gettando una scala di corda lunghissima da un puntino lontano nel cielo. La scala si srotolò fino quasi a toccare terra. Ondeggiava placidamente davanti al naso di Diego.
— Muovi il culo! — gridò la voce tonante da lassù. Il giovane era terrorizzato ma, un passo tremante alla volta, salì tra i palazzi, sopra la nebbia, verso le stelle, fino alle prime nubi. Ogni istante temeva di precipitare ma non osò disobbedire al famoso filosofo morto nel 1883.
Finalmente, scavalcò il parapetto della navicella di vimini e vide Marx manovrare le corde e la fiamma della mongolfiera per partire.
— OK. Questa volta niente jet, dobbiamo viaggiare di giorno e guarderemo da lontano. Puoi usare quel cannocchiale, ha un buono zoom.
Diego non si trattenne: — Egregio lemure, maestro, ma perché lo chiami «jet», quando c’è una bellissima parola italiana, «aviogetto»? E poi perché «zoom»? «Ingrandimento»! E anche «OK»…
Marx si irrigidì di colpo. Strizzò gli occhi sotto le sopracciglia folte e digrignò i denti. Lasciò la guida dell’aeromobile.
— Primo: lemure lo dici a tua sorella.
— Ma vuol dire spirito notturno! Dal latino.
— Lo so! Ma su Google trovi solo scimmiette ormai. La lingua si evolve, bestia.
— Capisco.
— E questa cavolata di non usare parole straniere da dove nasce? Cos’è, la difesa linguistica della patria? Gli operai non hanno patria. E se hai letto mezza pagina mia, metto una parola straniera ogni due righe. Se è in inglese, ci metto il francese. Se è in tedesco, ci metto l’inglese. Se è in francese, ci metto il tedesco. Ma si può essere un uomo di cultura nel secolo decimonono senza essere un po’ cosmopolita? E tu sei del ventunesimo e mi fai queste manfrine! Ma vatti a nascondere!
— Scusami.
— Scusato. Ora riprendo in mano questo trabiccolo e tu non mi rompi le balle. OK?
— Va bene.
— No! Devi dire «OK».
— Ma… ti prego… non riesco.
— Dillo!
— O… K.
— Alright.
ll pallone era di un tessuto rosso scuro su cui campeggiava in eleganti caratteri ottocenteschi color oro la scritta pubblicitaria «ERMEN & ENGELS». — Non chiedermi niente. — borbottò il lemure.
Prima dell’alba, le luci assonnate di una metropoli resero facile l’orientamento: — Ma quella è Roma! — disse emozionato Diego. Lo spettro sbadigliò e tenne la rotta, lasciando scorrere la capitale alla sinistra.
Un paio d’ore dopo, superati altri centri più piccoli, si cominciò a riconoscere in lontananza una città importante, dal piano regolare, in mezzo a un collage di rettangoli di varie tonalità di verde: campi di frutta e verdura.

— Riconosco anche quella: è Littoria!
Marx lo fulminò con lo sguardo.
— Latina! Volevo dire Latina… — si corresse subito Diego.
— Sai chi sono i Sikh? — domandò il vecchio.
— Un credo esotico.
— Esotico non vuol dire niente. Per te sarebbe esotica anche la Corsica. È una religione originaria dell’India. Ci sono più di ventimila sikh che lavorano nell’Agro Pontino, in condizioni pessime, anche 12 ore al giorno, per una paga ridicola. Gli stessi capi o capetti forniscono droghe per sostenere i ritmi nei campi e nelle serre: Engels mi raccontava che ai nostri tempi i capitalisti a volte usavano metodi simili nelle fabbriche inglesi.
— Questo è l’effetto dell’immigrazione clandestina.
— E come al solito ti sbagli. Sono quasi tutti immigrati regolari. La legge Bossi-Fini stabilisce che l’entrata regolare del migrante in Italia possa avvenire dentro i flussi prestabiliti a condizione che l’immigrato abbia già un contratto di lavoro pronto prima di partire. Di solito è una farsa perché questo è praticamente impossibile; ma le farse possono diventare tragedie. Ci sono dei reclutatori che vanno nei villaggi del Punjab e vendono a credito dei pacchetti completi: contatto col datore di lavoro, viaggio, alloggio. I migranti si indebitano per 4-8mila euro, e a quel punto sono in balia dei mediatori di manodopera, che possono obbligarli ad accettare qualsiasi lavoro per ripagare il debito. Questi reclutatori sono collegati con le mafie che spadroneggiano nel mercato di Fondi e coi caporali, che trattengono una parte del salario. E i padroni, che li cacciano all’istante se osano protestare, trattengono altre migliaia di euro in cambio della stipula del contratto che serve ad avere e rinnovare il permesso.
— Sì, è terribile. Però, senti: perché loro lo accettano?
— Proprio perché i flussi sono regolati! Ecco a cosa serve ai padroni avere la distinzione tra immigrati regolari e clandestini: si forma una gerarchia. E per stare a galla e avere i permessi diventi ricattabile. Ma poi, chi te lo ha detto che lo accettano? Guarda giù.
Erano arrivati nel 2016. La mongolfiera si era fermata sopra una piazza di Latina. Riconoscere un edificio squadrato di architettura fascista diede un brivido di piacere a Diego. Prese il cannocchiale per riconoscere la massa umana che si addensava nella piazza.

Dovevano essere circa quattromila persone. Tanto per cambiare, un tripudio di bandiere rosse. Ascoltavano molto ordinatamente i comizi in una lingua asiatica (Diego pensò: esotica) che venivano fatti salendo sopra una di quelle grandi “vele” pubblicitarie montate su un camioncino. Erano quasi tutti uomini dal viso olivastro, parecchi con barbe importanti e scurissime; molti avevano il cappellino del sindacato, altri dei turbanti di vari colori. Chissà se avevano addosso il kirpan, il pugnale che ogni sikh è obbligato dalla sua fede a portare.
— Stanno scioperando. Otterranno un aumento del salario a un livello più dignitoso.
— Quanto? — chiese Diego restando incollato al cannocchiale.
— Cinque euro all’ora. — rispose il fantasma.
7. Lenin No Border Lenin immigrazione

«Il compagno Lenin pulisce la Terra dalla sporcizia.», manifesto di ViKtor Deni, 1920. Non una patria ma il mondo, non «padroni a casa nostra» ma un pianeta senza padroni era il sogno dell’Ottobre e rimane il programma comunista. Clicca per ingrandire.
Marx ed Engels dedicarono la loro vita alla costruzione di partiti, movimenti e organizzazioni internazionali di ispirazione, indovinate un po’, marxista. Tuttavia, non ebbero mai cariche pubbliche, non erano neanche consiglieri di condominio. Il primo marxista che conquistò il potere politico alla testa di una rivoluzione per più di qualche giorno fu Lenin. Da questo punto di vista, le sue opinioni sul tema dell’immigrazione sembrano più rilevanti per capire come mettere in pratica l’internazionalismo su questo tema in termini di programma politico.
Siccome il nostro amico Diego bazzica i “sovranisti” (quelli “di sinistra”, si capisce!) e siccome i sovranisti amano non solo la patria italiana ma soprattutto quella russa, guidata dal presidentissimo Putin, di solito in quell’ambiente si vorrebbe fare bingo arruolando nelle file anti-immigrati anche l’anello di congiunzione per antonomasia tra la Russia e il marxismo: Lenin in persona. Sarebbe una tombola, perché si potrebbe avere un Giano bifronte, russissimo, da schierare in qualunque discussione: sei di destra? Bèccati Putin, omofobo e anti-immigrati; sei di sinistra? Bèccati Lenin, che è circa uguale.
Ci tocca porre un piccolo ostacolo a questo progetto: la realtà storica.
Come dovrebbe essere noto, Lenin fece parte della Seconda Internazionale (la Prima si era sciolta nel 1876-’77), all’interno della quale rappresentò l’ala più a sinistra. Si scontrò con la linea dominante nell’organizzazione fino a rompere completamente con i maggiori partiti che ne facevano parte e che distrussero l’Internazionale allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. La ragione fondamentale della rottura potrebbe essere descritta, in termini odierni, così: la gran parte dei partiti socialisti assunse posizioni sovraniste, di appoggio alla propria borghesia nazionale contro le altre nella Grande Guerra.
Contro questo che Lenin vedeva come un tradimento dell’internazionalismo marxista, venne in seguito fondata la Terza Internazionale ovvero l’Internazionale Comunista con sede a Mosca.
Molto prima di questa rottura, nell’agosto del 1907, la Seconda Internazionale tenne un suo congresso mondiale a Stoccarda. Lenin scrisse un rapporto dal congresso nel quale si intravedono i prodromi della futura degenerazione sovranista dei grandi partiti socialisti. Per esempio, Lenin criticò con indignazione il tentativo, da parte di alcuni socialisti dei Paesi imperialisti più rapaci, di approvare una mozione che potesse giustificare qualsiasi forma di colonialismo (fosse pure “colonialismo socialista”). Il tentativo fu sconfitto ma come sintomo preoccupò parecchio Lenin:
«Questo voto sulla questione coloniale è di grandissima importanza. In primo luogo, ha mostrato in modo impressionante l’opportunismo socialista, che soccombe alle blandizie borghesi. In secondo luogo, ha rivelato una caratteristica negativa nel movimento operaio, la quale può fare non poco danno alla causa proletaria e che per questa ragione va presa molto sul serio.»
Un’altra discussione in cui emersero posizioni confuse, in questo caso sconfitte a larghissima maggioranza, fu quella sulla questione femminile e in particolare sul diritto di voto: una posizione minoritaria sosteneva, sulla base di sofismi tattici, che bisognasse prima combattere per il suffragio maschile e poi per quello universale. Va citata per ricordare che nella storia del movimento socialista e comunista non si è mai disdegnata la lotta per i cosiddetti diritti civili, la cui denigrazione è invece un cavallo di battaglia di Diego.
Ma c’è un passaggio interessante nel rapporto di Lenin che riguarda proprio le migrazioni di lavoratori. Infatti, dal Partito Socialista Americano (che ci aveva già provato in combutta con gli australiani e gli olandesi al congresso precedente) era giunta una proposta di questo tenore: «Combattere con tutti i mezzi a propria disposizione l’importazione premeditata di manodopera straniera a basso costo, calcolata per distruggere le organizzazioni dei lavoratori, per abbassare il tenore di vita della classe operaia e per ritardare la realizzazione finale del socialismo.»
Il delegato americano Hillquit difese la proposta di restrizioni all’immigrazione prendendosela in particolare coi cinesi e altri popoli poco industrializzati «che non sono in grado di assimilarsi ai lavoratori del Paese di adozione». Sono le stesse fesserie che sentiamo dire oggi sugli africani o sui musulmani che non possono “integrarsi”. Questa proposta orripilante fu sconfitta. Ecco cosa ne scrisse Lenin:
«Qualche parola sulla mozione su emigrazione ed immigrazione. Anche qui, in Commissione c’è stato un tentativo di difendere ristretti interessi di bottega, di proibire l’immigrazione di lavoratori da Paesi arretrati (i coolie – dalla Cina ecc.). Questo è lo stesso spirito di aristocratismo che si trova tra i lavoratori in alcuni dei Paesi “civilizzati”, che traggono certi vantaggi dalla propria posizione privilegiata e sono, quindi, propensi a dimenticare la necessità della solidarietà di classe internazionale. Nessuno però al Congresso ha difeso questa ristrettezza di vedute corporativa e piccolo-borghese. La mozione approvata riflette appieno le rivendicazioni della socialdemocrazia rivoluzionaria.»
Ops! Ma questo è esattamente il contrario di quello che ci dice Diego, secondo cui la «sinistra petalosa e mondialista» è piccolo-borghese e distante dal proletariato e per questo motivo difende gli immigrati! Secondo Lenin erano proprio quelli che volevano bandire l’immigrazione a essere succubi dell’ideologia e degli interessi borghesi. Di più: secondo Lenin, anche il fatto che tra alcuni operai in Occidente si diffondesse la richiesta di fermare l’immigrazione era indicativo del fatto che la borghesia avesse “comprato” uno strato privilegiato della classe operaia.
La polemica con i socialisti americani non si placò negli anni successivi. Nonostante Stoccarda e nonostante le proteste dei socialisti nipponici, il Partito Socialista Americano insistette su una linea di “xenofobia di sinistra”. In una lettera a un altro gruppo di compagni americani, nel 1915, Lenin scrive:
«Nella nostra lotta per il vero internazionalismo e contro il “jingo-socialismo” citiamo sempre nella nostra stampa l’esempio dei leader opportunisti del P.S. in America, che sono a favore di restrizioni sull’immigrazione di lavoratori cinesi e giapponesi (specialmente dopo il Congresso di Stoccarda del 1907 e contro le decisioni di Stoccarda). Pensiamo che non si possa essere internazionalisti e allo stesso tempo a favore di queste restrizioni. E affermiamo che i socialisti in America, specialmente i socialisti inglesi, che appartengono alla nazione dominante e degli oppressori, che non sono contrari a qualunque limitazione dell’immigrazione, contro il possesso delle colonie (Hawaii) e per l’integrale libertà delle colonie, ebbene tali socialisti sono in verità dei jingoisti.»
Per «jingoismo» si intendeva una forma di nazionalismo feroce e guerrafondaio. I «jingo-socialisti» oggi li chiameremmo rossobruni.
Lenin torna più di una volta sul tema nei suoi scritti. Nel 1913 scrive un breve articolo concentrato soprattutto sull’immigrazione in America, ma che parla delle migrazioni di lavoratori in generale. Un’argomentazione spesso usata dagli xenofobi è che la sinistra anticapitalista non si rende conto che è proprio il capitalismo oggi a causare e organizzare le migrazioni. Ovviamente, ce ne rendiamo conto; il punto è che questo non è sufficiente a decidere come schierarsi. Ecco come invece pone la questione Lenin:
«Il capitalismo ha creato un tipo particolare di migrazione di popoli. I paesi che si sviluppano industrialmente in fretta, introducendo più macchine e soppiantando i paesi arretrati nel mercato mondiale, elevano il salario al di sopra della media e attirano gli operai salariati di quei Paesi.
[…] Non c’è dubbio che solo l’estrema povertà costringe gli uomini ad abbandonare la patria e che i capitalisti sfruttano nella maniera più disonesta gli operai immigrati. Ma solo i reazionari possono chiudere gli occhi sul significato progressivo di questa migrazione moderna dei popoli. La liberazione dall’oppressione del capitale non avviene e non può avvenire senza un ulteriore sviluppo del capitalismo, senza la lotta di classe sul terreno del capitalismo stesso. E proprio a questa lotta il capitalismo trascina le masse lavoratrici di tutto il mondo, spezzando il ristagno e l’arretratezza della vita locale, distruggendo le barriere e i pregiudizi nazionali, unendo gli operai di tutti i paesi nelle più grandi fabbriche e miniere dell’America, della Germania, ecc.»
Senz’altro è un pensiero più complesso dei memi razzisti e dei post di Salvini: è un pensiero dialettico. Lenin dice al tempo stesso che emigrare è tremendo, che l’immigrazione è un’occasione di business schifoso per i padroni, eppure ritiene che le migrazioni abbiano un significato progressista e addirittura rivoluzionario. E come chiama quelli che rifiutano quest’ultima verità? Reazionari. Cioè, diremmo oggi, fascisti o qualcosa del genere.
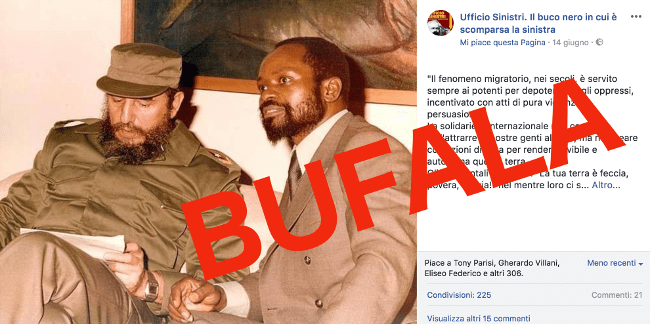
Tra i siti e le pagine Facebook che diffondono contenuti anti-immigrazione appiccicandovi sopra etichette “marxiste”, spicca «Ufficio Sinistri», pagina gestita da tale Vallepiano, autore anche di un omonimo libro. Il 14 giugno scorso Vallepiano ha pubblicato – ovviamente senza citare alcuna fonte – un presunto discorso di Samora Machel (1933-1986) in cui il leader anticoloniale mozambicano si scagliava contro l’emigrazione dall’Africa e la descriveva come una prassi controrivoluzionaria.
Nella discussione in calce al post, qualcuno che conosce bene pensiero e biografia di Machel (che era stato a sua volta un emigrante) ha chiesto le fonti; a brevissimo giro si è capito che stralcio e discorso erano inventati di sana pianta. Dopo molti solleciti, Vallepiano ha buttato lì il titolo di un libro, una raccolta di discorsi e scritti di Machel di difficile reperibilità, ma Lorenzo Vianini del gruppo Nicoletta Bourbaki lo ha reperito il giorno stesso e ha controllato. Nessuna frase minimamente somigliante, anzi: contenuti del tutto opposti.
Questa “logica” si era già vista con il meme finto-pasoliniano «Vedi, caro Alberto…», nato e diffuso negli stessi ambienti. [WM]
E che dire delle frontiere nazionali? Questo argomento da guardie doganali sembra appassionare molto quelli come Diego. Non vorrete mica dirci che Lenin era un fricchettone “no border”, un cosmopolita, per cui i confini sono solo linee immaginarie senza importanza? Non proprio, ma ci andiamo vicini:
«La borghesia aizza gli operai di una nazione contro gli operai di un’altra, cercando di dividerli. Gli operai coscienti, comprendendo l’inevitabilità e il carattere progressivo della distruzione di tutte le barriere nazionali operata dal capitalismo, cercano di aiutare a illuminare e a organizzare i loro compagni dei paesi arretrati.»
Il finale può sembrare un po’ paternalistico verso i lavoratori dei Paesi più poveri, ma in realtà solo poche righe più sopra lo stesso autore spiega come talvolta siano proprio gli immigrati a dare agli autoctoni lezioni preziose di lotta di classe:
«Gli operai che avevano vissuto scioperi di ogni tipo in Russia, hanno portato anche in America lo spirito degli scioperi di massa, più coraggiosi e offensivi.»
Questo risuona molto bene con l’esperienza degli ultimi anni in Italia, dove da un lato gli stranieri sono stati integrati in modo crescente nel sindacato e nelle lotte dei lavoratori italiani, dall’altro hanno in una serie di circostanze (e in particolare nell’agricoltura e nella logistica) rappresentato una punta avanzata di lotte particolarmente audaci ed esplosive.
Lenin torna sul tema nel 1916, quando scrive uno dei suoi capolavori ovvero L’imperialismo fase suprema del capitalismo. Nel testo afferma che se nella fase precedente del capitalismo le migrazioni di forza-lavoro (escludendo la tratta degli schiavi) avvenivano soprattutto a partire dall’Europa, nella sua fase imperialista diventa sempre più rilevante l’importazione di manodopera dalle colonie e dai Paesi più poveri. L’imperialismo esporta capitale e truppe nelle colonie, e ne importa materie prime e lavoratori:
«Una delle particolarità dell’imperialismo, collegata all’accennata cerchia di fenomeni, è la diminuzione dell’emigrazione dai paesi imperialisti e l’aumento dell’immigrazione in essi di individui provenienti da paesi più arretrati, con salari inferiori […] In Francia i lavoratori delle miniere sono “in gran parte” stranieri: polacchi, italiani, spagnoli. Negli Stati Uniti gli immigrati dall’Europa orientale e meridionale coprono i posti peggio pagati, mentre i lavoratori americani danno la maggior percentuale di candidati ai posti di sorveglianza e ai posti meglio pagati. L’imperialismo tende a costituire tra i lavoratori categorie privilegiate e a staccarle dalla grande massa dei proletari.»
Lenin usa una critica invertita rispetto a quella, che spesso ascoltiamo, secondo cui l’immigrazione ha creato uno strato di quasi-schiavi staccato dalla massa dei lavoratori. Dice invece che il fenomeno di cui preoccuparsi è la formazione di uno strato privilegiato di lavoratori autoctoni che guarda dall’alto in basso gli altri, tra cui gli immigrati. Ai giorni nostri, questa analisi va fortemente ridimensionata grazie alla decolonizzazione, alla grande crescita numerica del proletariato occidentale, alla proletarizzazione dei ceti medi e impiegatizi. Resta però indicativa dell’approccio leninista: il problema non sono gli immigrati e gli strati bassi della classe, il problema è il distacco degli strati alti e chi tenta di dargli politicamente voce.
L’anno dopo la pubblicazione del testo sull’imperialismo è il 1917, l’anno delle due rivoluzioni. Lenin inizia il 1917 da esule e lo finisce da capo del governo della Russia sovietica. È l’occasione per vedere concretamente come le sue idee sull’immigrazione siano state calate nella realtà.
Naturalmente, la Russia dopo la Rivoluzione d’Ottobre, sconvolta dalla guerra e poi dalla guerra civile, immersa in intrighi controrivoluzionari di ogni tipo e in giganteschi problemi economici, non era proprio l’obiettivo di grandi flussi migratori. Semmai, erano moltissimi gli emigranti: esponenti dell’aristocrazia e della grande borghesia in fuga dalla rivoluzione, prigionieri di guerra liberati, oppositori politici e migranti economici di varia estrazione. Tuttavia, fatta eccezione per le esigenze politico-militari, l’atteggiamento nei primi anni — cioè prima dello stalinismo — fu quello di realizzare il programma bolscevico di abolizione dei controlli dei passaporti sia interni (una delle caratteristiche più odiate del regime zarista, reintrodotta da Stalin nel 1932) sia esterni.
La Costituzione della Repubblica Socialista Federale Sovietica Russa del 1918 è, oltre e forse più che un riferimento giuridico, un documento politico che esprime gli intenti a lungo termine e i principî generali del nuovo regime. Sul tema dell’immigrazione esprime posizioni di radicale apertura dei confini:
Costituzione della Repubblica Socialista Federale Sovietica Russa, copertina originale, 1918.
«Art. 20. In forza della solidarietà dei lavoratori di tutte le nazioni, la Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa accorda tutti i diritti politici dei cittadini russi agli stranieri che risiedano sul territorio della Repubblica Russa per ragioni di lavoro e che appartengano alla classe operaia oppure ai contadini che non si avvalgano di lavoro altrui, e riconosce ai Soviet locali il diritto di accordare a tali stranieri i diritti della cittadinanza russa senza ulteriori difficoltose formalità.
Art. 21. La Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa concede diritto di asilo a tutti gli stranieri perseguitati per reati politici e religiosi.
Art. 22. Riconoscendo uguali diritti ai cittadini indipendentemente dalla loro razza o nazionalità, la Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa dichiara incompatibile con le leggi fondamentali della Repubblica la costituzione o la tolleranza di privilegi o di preferenze di qualsiasi genere attribuiti in base alla razza o alla nazionalità, come pure qualunque oppressione di minoranze nazionali o la limitazione della loro uguaglianza giuridica.»
Quindi: all’articolo 20 immigrazione libera e cittadinanza per tutti, all’articolo 21 accoglienza per tutti i profughi, all’articolo 22 divieto assoluto di discriminazioni razziste o etniche. Un partito di sinistra così leninista da avere nel suo programma questi punti sarebbe senz’altro accusato da Diego di essere al servizio del capitalismo globalizzato. Quante rivoluzioni ha fatto Diego? Nessuna? Ah, ecco: allora meglio fidarsi dell’Ottobre.

«Lavoratori di tutti i paesi e popoli oppressi delle colonie, alzate più in alto la bandiera di Lenin.» Poster di V. B. Koretskij del 1932.
8. L’ultima notte
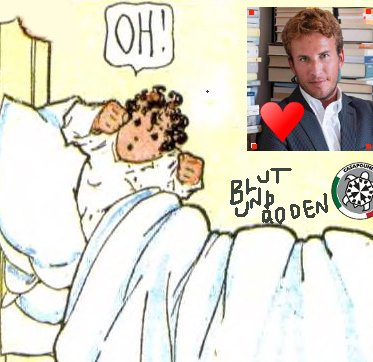 Sperava in un elicottero, in un idrovolante, in un’astronave. Ma quella quarta notte il fantasma di Karl Marx non arrivò più. Diego tornò di sopra, un po’ deluso, e dormì tutta la notte.
Sperava in un elicottero, in un idrovolante, in un’astronave. Ma quella quarta notte il fantasma di Karl Marx non arrivò più. Diego tornò di sopra, un po’ deluso, e dormì tutta la notte.
La mattina era ancora un po’ scosso. Gli era venuta voglia di rileggere qualche testo, di studiare. Forse era il momento di cambiare.
Il ricordo del fantasma però stava già svanendo. Tutto quello che era avvenuto gli sembrava irreale e inspiegabile. Non poteva essere successo davvero, né i viaggi con lo spirito di Marx né tutte quelle lotte fatte da allogeni, da turboschiavi sradicati, da marionette del cosmopolitismo borghese; e poi, cosa ci facevano lì in mezzo, nei campi e nelle officine, le bandiere della sinistra petalosa che pensa solo ai gay e ai diritti civili? Implausibile, onirico, falso.
Pensò però di controllare su Internet una per una le storie, per vedere se fossero vere, cosa ci fosse sotto, cosa fosse successo dopo; per cercare sui giornali se ne succedessero altre, in altri settori economici, con altre rivendicazioni, e che legami avessero con gli italiani, chi se ne stesse occupando.
Ma successe un’altra cosa: ricevette un messaggio sul telefonino, da un certo «Adriano CasaPound». Diceva: «Vista la storia del negro a Rozzano? Facci un pezzo per il Primato, daje».
Prendendo il telefono dal comodino, vide che era appoggiato su un pacco di bollette da pagare: della luce, del gas, della Linea Asimmetrica di Sottoscrizione Digitale… Il contratto con l’università dei ciellini scadeva a settembre.
Rispose: «Lo scrivo in giornata.»
«Bene, camerata. Nobis!», rispose Adriano.
Diego scosse la testa per scacciar via i pensieri fastidiosi.
Un lemure, era solo un lemure.
9. La «bella sinistra di una volta» vi schifava uguale
Sarebbe impossibile esplorare l’intera storia della sinistra mondiale, lungo tutti i suoi vari gradi di coerenza e di anticapitalismo, per scoprire dove e quando sia stata egemone in qualche partito o sindacato o movimento una posizione analoga a quella di Diego sull’immigrazione.
Sembra, dalla disamina fatta, che si possa escludere che questo sia il caso per Marx, Lenin e i loro più stretti sodali. Nella parte su Lenin abbiamo però visto che posizioni degeneri anti-immigrati emergevano eccome, qua e là, nel movimento socialista-comunista mondiale, costringendo gli altri a una battaglia teorica per difendere le idee fondamentali dell’internazionalismo. Anche la Terza Internazionale fondata da Lenin e Trotskij, cui aderirono dall’Italia Gramsci e Bordiga, ebbe a questo proposito le sue gatte da pelare. Al suo IV congresso, nel 1922, i terzinternazionalisti discutono la «questione orientale», espressione con cui all’epoca si intendeva ciò che potremmo definire «questione coloniale» o «questione del Terzo Mondo».
Come anni prima si era visto ai congressi della Seconda Internazionale, i Paesi in cui la sinistra era maggiormente infetta dal virus xenofobo erano i Paesi più ricchi affacciati sugli oceani: Gran Bretagna, Canada, USA, Australia, Giappone. Per motivi sociali, culturali, storici e anche banalmente geografici – sono più vistose le navi che solcano l’oceano, come oggi i barconi e le navi di soccorso nel Mediterraneo, rispetto alle migrazioni terrestri, e portano persone da luoghi più remoti – in questi Paesi il sindacato e la sinistra più incline al riformismo proponevano varie forme di regolamentazione o blocco dell’immigrazione, magari selettivamente contro alcuni Paesi più “barbari”.
Il tema è toccato con forza nella sezione «I compiti del proletariato nel Pacifico»:
«In vista del pericolo che si avvicina, i Partiti Comunisti dei Paesi imperialisti (America, Giappone, Gran Bretagna, Australia e Canada) non devono semplicemente diffondere propaganda contro la guerra, ma devono fare tutto il possibile per eliminare i fattori che disorganizzano il movimento operaio nei loro Paesi e che rendono più facile per i capitalisti lo sfruttamento degli antagonismi nazionali e razziali.
Questi fattori sono la questione dell’immigrazione e della manodopera di colore a basso costo.
La maggior parte dei lavoratori di colore portati dalla Cina e dall’India per lavorare nelle piantagioni di zucchero nella parte meridionale del Pacifico sono ancora reclutati sotto il sistema della servitù debitoria. Questo fatto ha portato i lavoratori nei Paesi imperialisti a rivendicare l’introduzione di leggi contro l’immigrazione e la manodopera di colore, sia in America sia in Australia. Queste leggi restrittive approfondiscono l’antagonismo tra lavoratori di colore e bianchi, il che divide e indebolisce l’unità del movimento operaio.
I Partiti Comunisti d’America, del Canada e dell’Australia devono condurre una campagna vigorosa contro le leggi restrittive sull’immigrazione e devono spiegare alle masse proletarie in questi Paesi che tali leggi, accendendo l’odio razziale, alla lunga si ripercuoteranno su di loro.
I capitalisti sono contro leggi restrittive negli interessi della libera importazione di manodopera di colore a basso costo per ottenere, per suo tramite, l’abbassamento dei salari dei lavoratori bianchi. L’intenzione dei capitalisti di andare all’offensiva può essere affrontata solo in un modo: i lavoratori immigrati devono unirsi ai ranghi dei sindacati esistenti dei lavoratori bianchi. Simultaneamente, si deve avanzare la richiesta che la paga dei lavoratori di colore sia innalzata allo stesso livello di quella dei lavoratori bianchi. Una mossa di questo tipo da parte dei Partiti Comunisti metterà allo scoperto le intenzioni dei capitalisti e allo stesso tempo dimostrerà platealmente ai lavoratori di colore che il proletariato internazionale non ha pregiudizi razziali.»
Il sistema della servitù debitoria è molto simile ai debiti che gli immigrati Sikh dell’Agro Pontino fanno coi mediatori di manodopera (in odor di mafia e caporalato), non cento anni fa ma ai giorni nostri. Eh, chissà se Diego ne ha mai sentito parlare…
Dalla fine degli anni Venti ci sono stati lo stalinismo, i fronti popolari, le “democrazie popolari”, la decolonizzazione, il maoismo, movimenti rivoluzionari più o meno eclettici, la trasformazione di molti partiti comunisti da avanguardie rivoluzionarie leniniste in partiti di massa più accomodanti col capitalismo… Nella sinistra si è allentato il rigore teorico che abbiamo trovato negli esempi fatti finora. Ciò non toglie che in linea di massima non sono mai state assunte le posizioni anti-immigrati oggi difese dai sovranisti sedicenti marxisti come Diego.

Paolo Cinanni
A puro titolo di esempio, introduciamo la figura di Paolo Cinanni (1916-1988). Combattente nella Guerra di Liberazione, dirigente di lotte contadine dopo la guerra, Cinanni fu un intellettuale del PCI la cui militanza fu segnata da un rapporto problematico col partito. Fondò con Carlo Levi la Federazione Italiana Lavoratori Emigrati e Famiglie. Nell’ambito della FILEF nacque il suo lavoro teorico più importante, Emigrazione e imperialismo. Siamo arrivati a Cinanni perché un amico di Diego, che ne aveva letto in un commento su un blog no euro, ce l’ha tirato fuori in una polemica di bassa lega su Twitter.
Alla base dell’uso strumentale di questo autore, come di molti altri, per sostenere la chiusura delle frontiere, ecco all’opera una modalità davvero puerile: si prende un pezzo di analisi e si lascia intendere che ne consegua una prassi simile a quella… di Salvini.
Questo approccio è particolarmente irritante e irrispettoso nel caso di autori militanti, come questo, che hanno lasciato scritto chiaro e tondo quali prassi politiche secondo loro andassero tratte dalle proprie analisi. Per esempio solo con molto pelo sullo stomaco un sovranista potrebbe citare questo brano come se fosse a proprio sostegno:
«L’emigrazione genera, invero, decadenza, e questa provoca nuova emigrazione, in un processo a spirale che lascia le nostre regioni dell’esodo senza fiato. L’unica merce che esse continuano a produrre è la forza-lavoro, ma con la sua partenza esse non perdono soltanto le spese sostenute per la sua formazione – sempre più qualificata e, perciò, sempre più onerosa –, ma perdono soprattutto il plusvalore da essa prodotto nelle regioni e nei paesi ove viene impiegata, a condizioni di particolare sfruttamento.»
— Visto? Visto?! — si eccita Diego,— Cinanni dice che l’emigrazione è una brutta cosa e che genera sfruttamento.
Diamo una camomilla a Diego e spieghiamogli che non serviva ce lo dicesse Cinanni, con rispetto parlando: abbiamo tutti parenti che sono emigrati e di norma avrebbero preferito risparmiarselo. Ma soprattutto abbiamo tutti davanti agli occhi lo stato miserando delle province italiane di grande emigrazione (interna o internazionale), specie meridionali e insulari.
Quello che dice Cinanni è che l’emigrazione impoverisce i Paesi di partenza a vantaggio dei Paesi di destinazione, ovvero, nel caso odierno, sposta risorse economiche dai Paesi di provenienza degli immigrati a vantaggio del padronato italiano. Cinanni sostiene, cioè, che l’immigrazione sia un vantaggio economico per i Paesi più ricchi, cioè proprio il contrario di quanto dicono oggi gli xenofobi per cui gli immigrati impoverirebbero l’Italia. Addirittura arriva a rivendicare che i Paesi di arrivo dei migranti dovrebbero compensare economicamente quelli di partenza, cosa che secondo lui le rimesse non fanno.
L’analisi di Cinanni è anche incompatibile con la teoria per cui gli immigrati generano disoccupazione; infatti Cinanni spiega che semmai sono gli emigrati a farlo, a dimostrazione che il numero di occupati (e quello dei disoccupati) nel capitalismo non è una grandezza fissa bensì dinamica, proprio come pensava Marx.
Ma se l’emigrazione per il comunista Cinanni è un male capitalista (Il male dell’emigrazione si intitola un suo testo), non sta dicendo che il blocco dell’immigrazione è un bene socialista? No. Lo spiega lui stesso benissimo:
«le migrazioni per motivi di lavoro così come avvengono oggi creano concorrenze e contrasti in seno alla stessa classe operaia; nonostante sia da tutti risaputo che l’immigrazione consente di dare maggior respiro al processo produttivo, di allargare il ventaglio dei settori della produzione, accelerando lo sviluppo complessivo del paese d’immigrazione, non è raro che il lavoratore straniero si senta dire che egli porta via il lavoro ed il pane al lavoratore locale.
Sono le stesse classi dirigenti che da una parte promuovono l’immigrazione e dall’altra hanno paura dell’unità dei lavoratori locali con gli immigrati, le quali suscitano le stesse campagne xenofobe, prendendo lo spunto dalle vicende e dai fatti occasionali più diversi.
È così che all’interno della stessa Italia, il quotidiano della Fiat conduce, a Torino, una sistematica campagna antimeridionalista: come in Svizzera, è l’industriale Schwarzenbach, che è a capo del partito anti-stranieri, che conduce la forsennata campagna xenofoba, che suggestiona sino al delitto i più ingenui e sprovveduti operai locali, seminando vittime innocenti fra i lavoratori immigrati.»
Per Cinanni, come per noi, la xenofobia è un’arma dei padroni che non si contrappone alle politiche migratorie capitaliste, ma al contrario le complementa.
Ancora una volta siamo di fronte a un pensiero dialettico, che richiede uno sforzo di comprensione delle contraddizioni. Se è vero che il padronato tenta di dividere i lavoratori per sfruttarli meglio, è vero anche che di per sé l’immigrazione non genera problemi economici generali perché tendenzialmente produce, in prima approssimazione, una crescita dell’economia proporzionale alla crescita della popolazione:
«Proporzionalmente alla massa di lavoratori immigrati, aumenta quindi la produzione in tutti i settori; aumenta sul mercato la domanda di beni di consumo, senza che ciò porti – ove non ci sia illecita speculazione – turbamento alcuno nell’economia del paese, in quanto l’emigrato produce sempre più di quanto consuma, e ciò rappresenta la miglior garanzia antinflazionistica.»
Si tratta dunque non di difendere l’economia nazionale dalla minaccia di un’invasione catastrofica, giacché tale minaccia non esiste e l’economia nazionale probabilmente si gioverà dell’apporto di forzalavoro immigrata, ma semmai di difendere il tenore di vita degli operai, degli impiegati e degli altri salariati, ovvero di strappare fette più grandi di reddito dalle mani dei padroni. Come farlo? In primo luogo Cinanni smonta lo slogan «Prima gli italiani!» (o prima i tedeschi, o prima i belgi, o, come nel suo esempio, prima gli europei comunitari):
«Ogni forza lavoro immigrata, deve, secondo noi, “costare” all’economia che impiega quanto costa la forza-lavoro locale. Ogni preferenza gioca in effetti in senso contrario, ed ogni differenza di trattamento mette in concorrenza i lavoratori fra di loro, spezzando l’unità del mercato del lavoro, e minando, con l’unità di classe, ogni prospettiva di avanzamento sociale.
L’emigrazione non deve diventare il moderno “esercito di riserva”, col quale si ricatta la classe operaia locale; se le forze-lavoro immigrate costano di meno e consentono al capitale un profitto più elevato, oggettivamente – anche a loro insaputa – esse fanno concorrenza ai lavoratori locali, sollevando tutte le furie della discriminazione, dell’ostracismo civile e della xenofobia.
Ciò è da evitare, e di tale esigenza devono rendersi soprattutto conto la classe operaia e le sue organizzazioni, imponendo un’effettiva “parità di costo” del lavoro.»
Secondo Cinanni, gli immigrati non sono un esercito industriale di riserva perché hanno tassi di occupazione simili agli autoctoni. Sarebbe proprio la messa in pratica di slogan come «Prima gli italiani!» a rischiare di renderli tali: tutti disoccupati, quindi separati economicamente dalla classe lavoratrice indigena e pronti a esercitare una pressione al ribasso sui salari. Viceversa, una necessità vitale per il movimento operaio diventa quella di parificare il costo del lavoro immigrato e del lavoro autoctono, cioè alzare i salari degli immigrati fino all’uguaglianza.
Ci si risponderà che è utopistico, perché gli immigrati sono dei poveracci che vivono in baracche, sono sottoproletariato, non possono mettersi a pari. Ebbene, in Italia, oggi, questo è falso. Lo dimostra la distribuzione dei redditi:
Non è immediato leggere questi dati, ma ciò che dicono è che metà degli extracomunitari sono più poveri di tre quarti degli italiani. Quindi, l’altra metà guadagna di più del quarto più povero degli italiani. Lo stesso vale anche per gli stranieri comunitari (tra cui si trova la minoranza più grande: i rumeni). Questa è una buona notizia: ci dice che tutto sommato, anche se gli immigrati guadagnano nettamente meno in media, non c’è una stratificazione etnica come se ci fosse l’apartheid: i proletari stranieri fanno parte della stessa classe dei proletari italiani, a cui sono abbastanza mescolati dal punto di vista retributivo. Divide et impera ? Ci provano, ma ce l’hanno fatta solo un po’. L’uguaglianza non è fuori portata, ma bisogna lottare: conviene a tutti (tranne che ai padroni).
E che dice Cinanni proprio di quelli come Diego, degli xenofobi “di sinistra” che vorrebbero correggere la linea “buonista” dei partiti di sinistra e dei sindacati introducendo slogan contro l’immigrazione? Be’, non ci va giù leggero:
«Oggi, in tanti paesi, sembrano raggiunte dalla lebbra xenofoba anche grandi organizzazioni operaie; certi sindacati si chiudono addirittura nel più cieco corporativismo, senza riuscire, per altro, a garantire i fondamentali interessi della classe operaia locale, in nome della quale affermano di schierarsi con la discriminazione antistranieri. In verità, c’è da dubitare della stessa buona fede di certi dirigenti sindacali, che pur sapendo che sul piano economico l’immigrazione accelera e dà più ampio respiro allo sviluppo economico del paese; pur sapendo, altresì, che sul piano sindacale l’apporto dei lavoratori immigrati potrebbe rappresentare un contributo decisivo al rafforzamento del potere contrattuale dell’intera classe operaia; e che sul piano politico stesso, l’unità di tutta la classe operaia può rappresentare – in Svizzera, per esempio – un solido baluardo contro ogni involuzione anti-democratica e sociale; pur sapendo tutto ciò, certi dirigenti sindacali fingono, tuttavia, di credere essi stessi alla favola dell’immigrato che “ruba il pane” al lavoratore indigeno, e sottoscrivono anche loro – come è avvenuto in Svizzera – il referendum antistranieri.»

San Gallo, Svizzera, un corteo del Primo Maggio nei primi anni Settanta. I lavoratori immigrati italiani manifestano contro la xenofobia, per il diritto alla libera circolazione senza restrizioni (gli stagionali erano costretti a lasciare il paese ogni nove mesi) e al ricongiungimento famigliare e per l’unità della classe operaia. Fotografia di Raniero Fratini, giornalista della radio nazionale svizzera. Fonte.
Cinanni scrive in una interessante terra di mezzo, che è l’Europa occidentale degli anni Settanta: uno spazio economico dove convivono regioni di forte emigrazione, come il nostro Mezzogiorno, regioni di forte immigrazione e infine regioni sempre più miste, come è diventata oggi l’Italia, al tempo stesso terra di emigranti (la «fuga dei cervelli» che in realtà è soprattutto fuga di braccia italiane in Germania, Francia, Inghilterra, Canada) e destinazione di grandi flussi migratori dall’Est Europa, dall’Africa, dall’Asia, dall’America Latina.
Cinanni si pone giustamente il problema di come frenare il processo distruttivo dell’emigrazione, che sta soffocando il Sud e che lui vede come prosecuzione in epoca post-coloniale della politica imperialista di dominio e rapina sui Paesi poveri e sulle regioni arretrate. Scarta subito l’idea reazionaria del blocco dell’emigrazione e del rimpatrio dei migranti, che definisce inutile e anzi controproducente. Si appella invece al superamento del capitalismo, al socialismo e alla lotta sociale e politica, certo, nei Paesi di origine, ma anche in quelli di destinazione:
«Solo in una economia equilibrata, pianificata secondo i bisogni sociali, le forze produttive si sviluppano insieme e con lo stesso ritmo del sistema economico, e in questo caso non ci sarà più bisogno né dell’emigrazione, né dell’immigrazione. Ma sotto il dominio del capitale, con l’aggravarsi dell’ineguale sviluppo e degli squilibri territoriali, si aggrava anche il drenaggio di forze-lavoro per cui la sola prospettiva e la sola lotta per il ritorno non ci sembra sufficiente: essa, infatti, pone le sue rivendicazioni e rivolge la sua azione solo nei confronti del governo del paese d’origine, ma lascia disarmata l’emigrazione nei confronti del sistema che quotidianamente la sfrutta e della politica imperialista che genera lo stesso sottosviluppo dei paesi dell’esodo.
Pertanto, alla prospettiva del “ritorno”, cui è particolarmente sensibile ogni emigrato, occorre affiancare quella del cosiddetto “compenso”, ossia della effettiva parità di costo – per la economia che le impiega – della forza-lavoro immigrate e di quella locale.
Ciò scaturisce dalla più rigorosa analisi del fenomeno, ma rappresenta soprattutto un’esigenza fondamentale per mantenere l’unità del movimento operaio.»
Nel 2016 Rodolfo Ricci ha curato la pubblicazione di una raccolta di scritti di Cinanni che è veramente una miniera di analisi molto preziose per comprendere come la questione fosse posta all’inizio degli anni Settanta. Questa pubblicazione può essere scaricata online liberamente.
Si può ben dire, dopo questa pur rapidissima carrellata, che nella seconda metà dell’Ottocento, come nella prima metà e nella seconda metà del Novecento, tutti i pensatori comunisti più acuti hanno sempre tenuto una linea simile sul problema dell’immigrazione.
Questa linea è il contrario esatto di quanto predicano quelli come Diego.
Questa linea è sempre stata antirazzista, no border, internazionalista, a favore dell’unità della classe lavoratrice.
Se a qualcuno non va giù, il problema è tutto suo, ma perlomeno speriamo che dopo questo articolo smetta di giocare a nascondino.
10. Poscritto
In questo testo abbiamo parlato dei migranti in generale, non dei cosiddetti profughi. I migranti che vivono in Italia sono in larga parte immigrati regolari (l’8% della popolazione).
Una minoranza rilevante (un immigrato su dieci) è costituita dai clandestini, cioè dai migranti che non hanno documenti. Molti di loro prima o poi riusciranno a ottenerli e diventeranno immigrati regolari, e viceversa i migranti regolari potrebbero perdere il diritto legale a stare in Italia e diventare clandestini.
I clandestini non fanno parte di una razza speciale: sono solo persone trattate come reietti da ingiuste (e inapplicabili) regole burocratiche. I “profughi” sono un gruppo ancora più piccolo — meno dell’1% della popolazione — di cui si parla in maniera sproporzionata per motivi politici.
Diego fa spesso confusione tra queste categorie e pensa che in Italia milioni di migranti siano messi «negli hotel» a 35 euro al giorno. Cerchiamo di non essere fessi come Diego.

August Diehl nel film Il giovane Karl Marx di Raoul Peck, 2017. Qui il trailer.
Karl Marx era un migrante e un profugo di origini tedesche, olandesi ed ebraiche. Emigrò nel 1843 in Francia, da dove fu espulso su pressione della Prussia nel 1845, rifugiandosi in Belgio. Fu arrestato ed espulso dal Belgio nel 1848. Tornato in Francia e poi nella Germania scossa dalla rivoluzione, fu espulso nuovamente nel 1849 verso la Francia, ma neppure la Francia gli diede asilo. Finì dunque profugo a Londra.
 Vladimir Ilic Ulyanov, detto Lenin, era un migrante e un profugo di origini (pare) russe, tedesche, svedesi ed ebraiche. Nel 1900 emigrò in Svizzera e poi in Germania. Nel 1902 sfuggì alla polizia bavarese spostandosi a Londra. Tornato in Russia dopo la rivoluzione del 1905, ne dovette fuggire da profugo nel 1907, tornando in Svizzera e poi in Francia e per un breve periodo a Londra. Durante la Grande Guerra visse da immigrato in una regione oggi polacca dell’Austria-Ungheria e in Svizzera, senza poter rientrare in Russia, come è noto, fino al 1917.
Vladimir Ilic Ulyanov, detto Lenin, era un migrante e un profugo di origini (pare) russe, tedesche, svedesi ed ebraiche. Nel 1900 emigrò in Svizzera e poi in Germania. Nel 1902 sfuggì alla polizia bavarese spostandosi a Londra. Tornato in Russia dopo la rivoluzione del 1905, ne dovette fuggire da profugo nel 1907, tornando in Svizzera e poi in Francia e per un breve periodo a Londra. Durante la Grande Guerra visse da immigrato in una regione oggi polacca dell’Austria-Ungheria e in Svizzera, senza poter rientrare in Russia, come è noto, fino al 1917.
Consigli di lettura
 ■ Luca Lombardi, «Le miserie della sinistra anti-immigrati»;
■ Luca Lombardi, «Le miserie della sinistra anti-immigrati»;
■ David L. Wilson, «Marx on Immigration. Workers, Wages, and Legal Status»; (tradotto in italiano qui);
■ Paolo Cinanni, Rodolfo Ricci (ed.), Che cos’è l’emigrazione. Scritti di Paolo Cinanni.
Sul caporalato agricolo nell’Agro Pontino e gli scioperi dei braccianti indiani consigliamo il film The Harvest, regia di Andrea Paco Mariani.
Lotta di classe, mormorò lo spettro è dedicato a Soumaila Sacko, sindacalista USB ucciso a San Calogero (Vibo Valentia) il 2 giugno 2018.
N.B. I commenti a Lotta di classe, mormorò lo spettro verrano aperti alle h. 9:00 del 30 giugno 2018.
Segui Mauro su Twitter → @maurovanetti


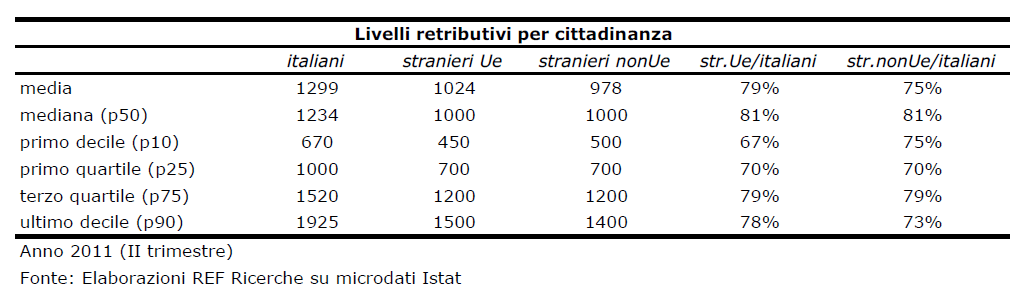

 Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)
Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)


[…] Machel, quel passaggio non risulta da nessuna parte. Lo avevamo già fatto notare in un box dentro la seconda puntata di Lotta di classe, mormorò lo spettro. Ora possiamo dire qualcosa di […]
Leggo questi due pezzi come una sorta di “strumento”, molto raffinato, da utilizzare nelle varie colluttazioni (“discussioni” è eccessivo) da social o da dibattito para televisivo. Credo che una buona idea sia fra l’altro quella di fare una sorta di spin off contenente tutti i possibili casi che riusciamo a segnalare di lotte comuni di autoctoni e immigrati e, meglio ancora, quelle che hanno gli immigrati come principali proptagonisti. Un pezzo magari aggiornabile, un po’ sulla falsa riga di “Renzi scappa”, chissà che non possa essere anticipatore di buone notizie, come quell’altro.
A proposito di “strumenti” una cosa che mi sembra tipica dei giapster potrebbe (dovrebbe) essere quella di accettare le discussioni – anche se la pazienza di Mauro e dei WU Ming non ce l’abbiamo – a partire però della descrizione della struttura della stessa. Provo a spiegarmi. In uno scambio su twitter uno sosteneva che i zapatisti volevano cacciare gli immigrati. Naturalmente non è vero, ma nel momento in cui è stato fatto notare c’è stato un repentino tentativo di cambiare il nocciolo della discussione domandando “la classe sociale” dell’interlocutore. Ora, non mi pare importante il fatto in sè o che la domanda sia particolarmente fuori fuoco, ma mi pare che sia un leit motiv che si ripete spesso, soprattutto nelle discussioni in cui si avventura il nostro Beauregard.
“Marx diceva che gli immigrati irlandesi dovevano essere cacciati a calci in culo”
– veramente no, non l’ha mai detto
“Tu non hai dimostrato che questo è l’esercito industriale di riserva”
– Ma… non volevo dimostrare questo
“Ah-A beccato!”
Il suggerimento è quello di non andare avanti nelle discussioni fino a quando l’interlocutore non riconosca di aver detto una cazzata e di NON seguirlo nelle diramazioni. (“Calenda è un mio nemico se ha quella priorità, come Salvini” “Calenda non è Salvini perché ha fatto questo e quell’altro”. Si azzera e si torna indietro: puoi essere gesù cristo, o NON HAI quella priorità o sei una merda).
Complimenti a Mauro Vanetti, un esempio di fact-checking storiografico davvero efficace che non si limita soltanto a fornire dati e nozioni verificate ma le cala in una cornice narrativa che ne potenzia la presa. E senza ambiguità fra la fiction e l’informazione storica, anche quando risultano sovrapposte come nelle visioni notturne del buon(?) Diego. C’è bisogno di pezzi come questo per contrastare, tra le altre cose, la vulgata che vuole Salvini quale un genio della comunicazione e il relativo corollario “macchissenefrega se le sue sparate oltre che eticamente ributtanti fanno da foglia di fico al mancato conseguimento degli obbiettivi strombazzati! Sa comunicare, la Lega cresce nei sondaggi e blablabla”. Non è l’unico che se la cava con la comunicazione, ribadiamolo una volta di più. E poi credo ci sia un qual certo margine di differenza fra l’abilità richiesta per fare da cassa di risonanza a pulsioni basiche e quella che invece occorre per divulgare analisi complesse in forma creativa.
La strategia di appropriazione indebita attuata dai rossobruni (o “bruniebbasta”), al di là della sguaiataggine con la quale reagiscono quando li si coglie in castagna, ha una sua perversa raffinatezza. Consente di accalappiare una fetta di persone genericamente (e non dubito sinceramente) di sinistra ma dalla scarsa alfabetizzazione politica, le quali rifuggirebbero da una propaganda apertamente razzista ma a una “che, insomma, se anche Marx diceva che l’esercito industriale di riserva…, allora, forse si dovrebbe…” possono prestare invece attenzione. Il vantaggio di questo format consiste nel far appoggiare a costoro idee e politiche razziste dandogli, al contempo, l’illusione di non essere poi in contraddizione con le proprie convinzioni etiche. Di più, dandogli la certezza di aver trovato la formula per risollevare le sorti di una sinistra ostaggio del “mondialismo immigrazionista”! Quanto sia numericamente consistente questo target, non saprei dire, ma ultimamente mi pare in crescita o almeno lo è nella mia filter bubble.
Venendo all’imbarazzante caso Fusaro, vorrei solo fare qualche considerazione sulla sua equazione migranti=nuovi schiavi. Ora, nella miniserie è spiegato molto chiaramente quanto sia indifendibile la pretesa di giustificare questo assunto richiamandosi al pensiero marxista e non ci sarebbe altro da aggiungere. Quello che sgomenta è che un accademico dimostri una tal crassa ignoranza in merito alle stesse dinamiche dello schiavismo come fenomeno storico. Leggendo le analisi(?) fusariane si evince come egli ritenga che i migranti siano “una massa di schiavi post-identitari e senza coscienza di classe, umiliati, strutturalmente instabili, servili e sfruttabili senza impedimenti e a ogni condizione” sostanzialmente privi della capacità di compiere scelte autonome e organizzarsi per rivendicare i propri diritti e proprio per questo “il capitale deporta dall’Africa migliaia di nuovi schiavi disposti a tutto e pronti a essere sfruttati illimitatamente, il “materiale umano” ideale per le nuove pratiche dello sfruttamento neo-feudale”. Sorvolando sul fatto che non è così, ma ci rendiamo conto che costui reputa le popolazioni africane naturalmente inclini alla sottomissione? Non è consonante con l’opinione che ne avevano colonizzatori e schiavisti europei dell’età moderna? Ma soprattutto, il ragionamento si sfalda completamente perché balza agli occhi che la passività che imputa oggi ai migranti non valeva neppure per gli schiavi ieri (Rivolta di Haiti, gli dirà qualcosa?). E anche il suo ossessivo identitarismo sembra impedirgli di vedere il grande, sfaccettato e vitale apporto culturale offerto dai popoli che hanno subito la schiavitù e vi si sono poi ribellati. Non può essere così incapace di vedere il conflitto laddove è conclamato, gli è proprio che non vuole farlo.
(Visto che le fonti vanno sempre citate, per chi ha voglia: https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/09/20/migranti-il-capitale-deporta-i-nuovi-schiavi-per-sostituirli-al-popolo-europeo/3867637/)
Per trovare risonanze col discorso di “Diego” a proposito della “naturale inclinazione alla sottomissione” degli “allogeni” non occorre nemmeno andare nelle colonie in Africa. Basta andare a Trieste.
“Al confine orientale non esiste alcuna minoranza nazionale, ma soltanto gruppi sparsi di allogeni, di popolazione che non ha una propria storia né è legata ad alcuna civiltà, come non ha un proprio sentimento di nazionalità e non ha una cultura nazionale; essa è costituita da raggruppamenti rurali e vi si nota subito l’ assenza di una classe intellettuale e della più modesta istruzione… Privi di una propria convinzione e di qualsiasi coscienza nazionale, essi sono sempre guidati o con la forza e l’intimidazione oppure con le lusinghe e le illusioni. E così le cose dovrebbero restare anche in futuro.”
Così scriveva nel 1929 Livio Ragusin Righi nel suo volume “Politica di confine.” Gli allogeni di cui parlava erano gli sloveni e i croati della “Venezia Giulia”, sottoposta dal 1919 a una violentissima politica di stampo coloniale.
Quindici anni dopo quegli allogeni, contadini e operai, insieme ai proletari italiani con cui lavoravano gomito a gomito, diedero alla “bimillenaria civiltà italica” una rata tale che i “discendenti dei legionari di Cesare” ancora se la ricordano con terrore.
Il contesto in cui è usato il termine dovrebbe renderlo chiaro anche ai non triestini, ad ogni modo: «rata» vuol dire più o meno “scarica di mazzate” :-)
@Bazzo In realtà Fusaro sa benissimo di cosa parla e cosa sta dicendo. Ha passato l’intero periodo universitario a studiare Marx. Ebbi l’occasione di parlarci, se non ricordo male nel 2006, e stava lavorando alla sua tesi su Marx e lo conosceva più che bene. E’ semplicemente in malafede, sa bene di mentire e di pervertire il pensiero di Marx, di Gramsci e di chiunque citi. Il punto è molto semplice, con Marx non raccogli gloria. Proporlo nella lettura comunitarista del suo maestro Costanzo Preve può essere un buon inizio, ma ancora non basta. Con l’emergere degli effetti della crisi in tutta la loro drammaticità, bisognava degradare il pensiero di Marx a una poltiglia dozzinale che andasse incontro alle paure inconsce delle classi medie che vedevano il loro status minacciato. Non solo piccola borghesia, ma anche impiegati, operai con anzianità, famiglie plurireddito magari proprietarie di casa. L’Italia dopotutto è il paese occidentale con la più alta patrimonializzazione privata e questa ricchezza è minacciata dalla crisi. Fusaro più o meno scientemente è andato incontro alle paure provocate da questa minaccia. Si è riuscito così a ritagliare una nicchia di pubblico sempre più grossa, man mano che gli effetti della crisi sono progrediti e soprattutto man mano che questi hanno portato gente che in periodo di vacche grasse era di sinistra a diventare di destra quando le vacche sono diventate magre. Perciò mente sapendo di mentire e lo fa perché altrimenti sarebbe un signor nessuno e dovrebbe sbattersi come tutti gli altri.
La cosa che trovo allucinante è come persone che si definiscono marxiste possano pensare che sia una riduzione del numero di lavoratori disponibili in un paese e non il conflitto sociale a creare migliori condizioni per l’affermarsi dei diritti della classe operaia. Questa gente evidentemente non vuole intraprendere nessuna lotta, vuole solo che qualcuno (un duce a caso) crei quelle che secondo loro sono condizioni “migliori”.
Non solo gli scritti di Marx e Lenin, ma tutta la storia del movimento dei lavoratori in Italia contrasta nettamente con questo atteggiamento. I braccianti che costituirono la base socialista prima e comunista poi dell'”Emilia rossa” erano forse una classe lavoratrice il cui numero eccedeva cronicamente rispetto ai posti di lavoro disponibili, ed erano, almeno inizialmente, dei migranti “sradicati”.
Prendiamo il caso della bassa ferrarese, che sto approfondendo e da dove provengo. Da bambino mia nonna mi cantava il “Canto degli scariolanti”
«A mezzanotte in punto
si sente un gran rumor,
sono gli scariolanti
che vanno a lavorar.
Volta e rivolta
e torna a rivoltar;
noi siam gli scariolanti
che vanno a lavorar»
Perché era in italiano e non in dialetto? Perché gente sottoposta ad una fatica bestiale che era in buona misura analfabeta e per la quale l’italiano era una seconda lingua che parlava magari con grande difficoltà non cantava nel proprio dialetto? Perché non ce lo avevano un dialetto comune. Perché venivano da diverse province del Veneto, dell’Emilia e della Romagna e si ritrovarono nella bassa ferrarese quando cominciarono i lavori di bonifica a fine XIX secolo.
Tant’è che Emilio Sereni (comunista “ortodosso”, partigiano e poi deputato del PCI) nella sua opera “Il capitalismo nelle campagne (1860-1900)” scrive:
«è caratteristico il fatto che in questa zona ed in quest’epoca, in cui lo sviluppo delle opere di bonifica ha concentrato qui i lavoratori di province diverse, molti dei canti del lavoro sono, come questo, non in dialetto, ma in “lingua”, in italiano: ed anche in questo piccolo particolare comincia ad esprimersi la coscienza che il proletariato agricolo comincia ad acquistare su scala nazionale».
Tra 1881 e 1901 infatti la bassa ferrarese fu un luogo di massiccia immigrazione . In quel periodo l’incremento annuale della popolazione della provincia di Ferrara fu del 9,2 per mille a fronte di un incremento della popolazione nazionale del 7,3 per mille. Addirittura l’incremento annuo del circondario di Comacchio (comprendente i comuni di Comacchio, Migliaro, Massafiscaglia, Lagosanto, Codigoro e Mesola) fu del 14,6 per mille, esattamente il doppio della media nazionale.
La massa di braccianti creata dalle bonifiche era sottoposta ad una cronica disoccupazione. Durante l’inverno infatti i campi non abbisognavano della loro opera e a meno di non trovare lavoro come scariolanti o come manovali essi rimanevano privi di ogni entrata. Nel 1897 si calcolava che nel ferrarese i braccianti lavorassero in media 200 giorni all’anno, con un guadagno complessivo che non superava le 300 Lire annue. All’inizio del Novecento le inchieste del Ministero dell’agricoltura attribuivano ai braccianti bolognesi, ferraresi e romagnoli un numero di giornate lavorative annue che andava dalle 86 alle 113. Sono tutti dati che si trovano nell’opera di Serene e in quella di Alessandro Roveri (altro storico di area PCI).
Secondo Sereni, oltre ad aver richiamato masse di disoccupati per i lavori di bonifica, il capitalismo agrario presente nel ferrarese e in larga parte dell’Emilia e della Romagna creava quella lui definiva «sovrappopolazione artificiale», che era all’origine della cronica disoccupazione bracciantile. Questa «sovrappopolazione artificiale» era dovuta proprio allo sviluppo di un’agricoltura moderna e produttiva. Prima infatti la produzione di un fondo agricolo era gestita dalla famiglia contadina che impiegava tutti i suoi membri anche quando erano sovrabbondanti o improduttivi. Una moderna azienda agricola, come quelle sorte sulle terre bonificate, invece impiega solo i salariati di cui ha davvero bisogno, inoltre con l’impiego di macchine e una migliore organizzazione cerca di ridurre gli addetti e nel contempo aumentare la produzione.
Di fatto quindi la nascita del movimento dei lavoratori nel ferrarese e in buona parte della Val Padana si trattò di una sindacalizzazione di massa di lavoratori precari e perennemente a rischio di restare disoccupati.
Questa sindacalizzazione di massa non si ebbe perché qualcuno cacciò una parte dei lavoratori e creò così “condizioni favorevoli”, ma proprio perché questa massa di “sradicati”, slegati da ogni rapporto paternalistico con il padronato proprio dalla loro condizione di precari e di persone con provenienze diverse iniziò ad operare forme di lotta dure miranti a creare un vero contro-potere di classe. Un contro-potere che si esprimeva attraverso due conquiste:
1) il collocamento di classe, ovvero l’assunzione di braccianti o l’assegnazione di fondi ai mezzadri attraverso l’intermediazione delle organizzazioni sindacali, in modo da evitare che i lavoratori venissero posti in concorrenza tra loro.
2) l’imponibile di mano d’opera, che consisteva invece nell’imporre ai proprietari l’assunzione di un determinato numero di lavoratori in base alla quantità di terra da loro posseduta.
La bassa ferrarese fu uno dei luoghi dove prima e più massicciamente le leghe bracciantili cercarono di raggiungere questi obiettivi che portarono ad un aumento dei salari e dei diritti, tant’è che il padronato dovette istituzionalizzare il terrorismo di classe con il regime fascista per fermare la spinta bracciantile.
Insomma proprio la storia del movimento dei lavoratori in Emilia dimostra che il numero dei disoccupati e le condizioni dei lavoratori non dipendono dal numero di lavoratori disponibili, ma dalla loro capacità di lottare, di lottare sul serio imponendosi forme dure di disciplina. Non è che nella gloriosa “Emilia rossa” fossero tutti solidali ed eroici, è che i crumiri non arrivavano con lo costole intere alla fine di uno sciopero e i granai e le stalle dei padroni che li assumevano avevano la brutta abitudine a prender fuoco durante o dopo il raccolto. Magari tener presente che oggi chi lotta sul serio bloccando la produzione sono proprio i migranti aiuterebbe qualcuno a staccarsi da masturbazioni geopoliche e attese di palingenesi affidate a forze reazionarie o fasciste.
Ti ringrazio per avere ricordato questa storia, che è quella da cui provengo.
Io sono figlio e nipote di braccianti sparsi tra Massafiscaglia (uno dei focolai di rivolta proletaria più importanti del primo Novecento, e poi di nuovo nel Dopoguerra) e Dogato. Mia madre è stata bracciante (oggi è in pensione). Due mie nonne e un nonno erano braccianti. Mio padre è stato operaio non della campagna ma dell’industria, per la precisione metalmeccanico (come tuttora mio fratello, che lavora alla TRW di S. Giovanni di Ostellato), ma quando è diventato sindacalista a tempo pieno ha fatto il capolega dei braccianti in vari comuni del basso ferrarese. Questa storia è la mia storia.
La mia famiglia è non solo storicamente ma letteralmente uscita dalle paludi grazie alle lotte, al collocamento di classe, all’imponibile di manodopera. E il proletariato rurale da cui discendo, come hai ricordato, aveva una composizione molto peculiare, era nato durante e dopo le bonifiche come frutto della grande immigrazione, e doveva molta della sua radicalità e tendenza all’insubordinazione proprio all’esperienza dello sradicamento e del “meticciato”.
A dire il vero, a me non viene in mente nessun precedente in cui abbia funzionato quello che “teorizzano” (parole forti…) i sovranisti “di sinistra”, i neo-leghisti ancora in parte verniciati di rosso, i fascisti che giocano al “Giano Bifronte”… Nella storia delle lotte proletarie mi sa proprio che non si è mai visto un caso in cui bloccare l’immigrazione e ridurre la complessità della composizione di classe abbia favorito la lotta di classe. È sempre avvenuto il contrario: l’immigrazione ha radicalizzato le lotte, che si parli del movimento operaio statunitense organizzato negli IWW nei primi decenni del Novecento, dell’operaio-massa venuto dal Sud Italia e divenuto protagonista dell’Autunno caldo e delle lotte nel “triangolo industriale”, o delle lotte nell’Italia di oggi, in particolare nella logistica.
Infatti, mentre i rossobruni straparlano, insultano, fanno battute sui bimbi annegati e vagheggiano una classe operaia tutta bianca e autoctona, proprio in questi giorni operai autoctoni e migranti sono protagonisti, insieme, dell’ennesima, durissima lotta all’Interporto di Bologna.
A proposito della lotta all’interporto di #Bologna, alcune preziose riflessioni di Infoaut.
«Durante i blocchi e gli scontri della scorsa settimana all’interporto si è assistito ad alcune scene paradossali e grottesche ma da cui si possono trarre non poche indicazioni politiche per il futuro: tra gli insulti e le minacce dei celerini e dei carabinieri durante i faccia a faccia con gli operai, oltre alle solite offese alle madri e ai frequenti “bestie, cani, merde” molto spesso abbiamo ascoltato “torna a casa tua maiale!”, “ti tolgo il permesso di soggiorno dopo che ti arresto!”, “vi ritocca sul barcone”. Scontate le risate degli operai che magari a Bologna ci sono nati o che al massimo il barcone che conoscono sono i pescherecci di qualche città del sud. Anche il compagno operaio pestato e arrestato sanguinante è un giovanissimo italiano assunto da poche settimane e unitosi alla lotta per esprimere solidarietà ai colleghi del magazzino Logista […] Crediamo che questo dato che solo in apparenza può apparire aneddotico stia impensierendo la Santa Alleanza di padroni di multinazionali e cooperative, quotidiani, politici e poliziotti di ogni ordine e grado coinvolti nel soffocare e reprimere questa importante lotta, e dall’altra parte da un punto di vista antagonista si può parlare di una serie di ipotesi per il futuro immediato e indicare sia tendenze o elementi politici importanti – soprattutto se scagliati sull’attuale fase politica nazionale configuratasi tramite il paradigma del “prima gli italiani” del governo giallo/verde. Si tratta certamente di embrioni di un fenomeno ma che iniziano ad essere ricorrenti.
Razza e generazione operaia. Il colore della pelle […] è un fatto politico, l’esempio dei celerini bolognesi decisamente caricati dal nuovo contesto politico nazionale è esemplare: nel momento in cui si lotta per il salario, o si partecipa solidarizzando con la vertenza, si diviene migranti. La presenza in un picchetto diventa un fattore di razzializzazione.»
Se lotti sei un migrante. Punti di vista su nuove composizioni giovani e scenari di conflitto dall’interporto di Bologna.
Vittoria all’Interporto di #Bologna. Una lotta condotta da lavoratori italiani e immigrati, insieme. Insieme hanno scioperato, insieme hanno preso le manganellate, insieme hanno vinto.
Mentre fascioleghisti, rossobruni e cialtroni disparati fanno di tutto per metterci gli uni contro gli altri, le lotte stabiliscono il piano di realtà.
Tutti i dettagli qui.
egregio Vanetti,
mi presento: ingegnere elettronico senza specifica cultura politica, storica e/o economica (solo sporadiche letture); mi ritengo un socialdemocratico, innamorato per esempio di quel che scriveva Federico Caffè; convinto che il capitalismo moderno debba seguire la strada della piena occupazione. non sono socialista, non sono comunista: sono il tuo conoscente che sostiene di essere di sinistra, E ANCHE che la tratta di barconi debba venire fermata, ANCHE PERCHÈ aumenta la disoccupazione MA SOPRATTUTTO PERCHÈ è disumana.
al proposito ti propongo alcuni spunti di riflessione.
(a) le tue precisazioni su Marx sono preziose per che come me
non l’ha mai letto, lo dico senza alcun sarcasmo. a leggere
però i passi che citi e i tuoi commenti, ti domando
(a1) la sovrappopolazione stagnante e maxime quella latente,
non sono forse serbatoi di manodopera non qualificata,
disperati alla ricerca di lavoro per un tozzo di pane?
(a2) i migranti che sopravvivono alle traversate non sono un tipo
simile di forza lavoro?
(a3) alla luce di ciò, Marx non avrà parlato di “migranti” sui barconi
come noi oggi, ma ho idea che lui stesso li avrebbe messi proprio
nell’esercito di riserva. magari inventandosi una quarta categoria,
oppure allargando quella dei latenti. questo ti sembra davvero
così assurdo?
(a4) la tua nota che “il capitale non richiede di attingere a fonti
esterne per rimpolpare l’esercito dei disoccupati” non è pertinente
all’oggetto del contendere. qui ci si domanda SE i migranti sui
barconi rimpolpino l’esercito di riserva, non se il capitale lo richieda.
(b) “se crediamo che l’immigrazione crei disoccupazione, dovremmo credere
anche che l’emigrazione crei occupazione” è una fallacia logica:
da “A implica B” non puoi dedurre che “non-A implica non-B”.
tolto comunque questo argomento logico/retorico, i fattori in gioco
sono molteplici complessi e lontani da una modellizzazione scientifica
efficace. che non si veda un’ovvia causazione (o anche una semplice
correlazione) fra immigrazione e disoccupazione può essere dovuto a
tanti motivi; per dire, l’immigrazione odierna per barconi è piccola
rispetto alla forzalavoro europea quindi l’effetto è scarsamente
visibile, presumibilmente annegato da altri fattori ben più forti.
e però, c’è.
l’immigrazione incrementa la forzalavoro ergo abbassa i salari, lo
ammetti anche tu e dichiari che lo diceva pure Marx, e i riferimenti
in Rete volendo si sprecano, qui per esempio citano HaJoon Chang:
https://socialdemocracy21stcentury.blogspot.com/2016/07/ha-joon-chang-on-wage-determination-in.html
e io francamente non vedo perché accettare una vergognosa tratta di
esseri umani che poi mi abbassa pure i salari, anche se di poco.
(c) che il benessere generale si raggiunga con la lotta di classe mi
pare sensato condivisibile e, francamente, ci credo. (non dico di
saperlo perché, lo ripeto, in storia e politica mi muovo un po’ come
il proverbiale elefante nella cristalleria.) Questo non toglie che
l’orribile tratta di esseri umani nel Mediterraneo vada bloccata
al più presto possibile. sei d’accordo su questo?
io alla luce di ciò non posso che apprezzare il blocco navale alle
ONG attuato dal governo. mostrare ai boat people che non si entra
significa che non ne verranno più, o che ne verranno molti meno,
e ne moriranno molti meno.
(d) a complemento di quanto dico al punto (c), aggiungo che, a mio
modestissimo avviso, i flussi migratori vanno gestiti e regolati dagli
Stati, o magari dall’Unione Europea se siete fra quelli che in essa
credono (io no, ma questa è un’altra storia) – questo non significa
in alcun modo auspicare la chiusura del Paese ai suddetti flussi.
sto parlando quindi di flussi di migranti dotati di permessi di
soggiorno e lavoro, e istradati a una sana integrazione nella società.
lasciarli crepare in barca, o peggio, farli entrare da irregolari e
“garantire” loro una vita da ultimi della società in aeternum a me
proprio non va. (come sappiamo bene, in effetti i morti in barca sono
una piccola percentuale: il resto finisce non si sa bene dove in tutta
Europa.)
con questo concludo per ora. sono apertissimo a qualunque critica al mio intervento – quando mi proclamo ignorante non lo dico per falsa modestia, credo che da queste parti potrei imparare qualcosa. a te la palla.
cordialmente,
Castellini
Buongiorno collega,
sono anch’io ingegnere elettronico, anche se mi occupo solo di software.
Provo a rispondere alle domande seguendo lo schema argomentativo che hai proposto.
(a1) Ai tempi di Marx era soprattutto manodopera non qualificata, ma ai giorni nostri il serbatoio del precariato contiene una grande quantità di manodopera qualificata. Non userei descrizioni apocalittiche che dipingono queste sezioni della classe come integralmente composte da morti di fame, perché rischiamo poi di non riuscire a riconoscerle nella realtà occidentale.
(a2) I migranti che sopravvivono alle traversate sono solo una minoranza dei lavoratori che entrano in Italia. In gran parte il proletariato immigrato in Italia ci è arrivato via terra o in aeroplano. Comunque senz’altro al loro arrivo molte di queste persone si trovano nei gradini più bassi della scala sociale: i gradini cui da sempre i comunisti prestano particolare attenzione cercando di farli risalire almeno fino al livello medio del resto della classe lavoratrice.
(a3) Come ho cercato di spiegare nell’articolo, gli immigrati né coincidono né sono un sottoinsieme della sovrappopolazione relativa (esercito industriale di riserva). Proprio come i lavoratori autoctoni, si distribuiscono nelle varie sottoclassi del proletariato: la maggior parte degli immigrati (inclusi quelli «dei barconi» che non sono geneticamente diversi dagli altri) finisce semplicemente a lavorare a tempo pieno; qualcuno finirà invece precario o disoccupato. Il tasso di occupazione degli stranieri in Italia è simile a quello degli italiani. Dal punto di vista marxista, non c’è ragione di considerare gli stranieri come necessariamente destinati a costituire l’esercito industriale di riserva.
Del resto siamo di fronte al solito paradosso del “migrante di Schrödinger”: simultaneamente «troppo pigro per lavorare» e dedito a «rubarci il lavoro». Tutto fa brodo per gli xenofobi. A noi invece interessa la condizione effettiva della classe e quindi dobbiamo spiegare che gli immigrati sono già integrati nella classe operaia italiana.
Tutti gli esempi che ho fatto nelle parti narrative (che fanno parte a pieno titolo della mia argomentazione) sono di immigrati che non fanno parte della sovrappopolazione relativa, che lavorano a tempo pieno e che lottano al fianco dei lavoratori italiani. Non c’è modo di sapere se sono arrivati coi barconi o con gli elicotteroni, né ha la minima importanza per la lotta di classe.
(b) La cosiddetta “negazione dell’antecedente” (A -> B => !A -> !B) non c’entra con la mia frase, che riporto perché è corretta: «Se crediamo che l’immigrazione crei disoccupazione, dovremmo credere anche che l’emigrazione crei occupazione». Infatti l’emigrazione non è la negazione dell’immigrazione, ma è un processo di segno opposto. È come se avessi scritto «Se crediamo che comprimendo un gas esso si scalda, dovremmo credere che espandendolo esso si raffredda»: infatti è ciò che avviene e naturalmente questo tipo di ragionamento è razionale e scientifico.
Quel che sto dicendo è che l’aumento demografico non ha gli effetti che il nostro “economista ingenuo” interiore potrebbe aspettarsi. Sempre nei passi dove introduce il concetto di esercito industriale di riserva, Marx spiega la faccenda con grande acume:
«Quindi la popolazione operaia produce in misura crescente, mediante l’accumulazione del capitale da essa stessa prodotta, i mezzi per render sé stessa relativamente eccedente.
È questa una legge della popolazione peculiare del modo di produzione capitalistico, come di fatto ogni modo di produzione storico particolare ha le proprie leggi della popolazione particolari, storicamente valide. Una legge astratta della popolazione esiste soltanto per le piante e per gli animali nella misura in cui l’uomo non interviene portandovi la storia.»
Non è meraviglioso? Karl sta dicendoci che non abbiamo la dinamica demografica degli altri animali, che se sono troppo numerosi si affamano a vicenda. Al contrario, nella società industriale più siamo numerosi più produciamo. Nel capitalismo, che è un modo di produzione con una disoccupazione strutturale, questo implica che una certa percentuale sia disoccupata, ma non perché siamo “troppi”: addirittura, si può dimostrare abbastanza facilmente che esiste semmai nel medio periodo una correlazione (anzi, un nesso causale) tra l’emigrazione e l’aumento del tasso di disoccupazione.
Vedo che non ho spiegato bene o non hai capito bene il ragionamento quando dici «l’immigrazione incrementa la forzalavoro ergo abbassa i salari»: no, non è questo il punto. L’immigrazione non abbassa i salari, ciò dipende dalla lotta di classe e non è un fenomeno automatico; l’essenza della teoria marxista del salario e della politica sindacale marxista è proprio che l’andamento dei salari dipenda in larghissima misura da quanto i lavoratori esigono, da come lottano e si organizzano («Dunque la determinazione del valore della forza-lavoro, al contrario che per le altre merci, contiene un elemento storico e morale» – questo è sempre il Capitale). Semmai si potrebbe dire che la disoccupazione abbassa i salari, ma la disoccupazione non dipende dall’immigrazione, anzi, probabilmente l’immigrazione diminuisce leggermente il tasso di disoccupazione (così parrebbe vedendo i dati).
Quella singola riga di citazione dell’economista sudcoreano Chang Ha-Joon vedo che è molto popolare in siti sovranisti e rossobruni. Mi sembra curioso, visto che è una citazione di un passo di straordinaria ottusità, mentre da quel poco che ho visto online credo che quell’economista (che comunque è favorevole al capitalismo) abbia prodotto roba migliore. Che ragionamento, francamente stupidissimo, fa Chang? Dice che se un guidatore di autobus svedese guadagna molto di più di un autista pakistano è perché ai pakistani è impedito trasferirsi liberamente in Svezia, altrimenti affluirebbero in massa fino ad abbassare gli stipendi da autista al livello pakistano. Questa idea cretina può avere senso solo ritenendo che i pakistani per motivi genetici abbiano bisogno di meno cibo, e a dire il vero pure in tal caso reggerebbe poco perché le donne hanno bisogno di meno cibo eppure con la lotta hanno conquistato salari via via più simili a quelli maschili. Ovviamente, se un pakistano va in Svezia a guidare bus, finisce per prendere lo stesso salario di un autista svedese biondo.
La «vergognosa tratta di esseri umani» non abbassa i nostri salari, neppure di poco. Ciò che li abbassa è quando perdiamo la lotta di classe e la vincono i padroni. Se ti interessa non cedere, neppure di poco, terreno ai padroni, l’antirazzismo è la tua arma più potente, non Matteo Salvini (che, guarda caso, è contrario a mettere leggi stringenti contro il caporalato).
(c) Naturalmente i barconi vanno “fermati”, ma non nel senso che intende Salvini. Vanno fermati nell’unico modo in cui ciò è possibile e coerente con l’interesse dei migranti stessi e della classe operaia internazionale: permettendo a tutte queste persone di immigrare in Europa in modo legale e sicuro. Non parlo dei soli “corridoi umanitari”, che per loro natura sono un fenomeno ridotto e selettivo, ma di una generale legalizzazione dell’immigrazione che rompa l’apartheid tra immigrati regolari ed irregolari. Questo distruggerebbe instantaneamente il business degli scafisti e le morti in mare, ma ovviamente togliendo al capitale uno strumento di divisione della classe incontrerebbe enormi resistenze politiche ed economiche: per questa ragione nessun partito dei padroni (e ben pochi tra i partiti di sinistra) lo propone.
Il blocco navale attuato dal governo è una misura crudele e per giunta del tutto inefficace (negli stessi giorni in cui si perseguitava la nave Aquarius, ne è sbarcata un’altra, statale, a Catania, che aveva a bordo centinaia di migranti in più). Serve solo a fomentare la divisione nella classe e a far gravare una spada di Damocle sulla testa dei lavoratori già immigrati, oltre che a risparmiare quattro soldi del sistema di cosiddetta “accoglienza” (in realtà un sistema farraginoso e corrotto di filtraggio delle richieste di asilo).
(d) In questo sito si è parlato spesso del concetto di frame, di cornice concettuale. In maniera più ottocentesca io direi che è importante scegliere di usare le categorie giuste. Secondo me bisogna fare uno sforzo affinché il linguaggio poco scientifico, confusionario e ideologico del capitale non sia usato anche da chi si oppone al capitalismo. Cosa mai significa «flussi regolati»? Alla fine è solo un eufemismo per indicare l’apartheid tra regolari e clandestini, l’affondamento di fatto dei barconi, la xenofobia di Stato.
Come sono regolati oggi i flussi? Lo faccio vedere nell’esempio dei sikh dell’Agro Pontino. Per regolarli si stabiliscono regole impossibili (bisogna avere il contratto di lavoro prima di venire in Italia!) e pene draconiane per chi le viola (il rimpatrio forzato ammanettato al sedile dell’aereo). Ovviamente siccome la pena del rimpatrio è costosissima per lo Stato italiano, viene applicata a casaccio a qualche sfigato, mentre la maggior parte dei clandestini continua a vivacchiare illegalmente in Italia sperando di non essere beccato, ed essendo così disposto a farsi supersfruttare da qualche caporale o padrone senza scrupoli (tra i padroni è molto facile trovare gente senza scrupoli, mentre tra i caporali i senza scrupoli sono il 100%). Questo è ciò che rende gli immigrati clandestini merce da supersfruttamento che rompe l’unità della classe e perciò bisogna combattere per regolarizzare tutti i clandestini.
Usiamo invece le nostre categorie, il nostro frame. Bisogna rivendicare la fine dell’attuale sistema discriminatorio, permettendo a tutti i lavoratori di immigrare legalmente e in piena sicurezza, garantendo loro una totale parità di diritti e doveri coi lavoratori italiani. Faccio notare che nonostante la presa della xenofobia sulla classe, l’oggetto del pregiudizio etnico e razziale è cambiato negli anni, a dimostrazione della sua radice socioeconomica. Gli immigrati degli anni Ottanta e Novanta sono ormai considerati “integrati” e si parla pochissimo di albanesi e rumeni. Qualche anno fa l’attenzione si è spostata sui clandestini (mezzo milione), e gli immigrati regolari (che sono 5 milioni) hanno iniziato a essere considerati “immigrati buoni”. Oggi ci si fissa sui profughi sui barconi. Legalizzando anche la minoranza clandestina prenderemmo tre piccioni con una fava: miglioreremmo la condizione di questi fratelli di classe, che è la cosa più importante; aiuteremmo gli altri lavoratori togliendo un elemento di divisione e concorrenza salariale interno alla classe; leveremmo dai piedi una potente argomentazione xenofoba che alimenta il razzismo di destra, cioè l’ossessione contro i clandestini e i barconi. Facciamolo!
E’ comunque utile, allo scopo, tornare al paragrafo “Il socialismo e il comunismo critico-utopistico” del Manifesto del Partito Comunista, dove si evidenzia:
1)
l’incapacita dei socialisti utopici di riconoscere l’ “attività storica autonoma dalla parte del proletariato”:
“Il proletariato esiste per essi soltanto da questo punto di vista della classe che più soffre.”
Ora, non è lo stesso oggi? Come si può non vedere nei fenomeni migratori quel che è evidente, e cioè un'”attività storica autonoma” del proletariato – e farsi abbagliare invece dalla dimensione di “tratta”, confondendo il processo storico nel suo complesso coi “modi” della migrazione, necessariamente criminali e quindi in mano ai peggiori pescecani, ma tali perché resi illegali dagli stati?
2) Il capoverso – nel Manifesto – continua: “… non vedono nessuna attività storica autonoma dalla parte del proletariato, non vedono nessun movimento politico proprio e particolare del proletariato.”
Ebbene, non è di nuovo lo stesso? Chi non riconosce l’attività storica, non riconosce neppure la possibilità di un movimento politico proprio – che nella fattispecie è un movimento proletario meticcio – ed è il movimento meticcio che con fatica – e duramente represso – tenta di nascere negli interporti, nella lotta per la casa…
Ovviamente, infine, i rossobruni non meritano il rispetto che meritavano allora gli utopisti; ma questi ci ha consegnato la storia, e questi quindi tocca contrastare.
I migliori filoni della cultura operaista hanno un merito molto importante a mio avviso,, aver rovesciato la lettura egemone a sinistra della migrazione come fenomeno indotto esclusivamente da miseria e sradicamento. Cessando di essere semplici vittime bisognose di aiuto e assistenza, pur senza negare le condizioni di sofferenza e deprivazione, i migranti diventano *soggetti* carichi di bisogni e desideri, alla ricerca di altre forme di vita e portatori di istanze di trasformazione. Le molteplici pratiche di esodo dei migranti, lungi dal determinare una rinuncia alle possibilità di lotta, configurano invece la materiale esistenza di un movimento sociale a tutto tondo, che ha contribuito a mettere in crisi la divisione internazionale del lavoro e continuamente attraversa ed eccede o confini nazionali e salariali.
caro Mauro, (mi permetto a questo punto il tono colloquiale – io mi chiamo Claudio, non mi è chiaro se questa piattaforma fa uscire il mio nome o no.)
innanzitutto grazie per l’articolata risposta. proverò a essere altrettanto articolato e giungere a una sintesi, se mi riesce.
il mio punto (in questo specifico post) sono solo i migranti irregolari, che arrivano senza permesso di soggiorno / lavoro. finiscono essi a fare il gioco del padrone? come dici in fondo al tuo post essi hanno tutte le caratteristiche di ricattabilità, indigenza, necessità che ne fanno la perfetta “carne da crumiri”; poi però sostieni che la tratta di esseri umani “non abbassa i nostri salari, neppure di poco”. ora, aumenti la forzalavoro sfruttabile, deve diminuire il costo marginale del lavoro, ANCHE SE l’esercito di riserva viene automaticamente mantenuto dal meccanismo di produzione stesso inerente al capitalismo. conitnua a sembrarmi che non si possa negare un effetto negativo sui salari. dove sto sbagliando?
tu dici che gli immigrati si distribuiscono su tutti gli strati della forzalavoro; anche questo, perdonami ma proprio non mi torna. immigrati disperati come quelli di cui sopra (ripeto: mi riferisco solo a quelli) mi sembrano quasi necessariamente finire nella terza categoria definita da Marx. un tempo era l’inurbazione dalle campagne alle città, oggi è lo spostamento da Paese a Paese. che sia la lotta di classe lo strumento precipuo per regolare i salari “lato offerta”, cioè lato lavoratori, sono d’accordo; non mi torna però che tu annulli l’effetto della regolazione dell’immigrazione “lato domanda”, cioè da parte degli imprenditori. una accurata politica di gestione dei permessi di lavoro/soggiorno avrebbe l’effetto di fare arrivare forzalavoro molto meno sfruttabile e molto più facile da immettere tranquillamente nella società, nel corso degli anni. (e l’argomento di HaJoon Chang non mi sembra per niente stupido.)
proponi di regolarizzarli tutti abolendo la distinzione regolari / irregolari e qui sono anche d’accordo, ma come? la mia soluzione è un preciso contingente di permessi e accordi bilaterali con i Paesi di provenienza dei migranti – nel mio mondo ideale, gli immigrati irregolari non esistono. tu invece sembri auspicare il permesso di soggiorno e lavoro illimitato “automatico” per chiunque giunga sul suolo europeo? non è una domanda retorica. di più: alla risposta al mio punto (c) sembri d’accordo con me che l’immigrazione illegale debba venire eliminata, e che la si elimina facendo entrare gente in maniera regolamentata. come proponi di allestire questa regolamentazione?
(in linea di massima divergo da te sui princìpi: il mio ideale non è abolire gli Stati, ma piuttosto (ri)costruire uno Stato sociale che garantisca benessere diffuso ed eguaglianza. e, en passant: hai ragione quando dici che la negazione dell’immigrazione non è l’emigrazione – era un mio errore, si tratta di due fenomeni indipendenti fra loro.)
invece per quanto riguarda la mossa salviniana di bloccare le navi delle ONG (come riconosci anche tu, quella di poco dopo era una nave militare italiana, son due cose diverse) continuo ad apprezzarla, per due motivi: (1) perché è un’azione di scoraggiamento della migrazione illegale e tende a salvare vite umane, (2) perché è un forte atto di politica estera diretto principalmente all’unione europea – finalmente in effetti il dibattito è arrivato in tutto il Continente. naturalmente, mi è anche chiarissimo l’intento elettorale del blocco navale. Matteo Salvini può non piacere ma è di un’intelligenza politica notevole, o almeno molto superiore ai suoi contemporanei (come dice Andreotti nel Divo, “io sono un nano ma non vedo giganti intorno a me”).
saluti,
Claudio Castellini
Ciao Claudio,
questo tuo ultimo commento è in larga parte inutile: stai ribadendo come articoli di fede argomentazioni fragili che ho già confutato, ignorando totalmente le mie precedenti (e, credo, ben articolate) risposte. Questo è in genere indice, in un dibattito, di non volontà di confrontarsi seriamente ed è il momento in cui conviene smettere di discutere. Infatti, così farò.
Lo stesso vale per la sviolinata al demagogo razzista Salvini, che dimostra soltanto la tua mala fede nella precedente professione di fede a sinistra.
Rispondo solo all’unica cosa nuova che domandi, ovvero «Come si fa a legalizzare l’immigrazione illegale»? Be’, mi pare chiaro: legalizzandola. Si dice che chi entra deve registrarsi da qualche parte (per esempio mettiamo degli uffici ai porti e agli aeroporti, altrimenti come si fa oggi in questura quando ci sono le sanatorie), lì gli vengono dati documenti, codice fiscale ecc. Lo stesso vale naturalmente per gli irregolari già nel territorio nazionale. Non vedo il problema tecnico.
Passo e chiudo.
Cambi il nome, egregio logorroico nazionalista. Sul TARDIS i razzisti non sono ben accetti, figuriamoci quelli che fingono di non esserlo. Quindi la smetta di coinvolgere la brava gente di Gallifrey nelle sue beghe da birreria di Monaco.
Chiudiamola qui.
Ecco cosa abbiamo scritto a quel commentatore:
«Su Giap ti è già stato concesso un elogio di Salvini, con tanto di indecente fandonia sul suo salvare vite. È già molto più di quel che normalmente tolleriamo. Come è scritto nella colonna destra, abbiamo una rigida policy antifascista. Hai moltissimi altri spazi dove scrivere propaganda sovranista e lodare il razzismo di stato, vaste praterie dove cavalcare insieme ad amici e camerati. Su Giap non scriverai mai più una riga.
P.S. Questa decisione non è di Mauro ma nostra.»
La propaganda pro-Salvini è *ovunque*, almeno qui non la lasceremo scorrazzare.
C’è un limite a tutto, e noi siamo no border, mica no limits.
A proposito della politica di Salvini e Toninelli che secondo il nostro commentatore «tende a salvare vite umane», ecco un po’ di dati forniti dall’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr).
Nel solo mese di giugno i migranti annegati o dispersi in mare sono stati 679. Come fa notare il ricercatore dell’Ispi Matteo Villa, la tragedia oggi colpisce un migrante su dieci. Prima era uno su trentadue. Il dato è triplicato.
Da quando questo governo ha deciso di giocare cinicamente con la pelle della gente, la rotta mediterranea è diventata molto più pericolosa. E prima non è che si scherzasse, con Minniti.
Qui un dettagliato articolo di Annalisa Camilli.
Che la chiusura dei porti «scoraggi l’immigrazione illegale» è del tutto infondato. Che addirittura sia fatta per «salvare vite umane» è, ribadiamolo, un’indecente fandonia. Non sono certo il primo a far notare che questa campagna in cui Salvini mostra il pugno duro e Toninelli sembra il pupazzo del ventriloquo è un’operazione esclusivamente e puramente d’immagine.
Salvini è un comunicatore limitatissimo, sa fare una cosa sola. Per ora gli funziona, ma non è detto che gli funzioni sempre. Se una nuova fase richiederà che faccia altro, si troverà in braghe di tela, perché altro non sa fare.
Nel frattempo, però, avrà causato migliaia di morti.
Il minimo (ma proprio il minimo) che possiamo fare noi è non ospitare apologie del suo operato.
@maurovanetti: davvero grazie per questo intervento (e anche la prima puntata) e per gli altri commenti. Una ottima argomentazione e un buon spunto di riflessione. Ho giá usato alcune di queste argomentazioni per smontare i soliti discorsi del tipo “io sono di sinistra ma…” e dopo il “ma” di tutto fino al supporto delle argomentazioni Salviniane.
Secondo me é davvero questa l´unica via per fermare l´onda dilagante di xenofobia: argomentazioni forti e concise che smontino una narrazione ormai divenuta “assodata” anche se basata su concetti/idee assolutamente deboli.
[…] Buona lettura, in attesa della seconda puntata… [che è stata pubblicata e potete leggere qui]. […]
[…] Mauro Vanetti, “Lotta di classe, mormorò lo spettro. Una miniserie in due puntate / 2”,… […]
Vorrei porre un quesito. Nel pezzo di Vanetti si fa riferimento (se ho ben capito) al fatto che la riduzione dei salari e degli altri diritti non é legato alla presenza o meno degli immigrati bensí alla efficacia o meno della lotta di classe.
Quindi sarebbe piú opportuno e vantaggioso includerli e portarli allo stesso livello di diritti della forza lavoro locale invece di emarginarli o addirittura respingerli.
Questo perché solo se la classe lavoratrice é compatta la lotta di classe risulta piú efficace. Altrimenti si puó facilmente vincerla usando il vecchio metodo del “divide et impera”.
Ora mi chiedo: soprattutto in un momento di globalizzazione dove é molto facile delocalizzare” la produzione quali dovrebbero essere gli strumenti per evitare che tale indebolimento della lotta di classe non venga ottenuto mettendo migranti contro locali, bensí minacciando di delocalizzare la produzione? Quindi mettendo contro lavoratori “ricchi” (o piú ricchi) contro lavoratori con meno diritti e salari piú bassi?
Indubbiamente la radice della soluzione sta nella Internazionalizzazione della lotta di classe. Ma in un mondo globale, dove é estramemente facile spostare la produzione, ottenere un fronte comune su scala mondiale credo sarebbe un processo lungo e difficile. In quel caso quali strumenti “intermedi” si potrebbero mettere in atto in modo da far fronte
al problema?
Grazie in anticipo.
@alessio
Quella che poni è una questione molto seria e di difficile soluzione. Proprio per questo, però, bisogna tracciare un quadro del fenomeno che abbiamo difronte, per renderci conto delle sue caratteristiche e della sua reale portata. Altrimenti scadiamo nei proclami elettoralistici, proponendo soluzioni poco utili per risolvere il problema, come, recentemente, ha fatto Di Maio.
Per avere un quadro del fenomeno, possiamo fare riferimento a uno studio pubblicato nel febbraio scorso dalla Cgia di Mestre, un documento di facile lettura anche per i profani.
Leggendolo ci accorgiamo – come sottolinea il coordinatote dell’ufficio studi della Cgia – che “non ci sono statistiche complete in grado di fotografare con precisione il fenomeno della delocalizzazione produttiva.”
Per esempio, non si può stabilire, e sarebbe un dato rilevante, il numero delle imprese che hanno cessato l’attività in Italia per stabilirsi all’estero.
Servendosi però dei dati forniti dall’Ice (l’agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane), gli unici disponibili, i ricercatori della Cgia sono riusciti a stabilire che le aziende italiane che hanno partecipazioni all’estero erano, nel 2015, 35.684 (nel 2009 erano 31.672), mentre, i lavoratori esteri di imprese a partecipazione italiana, sempre nel 2015 (il dato più vicino disponibile), erano 1.659.983, circa 50mila in meno rispetto al 2009.
Interessanti sono anche i dati che chiariscono quali sono le mete degli investimenti esteri delle imprese italiane. Tra le prime cinque troviamo, in ordine: Stati uniti, Francia, Romania, Spagna e Germania.
Anche un occhio disattento si rende conto che, tranne la Romania, gli investimenti sono indirizzati in paesi che hanno un costo del lavoro, e un livello di tassazione, simile a quello italiano.
In questo caso a spiegare la destinazione degli investimenti non è la volontà di creare competizione internazionale tra lavoratori, ma, probabilmente, la necessità di avvicinare le linee produttive a paesi già meta delle esportazioni delle aziende, in modo, per esempio, da minimizzare i costi di trasporto (una motivazione che non comporta necessariamente la chiusura o il depotenziamento degli stabilimenti italiani. A volte è il contrario).
Se poi andiamo a vedere nel dettaglio le imprese che investono all’estero, ci rendiamo che al primo posto, staccando nettamente le altre, ci sono aziende che praticano commercio all’ingrosso e al dettaglio (14.443 nel 2015), le quali, presumibilmente, aprono punti vendita in paesi stranieri; solo dopo troviamo le industrie manifatturiere (8242 nel 2015). Tra queste ultime, prime sono le imprese che producono macchinari e apparecchiature meccaniche (1.245), seconde le aziende metallurgiche o che producono prodotti in metallo (1.179), mentre, al terzo posto, troviamo industrie dedite alla fabbricazione di prodotti in gomma e materie plastiche (574).
Come puoi notare è un fenomeno complesso, e difficlmente quantificabile. Per esempio, una critica che si può fare allo studio della Cgia è quella di non aver evidenziato i settori che investono in un determinato paese, in modo da farsi un idea di chi investe all’estero alla ricerca di un costo del lavoro inferiore rispetto a quello italiano.
Scorgendo la lista delle prime trenta mete, ci rendiamo però anche conto che molti dei paesi dove il costo del lavoro è più basso rispetto a quello italiano sono soprattutto europei, addirittura tanti, come la Romania, sono paesi Ue.
Quindi, una prima risposta alla tua domanda su come evitare le delocalizzazioni, e impedire che si crei una competizione internazionale tra lavoratori, potrebbe essere: mediante l’introduzione di un salario minimo europeo che livelli il costo del lavoro nell’Unione, una misura che dovrebbe necessariamente essere accompagnata dal rendere uniforme la tassazione all’interno della Ue, in modo da rendere impossibile anche la delocalizzazione della sede amministrativa, cosa che recentemente ha fatto la Fca (ex Fiat), la quale, per pagare meno tasse, ha spostato la sede legale nei Paesi bassi, impoverendo l’Italia.
Ovviamente ciò non risolverebbe del tutto il problema, perché, se un’azienda trovasse più vantaggioso produrre in un paese extra Ue, dove tali norme non sono in vigore, delocalizzerebbe lì, chiudendo gli stabilimenti nel paese di origine. In questo caso potrebbe intervenire direttamente lo stato, nazionalizzando le strutture produttive che resterebbero inevitabilmente abbandonate, affidandole, per esempio, a una nuova Iri, cosa che nessuna normativa, penso neanche europea, impedisce. Anche in questo caso se la “nuova Iri” fosse continentale, e non solo italiana, la misura sarebbe più efficace.
Per disegnare un quadro più completo, è interessante anche capire se l’Italia, a sua volta, è meta di investimenti esteri. Per farlo possiamo prendere in considerazione gli Investimenti diretti esteri, cioè gli investimenti indirizzati a partecipazioni durevoli in altri paesi. I dati si trovano sulla banca dati della Banca mondiale.
Tra il 2000 e il 2017 l’Italia ha investito all’estero circa 536 miliardi di dollari, mentre gli Investimenti diretti esteri in Italia sono stati di circa 385 miliardi di dollari. Nel 2016 e nel 2017 sono stati maggiori gli investimenti durevoli fatti da imprese straniere in Italia, rispetto a quelli fatti da imprese italiane all’estero. In un certo senso, e in maniera parzialmente ridotta, quello che esce, rientra, almeno per il momento, in qualche modo.
Ma come controllare imprese che agiscono a livello globale deresponsabilizzandosi rispetto al paese in cui investono o dove hanno la propria sede operativa?
Zygmunt Bauman faceva notare che l’unica struttura che potrebbe impensierire le imprese transnazionali, è una struttura politica (e democratica) sovranazionale, in grado di imbrigliare e regolare la loro attività.
Attualmente, nel contesto in cui viviamo, l’unica classe che ha l’interesse materiale affinché tale struttura prenda vita è la classe lavoratrice, che, in tutti i suoi segmenti politici, dovrebbe cominciare a pensare di ridotarsi di un’organizzazione internazionale. Altrimenti continueremo a vivere in un arcipelago di piccoli stati assolutamente non in grado di governare l’operato di imprese che agiscono a livello globale. Esattamente quello che i neoliberisti, Friedman (quello che sperimentò le proprie teorie economiche nel Cile di Pinochet) in testa, si auguravano nei loro scritti.
Per porre fine allo strapotere delle imprese globali, o che tendono a divenire tali, è necessaria una maggiore integrazione internazionale, altrimenti l’esito di chiusure, guerre commerciali e dazi, potrebbe essere la catastrofe. Come è già successo nel 1914. Tenendo conto che il protezionismo, in un contesto come quello attuale, porterebbe solo a un ulteriore impoverimento dei paesi che lo attuano.
Forse è un percorso lungo e tortuoso, come facevi notare nel tuo commento, ma l’unica via d’uscita è l’internazionalizzazione della lotta di classe. Il capitalismo è ormai vecchio e stagnante, incapace di rinnovarsi. Gli interessi della classe che ha guidato il suo sviluppo non possono che condurre alla catastrofe. Solo se i lavoratori di tutto il mondo si unissero si potrebbe continuare a sperare. La storia ormai agisce sul piano universale, i rapporti sociali esistenti sono entrati in contraddizione con le forze produttive. Sta a noi, donne e uomini in quest’epoca, trarne le conseguenze e liberarci dal capitalismo e dal lavoro salariato. Perché una via “intermedia” per contrastare lo strapotere di imprese transnazionali è anche quella che porta all’introduzione di un reddito di base incondizionato. Finanziato anche con tasse imposte alle imprese transnazionali, ma solo una struttura sovranazionale avrebbe la forza di farlo.
In definitiva il “sovranismo” è inefficace anche nel contrastare i problemi che si (e ci) promette di risolvere. Molto più semplice superare, a livello globale, il capitalismo che tornare a chiudersi nello stato-nazione.
Molto giusta come analisi. Mi permetto di aggiungere che la manifattura italiana mediamente è di piccole dimensioni e non possiede quindi l’organizzazione per organizzare una delocalizzazione di massa, in particolare in paesi extra UE. E’ vero che magari per una piccola azienda potrebbe essere conveniente andare a produrre in Serbia ad esempio, ma a quel punto le difficoltà burocratiche sarebbero molto maggiori, senza contare che se il costo del lavoro è minore, la qualità dei servizi e delle infrastrutture è altrettanto minore. In definitiva il grosso delle delocalizzazioni avviene in paesi UE. Altra questione è poi quella delle grandi aziende e delle multinazionali che hanno tutte le capacità e le possibilità di delocalizzare e spostare interi stabilimenti all’altro capo del mondo e infatti lo fanno. Di solito però si tratta di società che sono legate in mille modi agli stati, attraverso contratti, sussidi, convenzioni e che possono inoltre avere particolari esposizione verso i mercati nazionali (ad esempio la Fiat). In questo caso un forte sindacato oltre a organizzare lotte, picchetti e occupazioni, sarebbe anche in grado di creare una pressione pubblica tale da indurre il governo ad agire quantomeno per limitare i danni. Si tratta certamente di una lotta di difesa, ma una lotta che può essere ben condotta e che può condurre a successi. Dopo tutto in Germania la disoccupazione è ai minimi, i salari crescono, ma le imprese tedesche non delocalizzano in massa. Certamente tante hanno stabilimenti in Polonia o in Romania, ma evidentemente solo una percentuale minore ha chiuso in Germania. E’ un caso che i sindacati tedeschi siano i più forti e organizzati d’Europa? Servirebbe allora un coordinamento sindacale europeo che fino ad oggi purtroppo non si riesce ancora a costruire per i soliti interessi di bottega e per il sabotaggio delle burocrazie sindacali. Qualche blando tentativo di coordinamento è riuscito solo nel campo della metalmeccanica, ma ci vuole ben altro. Dopotutto con l’UE il capitale ha organizzato la sua lotta di classe su scala continentale. E’ evidente che di fronte a un’offensiva coordinata su scala continentale una difesa nazionale è inefficace e al massimo conduce a vittorie locale. Anche i lavoratori allora devono condurre la lotta di classe su scala continentale e il lro primo strumento è il sindacato, pena il trovarsi sotto l’eterno ricatto del “allora spostiamo la produzione in Polonia”.
Il livello dei salari dipende dalla produttività. Il motivo per cui in Italia crescono poco e meno degli altri suoi pari è perché l’Italia è un paese in declino. A fronte di una minoranza di imprese avanzate soprattutto del nord c’è un resto del paese prossimo al sottosviluppo. In questo la delocalizzazione non credo c’entri molto e neanche la lotta al grande capitale. Intanto la maggior parte degli occupati italiani e stranieri, circa il 60-70%, lavora nei servizi. Questi per definizione non possono essere delocalizzati. E poi solo in pochi settori dei servizi c’è una sovrapposizione fra italiani e stranieri. Per cui, stante il declino, l’unica cosa su cui possono discutere sovranisti e no è che i salari rimarranno bassi, ma gli italiani possono tornare a fare lavori che hanno appaltato agli stranieri (edilizia, pulizie, cura degli anziani). Il settore manifatturiero fatto di imprese medie che hanno fra 50 e più di 250 dipendenti va bene, anche meglio di altri paesi, ma riguarda una minoranza di occupati. E non ha motivo di delocalizzare. Le micro-imprese, la maggior parte degli occupati, vanno male, e stanno nel campo dei servizi. Sono imprese inefficienti, di tipo familiare, che fanno evasione per sopravvivere e poco produttive. Per questo i giovani italiani se ne vanno, essendoci scarsa mobilità sociale e non vedendosi riconosciuto alcun valore al proprio talento. Con questa dinamica l’Italia tornerà lentamente ad essere un paese in cui delocalizzare al ribasso.
No, aspetta, Jackie. L’aumento dei salari non dipende dall’aumento della produttività, è una cazzata che gira ma è falsa. Tant’è che negli ultimi vent’anni la “forbice” tra produttività e salari si è allargata a dismisura a livello planetario. È una tendenza certificata – se ce ne fosse bisogno – dall’ILO, l’agenzia per il lavoro dell’ONU, che ogni anno compila il Global Wage Report. Nel periodo 1998-2013 nei paesi sviluppati la produttività media è cresciuta più del doppio rispetto al salario medio. Negli USA la produttività media oraria nell’industria è cresciuta dell’85%, mentre il salario medio è cresciuto solo del 35%. La domanda «Why is growing productivity not reflected in growing wages?» è una di quelle ricorrenti nel dibattito economico internazionale.
Nell’industria italiana proprio in anni di grande aumento della produttività (gli anni Ottanta) i salari hanno smesso di crescere, o comunque hanno subito un forte rallentamento. Sono gli anni, non a caso, in cui fu prima tagliata (1984) e poi soppressa del tutto (1992) la scala mobile.
In assenza di una lotta di classe che riduca le disuguaglianze, i benefici della crescita economica vanno molto più al capitale che al lavoro vivo. Il periodo in cui in Italia ci fu meno disuguaglianza salariale e sociale furono gli anni Settanta, appunto, anni di forte lotta di classe. Questo lo spiegano e mostrano nel modo più chiaro e plastico possibile, con dati e infografiche, i Clash City Workers nel loro importante libro Dove sono i nostri. Lavoro, classe e movimenti nell’Italia della crisi.
Un altro appunto: non è affatto vero che nei servizi non ci siano delocalizzazioni, basti vedere cos’è successo in questi anni coi call center. Che i servizi «per definizione non possano essere delocalizzati» è una frase che non capisco. Quale “definizione”?
@jackie.brown
Su quanto sia errata la correlazione tra salari e produttività ti ha già risposto Wu Ming 1, quindi sorvolo.
Mi viene però il dubbio che, con il tuo commento, ti riferissi alla teoria marginalista, secondo la quale i salari, e il livello dell’occupazione, dipendono dalla produttività marginale del lavoro, cioè dall’incremento della produzione dovuto a un’unità aggiuntiva di forza lavoro, un dato che, secondo i marginalisti, permette di misurare l’utilità per l’impresa di assumere, a un dato salario, un nuovo lavoratore rispetto a quelli già assunti. Per farla breve: i marginalisti pensavano che la domanda di lavoro da parte delle imprese cali all’aumentare dei salari e cresca al diminuire degli stessi.
Tralasciando le implicazioni filosofiche dietro questo assunto, che descrivono il lavoratore esclusivamente come un fattore produttivo, e non come un essere umano, questa prospettiva fu ribaltata dalla teoria keynesiana, e tornò in auge solo negli ultimi anni del secolo scorso, quando la teoria economica main stream accolse in toto i postulati monetaristi, che alla scuola marginalista si richiamavano.
Non la faccio lunga, se vuoi farti un’idea del dibattito tra keynesiani e marginalisti ti consiglio di leggere questo articolo, dove la questione è esposta in maniera abbastanza comprensibile.
Se lo leggerai, poco prima delle conclusioni troverai scritto che i salari reali sono influenzati da diverse variabili, “in particolare dalla forza dei sindacati e il grado di concorrenza nel mercato dei beni.”
Hai letto bene: i salari sono influenzati “in particolare dalla forza dei sindacati”, cioè dalla lotta di classe che i lavoratori riescono a mettere in campo e dalla loro forza contrattuale. Questa è la visione marxiana dell’andamento dei salari, accettata da molti di quelli che bazzicano su questo blog. Penso te ne sarai accorta.
Fino a oggi, nonostante la propaganda, nessuno è riuscito a dimostrare che questo assunto sia errato. E a questo, io, ma anche molti altri più bravi di me, continuiamo a fare riferimento.
Questa parte del tuo commento, però, non è l’unica che mi ha colpito. Mi ha molto colpito, per esempio, che consideri come una peculiarità italiana il fatto che la maggior parte degli occupati lavori nei servizi.
In realtà questo è un trend che riguarda tutti i paesi, industrializzati, e di “recente” industrializzazione, dalla fine negli anni Settanta. Non è una caratteristica italiana, ma dell’economia globale.
In un recente libro di Tommaso Detti e Giovanni Gozzini, “L’età del disordine” (Laterza, 2018), leggiamo per esempio:
“Nelle economie dei paesi ricchi (America del Nord, Europa, Giappone) la deindustrializzazione fu compensata dallo sviluppo del terziario: gli addetti a questo settore, che nel 1960 coprivano poco meno di un terzo della forza lavoro, nel 2010 arrivavano al 70%. In cifre assolute dal 1980 al 2010 ciò corrispose a un aumento di 131 milioni di posti di lavoro, che compensò il declino dell’agricoltura e dell’industria (-31 e -62 milioni). Fin dai primi anni Settanta questo mutamento venne avvertito dalle scienze sociali” (pg.30)
Mentre, riferendosi ai paesi di “recente” industrializzazione, scrivono:
“È molto significativo, però, che le aree a basso reddito (Asia senza Giappone, Africa e America Latina) fossero interessate a tendenze analoghe, mettendo in mostra una precoce e accelerata terziarizzazione. Dal 1980 al 2010, infatti, i posti di lavoro nei servizi vi crebbero in misura ancora maggiore (+576 milioni). […]
Nei paesi ricchi la transizione dall’economia industriale a quella post-industriale aveva impiegato più di un secolo per compiersi del tutto. In quelli a basso reddito degli ultimi decenni, invece, la transizione avveniva quasi sincronicamente: manifattura e servizi crescevano insieme.” (pg. 30 e 31)
Come vedi quello della terziarizzazione dell’economia è un fenomeno che riguarda tutti i continenti, e non soltanto il nostro paese.
Certamente non è quella la causa del declino italiano.
Dai un dato inesatto anche quando sostieni che le “micro-imprese” danno lavoro alla maggior parte degli occupati.
Se facciamo riferimento ai dati Istat relativi al 2016, possiamo osservare che, a quella data, in Italia c’erano 4.180.870 imprese con meno di dieci dipendenti, queste, sempre in quell’anno, davano lavoro a circa 7milioni e mezzo di persone. Meno di due addetti per impresa. Sono imprese soprattutto familiari, che occupano il titolare e magari la moglie e i figli. Sono soprattutto liberi professionisti, commercianti o attività ristorative e alberghiere a conduzione familiare.
Sono economicamente significative, ma non possiamo sostenere che siano l’ossatura dell’economia italiana.
La maggior parte degli individui, più di 9 milioni, nel 2016, lavorava in aziende piccole, medie e grandi, con più di dieci dipendenti, con specializzazioni produttive diverse.
Per esempio, in Italia, sempre nel 2016, si contano 184.098 aziende che hanno tra i 10 e i 50 dipendenti. Quasi un terzo di queste, 58.118, è dedita ad attività manifatturiere, e dà lavoro a oltre un milione di persone. All’interno del settore manifatturiero questo tipo di imprese ha, in totale, più addetti rispetto a quelle che contano tra i 50 e i 249 dipendenti, e a quelle che hanno oltre 250 dipendenti.
Tu definisci le imprese manifatturiere la parte “sana” della nostra economia e al contempo hai paura che il nostro paese diventi meta di delocalizzazione. Non ti rendi però conto che l’Italia è già dagli anni Novanta meta di delocalizzazione, sia per il basso costo del lavoro, sia per le elevate competenze che si possono trovare. E sono proprio queste piccole e medie aziende manifatturiere quelle nelle quali molte imprese transnazionali delocalizzano la produzione, poiché queste aziende indirizzano la propria attività alla produzione di un singolo componente di un prodotto più complesso, che, spesso, viene assemblato in altri paesi.
Una rete di imprese, fortemente specializzate, che è anche cresciuta a livello di singole unità, internazionalizzandosi a sua volta, nonostante le ridotte dimensioni. Per questo tipo di imprese è stato coniato il nome di “multinazionali tascabili”.
Come puoi leggere nei dati che ho citato nel precedente commento, sono soprattutto le imprese manifatturiere che investono all’estero, seconde solo alle imprese dedite al commercio, e non di rado delocalizzano, chiudendo l’attività in Italia, in cerca di salari più bassi, soprattutto in paesi europei (in prevalenza della Ue) dove possono trovare elevate competenze e un costo del lavoro risibile. Non è affatto vero che le imprese manifatturiere non hanno la necessità di delocalizzare, come non è vero, come ti faceva notare Wu Ming 1, che i servizi non possono essere delocalizzati.
Chiudo con due parole sul declino. L’Italia è un paese in declino non per la sua struttura produttiva, né per l’elevato costo del lavoro, che, come sostieni anche tu, è alquanto basso e spinge molti italiani, complice l’assenza di politiche occupazionali degne di questo nome, a emigrare.
L’Italia è un paese in declino perché da anni manca una politica industriale seria e, contemporaneamente, sono state svendute a società estere le imprese che potevano competere a livello globale. Società estere che, spesso, le hanno svuotate di competenze e idee per poi chiuderle. Queste imprese, fino agli anni ’90, erano in grossa parte pubbliche e furono privatizzate. Una scelta che, per esempio, Francia e Germania non hanno fatto, o la hanno attuata in maniera diversa rispetto a quella italiana.
Perché il governo italiano ha svenduto i “gioielli di famiglia” e non ha investito in settori come l’informatica, dove vantava aziende all’avanguardia come la Olivetti?
Colpa (anche) di Soros, il quale, almeno per questa volta, non viene citato a cazzo, ma gli vengono attribuite le sue reali responsabilità, cioè l’attacco valutario che condusse contro la lira, e contro la sterlina, che portò l’Italia e la Gran Bretagna a ridimensionare drasticamente le proprie riserve monetarie e auree per contrastarlo e, negli anni successivi, costrinse i governi di quei paesi a varare finanziarie di lacrime e sangue, spinti soprattutto dalla necessità di fare cassa.
Pochi oggi lo sottolineano, ma l’agire di Soros, spesso considerato un alfiere della globalizzazione e della moneta unica europea (cosa della quale spesso anche lui si vanta, basta leggere il suo libro “Salviamo l’Europa” [Hoepli, 2014]), in realtà mise a serio rischio l’introduzione dell’euro, spingendo la Gran Bretagna, che già era dubbiosa, a non aderire, e costringendo l’Italia a enormi sacrifici pur di far parte dei primi paesi nei quali veniva introdotta la moneta unica.
Noi non sappiamo se Soros fosse mosso esclusivamente da avidità personale, o se il suo operato faceva parte di un disegno più ampio. La cosa che sappiamo con certezza è che gli Stati uniti, fin da quando si parlò per la prima volta di una moneta unica europea, fecero di tutto per contrastarla, nonostante nessun governo europeo pensasse, neanche lontanamente, di minacciare i loro interessi. Una bella ricostruzione di quanto avvenne è possibile leggerla in questo articolo di Duccio Basosi, ricercatore all’Università di Venezia.
Ovviamente sarebbe da sciocchi attribuire tutte le sofferenze italiane all’operato di Soros, anche perché ciò porterebbe a trascurare, quando invece è rilevante, il fatto che in Italia le teorie neoliberiste si diffusero, ed ebbero presa sulla classe politica, in maniera maggiore rispetto ad altri paesi europei come Francia e Germania. E sta proprio nell’accettazione di quelle idee la mancanza di una politica industriale e di politiche volte a raggiungere la piena occupazione, entrambe cose che i neoliberisti non contemplano, poiché il loro unico obiettivo è massimizzare i profitti privati. Per questo non condivido quando affermi che il grande, e il piccolo, capitale non hanno responsabilità.
La chiudo qui, già mi sono dilungato troppo, anche se per tracciare un quadro completo sarebbe necessario fare riferimento al modello produttivo che si afferma dagli anni Settanta, al perché è soprattutto in esso che si trova la ragione della precarizzazione del lavoro, alle ragioni che portarono le aziende ad adottarlo, a come si sono modificate, a livello globale, le classi sociali, anche a causa della sua introduzione, e a molto altro. Perché solo così si può rendere la complessità della situazione italiana, dato che, negare le complessità e banalizzare, è da fascisti, come ci insegnava Umberto Eco.
Però non è questo il luogo, che già siamo nettamente OT.
Basti sapere che Hobsbawm, il quale sulle ragioni dell’introduzione di quel modello produttivo ci aveva capito poco (e trascurava qualche fonte), per parlare di esso, faceva, probabilmente a ragione, riferimento all’impresa italiana Benetton, e non alla Toyota, azienda all’interno della quale era stato ideato; e che quel modello produttivo fu introdotto anche, ma non solo (altrimenti si farebbe lo stesso errore di Tronti, del quale già Primo Moroni probabilmente si era accorto), per indebolire la lotta di classe, ridurre l’occupazione necessaria e rendere ricattabili i lavoratori.
Siamo in una fase in cui il capitalismo stesso ha al suo interno gli strumenti che ne permettono il superamento, l’organizzazione contemporanea della produzione è uno di essi. E la situazione italiana, economica e politica, è emblematica di questa possibilità.
Forse è per questo che le classi dominanti fanno di tutto per istillarci nostalgia del passato, perché, se invece che voltare la testa guardassimo in avanti, pensando a come attuare la lotta di classe nella nostra epoca, a come fare in modo che divenga lotta globale, scorgeremmo un mondo dove quelle classi non dominano affatto, un mondo dove si vive molto meglio che in quello attuale.
Grazie a tutti per le analisi ed i link molto interessanti. Soprattutto mi ha colpito che dallo studio presentato da Punco le delocalizzazioni dall´Italia avvengano in maggioranza verso paesi con un costo del lavoro uguale se non maggiore.
D´altra parte come faceva notare Vincenzo in Germania delocalizzano poco a fronte di un costo del lavoro alto e vivendo in Germania ho ben presente il potere dei Sindacati qui.
Comunque una bella discussione. Molto materiale su cui riflettere.
Saluti :)
***Questo commento è stato prodotto in uno stabilimento che fa uso di falsa coscienza. Agitare prima dell’uso. MPS approved (Δ)***
Parlando di produttività e di livello dei salari non ho inteso eslcudere qualsiasi altro fattore (né ovviamente escludere prescrittivamente la lotta di classe), ma porre quello che credo principale e ancora valido, anche se non vi è una corrispondenza esattamente proporzionale tra crescita della produttività e crescita dei salari. La mia convinzione non deriva solo da un insieme di letture e ascolti. Grazie per il link (non mi riferivo alla teoria marginalista): ho letto il passaggio citato, ma poco prima c’è anche scritto che per Keynes l’ideale è far crescere i salari con la produttività. La produttività si può raggiungere in vari modi, senza dogmi. Poi si può “star bene” pure con una produttività mediamente minore rispetto ai paesi più sviluppati. Negli anni del boom c’era appunto crescita, per cui le lotte influivano sulla quantità relativa del salario. Ma era la crescita economica a generare la quantità assoluta di ricavi da redistribuire. E insieme al contesto di crescita, in base al lavoro che fai generi più o meno valore. Si è detto della Germania, che negli anni ’10 ha tenuto un po’ più bassi i salari rispetto alla produttività, per essere più competitiva e per calmierare l’inflazione; negli ultimi anni ci sono stati accordi per aumentarli, oltre alla possibilità di lavorare meno ore. Ma in ogni caso parliamo di oscillazioni percentuali in una fase di crescita. Nei paesi emergenti dell’Europa dell’est i salari crescono a doppia cifra, partendo da un livello nettamente inferiore. Non credo che l’Italia, il paese che fa peggio in Europa, stia solo cercando di essere competitiva abbassando i salari (questo può avvenire nel settore dell’export). In Germania hanno tenuto relativamente bassi l’aumento dei salari mentre cresceva la produttività, per cui c’era margine per poi alzarli. In Italia questo margine non credo ci sia, e i dati sulla produttività questo dicono. Quello che si dice è che avendo l’Italia perso il treno per competere al rialzo, non rimane che competere al ribasso. Queste ultime sono riflessioni che faccio in base soprattutto a quello che leggo, le metto in discussione senza problemi.
Sulla occupazione nei servizi. Non ne ho parlato per dire che sia una peculiarità italiana, ma perché i vari commenti e la domanda di partenza si concentravano sulla delocalizzazione come arma per tenere bassi i salari. Mi è venuta in mente perché poco prima avevo proprio ascoltato un dialogo tra Boldrin (ALERT) e Manfredi su youtube a propositò di imprese e produttività. Lì ho preso il dato sulla percentuale di occupati nelle micro-i, che percentualmente dovrebbero essere in numero maggiore che negli altri paesi avanzati. Mentre quello generale sui lavoratori italiani e stranieri nei servizi l’ho cercato personalmente. Né appunto l’ho citata come causa del declino italiano. Ma per dire che essendo il grosso dei salari non viene influenzata né dalle strategie del capitale né dagli immigrati. Anche se naturalmente c’è una parte di questa fetta (come dell’altra parte degli occupati) che viene influenzata da quest’altri fattori. Ma la competizione al ribasso con i lavoratori degli altri paesi e con gli immigrati è un effetto del declino. E in generale non mi sembra neanche una cosa sbagliata in sé, che i salari a livello globale si avvicinino. E forse si può conciliare una povertà relativa con un’occupazione più diffusa. Quando parlavo di paese che tornerà ad essere territorio di delocalizzazione al ribasso non stavo esprimendo paura, quanto una “previsione” più o meno oggettiva. Più l’Italia declina più l’unico fattore vantaggioso per le imprese estere sarà quello del costo del lavoro, che ha come conseguenza un certo livello di salari. Mentre altri paesi che emergeranno metteranno a disposizione un sistema migliore per fare impresa. Non credo di aver espresso argomenti per spiegare il declino, l’ho messo come fatto in sé. Ho legato a questo i salari, ma non mi sono spinto a dare una spiegazione del declino, sebbene abbia dato credito al discorso sul tessuto improduttivo delle micro-i, tesi di una visione intellettuale basata sulla mancanza di competizione e su un mercato disfunzionale perché legato a vecchi schemi. Ma è la stessa parte intellettuale che sostiene che negli anni post-boom le elite industriali e la classe dirigente non abbiano affrontato il cambio tecnologico con adeguata riforma amministrativa, e con esse il paese nell’insieme. Se siamo in disaccordo (o meglio, io forse ho preferenze a priori, ma senza fondamento razionale) tra un’idea di politica industriale a intervento statale (o collettivistica) e no (o su un mix con percentuali variabili), mi resta difficile pensare al declino italiano in termini di accettazione del liberismo. Questo può spiegare maggiori o minori disuguaglianze interne e qualità delle condizioni di lavoro, ma non mi convince molto sul perché dovrebbe spiegare il declino di un paese rispetto ad altri che non credo abbiano politiche socialiste, quanto semmai diversamente liberiste (forse abbiamo un mix di cattive politiche stataliste e liberiste: tassazione e spesa pubblica alte e irrazionali, inefficienti; regolamentazioni, mercato del lavoro bloccato da una parte e ingiusto dall’altra). Anche qui si può dire che un sistema globale basato sulla competizione sfrenata fra paesi produce per forza di cose vincitori e sconfitti. Ma non credo sia tutto, ammesso sia vero nel caso in questione. Mi sembra un po’ come la spiegazione del declino che fa riferimento all’entrata nell’euro. Su questo ho trovato corrispondenze sia in Zingales che in Cesaratto, due economisti credo distanti, che pur ravvisando problemi tanto nell’entrata quanto nella mancata uscita (concordata), rilevano le difficoltà enormi che comunque rimarrebbero.
Per quanto riguarda delocalizzazioni e servizi, è vero, ho trascurato i call-center. Ma i servizi sono servizi alle persone. Per definizione intendevo questo.
Un commento di Carlo Freccero sul manifesto del 12 giugno scorso sembrava scritto sotto le stesse influenze che sospingono Diego sempre più a destra.
Eccolo: https://ilmanifesto.it/se-le-elites-sono-economiche-e-non-culturali/
Gli snodi chiave in cui il suo ragionamento si dieghizza sono due e meritano di essere studiati con una certa attenzione.
1. Questo è il primo (anche se compare dopo, nel testo, mi sembra che logicamente venga prima): «La svalutazione del lavoro in questi anni di ordoliberalismo e di euro, è stata possibile solo grazie all’esercito di riserva costituito dai migranti. È logico che le élites economiche siano favorevoli all’immigrazione».
Ma davvero? L’unica ragione, o perlomeno quella decisiva, della «svalutazione del lavoro» è stata la presenza di disoccupati immigrati? Oppure, supponendo che Freccero usi «esercito di riserva» senza ben sapere cosa significhi, è più in generale dovuta essenzialmente ai lavoratori immigrati? Questo è del tutto contrario all’esperienza comune, oltre che a quanto ci mostrano le statistiche.
Partiamo dalle statistiche: la svalutazione del lavoro secondo Ferrero immagino significhi, in concreto, la riduzione della quota salari nella distribuzione della ricchezza prodotta a livello nazionale. Questo fenomeno è comune a tutti o quasi i Paesi OCSE, che hanno visto un picco della quota salari intorno a metà degli anni Settanta o a inizio degli anni Ottanta, al termine di un importante ciclo di lotta di classe, e da allora un declino con qualche oscillazione. Qua c’è uno studio OCSE con dati su molti Paesi e in particolare tre bei grafici a pag. 15 che riguardano la Francia, il Regno Unito e gli USA: https://www.oecd.org/g20/topics/employment-and-social-policy/The-Labour-Share-in-G20-Economies.pdf
L’euro c’entra poco ma l’immigrazione non c’entra proprio nulla: il trend è lo stesso in Paesi di antica immigrazione o recente, di alta o bassa immigrazione, dentro o fuori dall’Eurozona. Qui si trova un grafico con l’andamento per alcuni Paesi: http://www.economiaepolitica.it/il-pensiero-economico/quota-salari-e-regime-di-accumulazione-in-italia/
Nel nostro Paese il proletariato ha perso terreno in anni in cui l’immigrazione era minima. In Italia, addirittura, negli ultimi anni la quota salari, secondo alcune serie statistiche, sarebbe un po’ risalita. La faccenda è controversa perché per esempio la commissione consultiva dei sindacati all’OCSE dice che questo è dovuto alla crescita della precarietà che falsa i dati e ad altri fattori: https://medium.com/workers-voice-oecd/new-oecd-working-paper-reports-on-declining-labour-share-and-increasing-wage-inequality-1e9b1fe8ec9f Ad ogni modo, se c’è qualche correlazione non è affatto con la crescita del numero di immigrati bensì con l’aumentare della distanza dalle grandi lotte sindacali e politiche iniziate con l’Autunno Caldo e finite con la sconfitta del movimento operaio (sconfitta provvisoria, dico io).
Ma anche l’esperienza quotidiana ci dice qualcosa a questo proposito. Esistono settori dell’economia italiana dove gli stranieri sono pochissimi. In generale, nei lavori di ufficio di tipo impiegatizio o tecnico gli immigrati non sono numerosi; tra il personale scolastico, sono quasi assenti; anche nel precariato cognitivo di età medio-bassa quanti immigrati ci sono? qualcuno c’è ma non c’è paragone col numero di lavoratori stranieri che sono impiegati nelle fabbriche, nei cantieri, nella distribuzione grande e piccola, nei magazzini ecc. In quei settori più «bianchi» la classe dei lavoratori salariati se l’è cavata meglio? Diremmo proprio di no.
Addirittura, c’è chi ha provato a scomporre la caduta della quota salari tra industria e terziario. In genere in Europa in fabbrica (dove ci sono molti più immigrati) si è riusciti a tenere botta meglio che nel settore dei servizi, a cui è dovuta la gran parte dell’avanzata percentuale del profitto e della rendita. Guardate pag. 9 di questo paper (ma dati simili si trovano ovunque): http://bruegel.org/wp-content/uploads/2017/04/PC-12-2017-1.pdf
2. Passiamo alla seconda affermazione diegheggiante chiave di Freccero: «Ma i migranti non sono il nuovo proletariato perché la loro coscienza identitaria non è qui ma altrove».
Sorvoliamo sul fatto che «coscienza identitaria» è un’espressione vuota o circolare. La coscienza identitaria è la propria identità cosciente, cioè la propria coscienza cosciente o la propria identità identitaria. Se le parole di Freccero hanno un senso (e talvolta la mia convinzione al proposito vacilla), la coscienza identitaria di qualcuno è ciò che quel qualcuno pensa di essere. Freccero sostiene quindi che i migranti non sono il nuovo proletariato perché non pensano di essere «qui», non pensano di essere «dei nostri», si sentono invece «altrove», «estranei».
Dissento innanzi tutto sulla veridicità di questa affermazione: gli immigrati di lungo periodo in larghissima misura si sentono, almeno in larga parte, dei nostri. Si sentono, in un senso non necessariamente etnico o nazionale ma perlomeno, per così dire, “territoriale”, italiani. Vivono qui, parlano (anche) italiano e sono parte delle nostre comunità. I loro bambini si sentono italiani o culturalmente meticci. Se per Freccero ciò che conta è la loro autorappresentazione, come pare credere, potrebbe anche parlare con queste persone e scoprirlo.
A prescindere da questo, il punto è però anche capire quanto ciò abbia a che vedere con essere o meno il «nuovo proletariato». Io, en passant, non credo che i migranti siano il nuovo proletariato: sono semmai un apporto (minoritario ma importante) al buon vecchio proletariato pre-esistente. Ma questo c’entra con il fatto che si sentano italiani o comunque parte di una comunità nazionale? Secondo me no.
Cosa avrà mai voluto dire Marx sostenendo come caratteristica precipua del proletario il fatto che «non ha patria»? Precisamente questo: che è la classe nella storia umana maggiormente disconnessa dal radicamento in comunità nazionale separate. Ovviamente ciò non vale in senso assoluto ma la miscela etnica e la crescente irrilevanza delle appartenenze nazionali è un dato di fatto che balza agli occhi di chiunque osservi masse proletarie al lavoro o alla lotta o anche banalmente dedite a fare la spesa, a prendere i figli da scuola o a portarli al parchetto o a fare il bagno in spiaggia (ormai in Occidente i proletari sono la maggioranza della popolazione, se vai in giro e guardi la gente quello che vedi è in grande misura proletariato). Le differenze culturali ed etniche che naturalmente un po’ persistono sono sempre più scavalcate da comuni stili di vita, comune sfruttamento sul lavoro, simili condizioni salariali.
Secondo Marx (e, umilmente, secondo me) questo è un fattore rivoluzionario, non reazionario. Facilita infatti la costruzione, diranno gli epigoni ma restando fedeli al pensiero marxiano, di una coscienza di classe, di un’identità di classe. La classe-in-sé diventa più facilmente classe-per-sé nella misura in cui non si percepisce come popolo o nazione bensì come classe lavoratrice. Questo concetto in Italia suona piuttosto ideologico per motivi in parte lessicali e in parte politici, ma per esempio nei Paesi anglofoni dirsi «working-class people» è banale per milioni di persone e spesso motivo di orgoglio.
L’identità nazionale entra in genere in concorrenza con l’identità di classe. L’intreccio può avere molti esiti, che dipendono anche dalla storia di ogni specifica nazione. Presso le nazioni oppresse da un imperialismo oppure presso quelle frammentate in molte sottonazioni artificiali (Patria Grande latinoamericana, sovranazione araba) la coscienza nazionale può giocare un ruolo progressista e in genere i marxisti hanno difeso questa forma di coscienza nazionale o cercato di farci leva, seppure problematizzando molto la questione. Sempre e comunque, tuttavia, c’è un elemento di interclassismo nell’identità nazionale che va combattuto se si ha a cuore coltivare la lotta di classe.
Da questo punto di vista, lo sviluppo di una coscienza di classe negli immigrati stranieri può essere facilitato dalle loro variegate non-appartenenze alla concezione standard, ufficiale, di cosa sia un italiano purosangue. Il loro processo di integrazione può prendere molte forme e una di quelle auspicabili è che passi dal riconoscimento di una comunanza di interessi di classe sia con lavoratori stranieri di altre nazionalità sia con il proletariato della nazionalità maggioritaria. Come ho cercato di raccontare con alcuni esempi, pochissimi scelti tra le centinaia che si potrebbero fare, questo sta già succedendo.
Quello semmai di cui dovremmo preoccuparci è l’uso strumentale delle differenze nazionali che viene fatto dal padronato. Mi sovviene l’esempio di una fabbrica di scatole (sic) della mia zona dove i lavoratori sono divisi lungo due crinali sovrapposti e coincidenti: di qua i lavoratori assunti dalla ditta, italiani, di là i lavoratori della cooperativa, straniera. Naturalmente lavorano fianco a fianco con mansioni spesso analoghe, anche se gli italiani assunti dominano totalmente alcune mansioni molto qualificate (stiamo parlando sempre di operai, gli impiegati sono pochissimi).
Non è il solito caso del facchinaggio lasciato agli stranieri, dove spesso capita che proprio i facchini siano i più combattivi: qua avviene il contrario, l’avanguardia è rappresentata da italiani sindacalizzati. La divisione tra questi due gruppi è la gallina dalle uova d’oro per il padrone della fabbrica e per il presidente-padrone della cooperativa, infatti ogni tentativo di fraternizzazione è punito (ho in mente una storia tremenda di richiami fatti a un’operaia che aveva invitato in mensa a una festa di compleanno i colleghi della cooperativa). Ma possiamo dire che la ragione profonda di questa divisione sia etnica? Sarebbe ridicolo. Ovviamente è di tipo sociale, e usa le nazionalità come strumento per ingannare i lavoratori meno coscienti.
Ora mi domando: se a chi organizza quegli operai interessa la prassi e non delle analisi accademiche, qual è la via maestra? La «coscienza identitaria» degli italiani? Direi proprio di no: i lavoratori che fremono di ardore patriottico sono probabilmente quelli che ci daranno più problemi. Ma in generale neppure assimilare gli stranieri della cooperativa nelle tradizioni italiane mi sembra prioritario. Avvicineremmo forse quei lavoratori chiedendogli se festeggiano anche loro il Natale o facendogli un test di ortografia italiana? Evidentemente la prima leva da agguantare sarebbe la comune condizione di classe, il fatto di avere di fronte lo stesso nemico bifronte. Quei lavoratori si sentiranno «altrove» rispetto a questo problema concreto? Penseranno alle tradizioni del Perù o del Senegal o dell’Albania? Ne dubito fortemente. Penseranno alle scatole che fanno, al salario che (non) prendono, ai licenziamenti, alle punizioni, ai soprusi. Davvero è tanto difficile capire e spiegare queste cose?
Tuttavia, un problema serio lo vedo, che non può spingerci a un eccesso di ottimismo sul fatto che la mescolanza sui posti di lavoro risolva da sola questi problemi. Il problema che vedo è la segregazione. Laddove il padronato riesce a segregare su base nazionale i lavoratori, così rafforzando proprio il senso di «coscienza identitaria» che sembra affascinare Freccero, approfondire il divario e quindi metterci gli uni contro gli altri diventa un rischio maggiore. Questo è lo stesso sistema con cui, nonostante l’evidente mescolanza tra i sessi esistente nella società, il capitalismo è riuscito a mantenere anche in Occidente un importante gap salariale a svantaggio delle lavoratrici. Nell’Unione Europea 4/5 dei posti di lavoro sono definiti come segregati, ovvero hanno meno del 40% di uomini o meno del 40% di donne, a volte molto molto meno. In questo modo ci sono (semplifico) “lavori da uomo” e “lavori da donna” che possono essere pagati in modo parecchio diverso, mettendo gli uni contro gli altri e peggiorando le condizioni di tutti.
La segregazione etnica è altrettanto perniciosa. Se si creano i lavori da cinesi, i lavori da ucraini, i lavori da rumeni, i lavori da bianchi, i lavori da neri… può diventare un problema in più da risolvere. Nella logistica esiste tantissimo questa cosa, con cooperative specializzate nel reclutamento di lavoratori di una certa nazionalità. Anche i caporali a volte formano squadre etnicamente omogenee di braccianti. Il fatto che gli sfruttatori fomentino sistemi per rafforzare l’identità nazionale dovrebbe far riflettere molto chi vede ovunque complotti del grande capitale per ribassare i salari. Chi fa tante manfrine identitarie è strumento di una vasta cospirazione antioperaia che farebbe impallidire anche il sordido Soros.
A modestissima integrazione del generoso commento di Mauro, vorrei ricordare un paio di cose a proposito del «diritto a non essere sradicati dalle loro usanze» che spetterebbe agli «abitanti dei quartieri più poveri in Europa» e che secondo Freccero sarebbe minacciato da «un’immigrazione culturalmente eterogenea»:
1) quegli abitanti sono già culturalmente eterogenei, in quanto frutto di generazioni di rimescolamenti, migrazioni interne e continentali, inurbamenti. Nelle periferie tedesche, i turchi di terza generazione cosa sarebbero, nella fantasia identitaria di Freccero? Autori di minaccia e sradicamento o minacciati da minaccia e sradicamento? E i meridionali in nord Italia, fino a ieri oggetti d’odio dei leghisti (oggi in stand by, domani chissà…), a quale stadio della coscienza identitaria frecceriana saranno ammessi a fare appello?
2) Alla luce dell’incontestabile punto 1, chiunque abbia minima contezza di ciò che sono i «quartieri più poveri d’Europa», sa bene che essi sono davvero sotto minaccia. Sotto minaccia della riduzione drastica, svendita e non-reintegrazione degli stock di edilizia popolare pubblica; dei tagli ai servizi di trasporto e di sanità e scolastici. Minaccia che colpisce
ndo cojo cojo, senza grande rispetto (spiace per Freccero) delle varie coscienze identitarie, qualsiasi cosa esse siano.
3) I più «fortunati» dei quartieri poveri sono poi minacciati anche dalla gentrificazione. I più poveri sono espulsi, le loro «usanze» per nulla identitarie ma reali, quotidiane, le loro consuetudini – tutte sono stravolte. I loro bar (spesso e volentieri multiculturali per frequentazione, e disperati per mood) sono chiusi da autorità antidegrado o per aumento del canone di affitto; i loro negozi, che alcuni chiamano «etnici» forse per via delle spezie ma in realtà sono semplicemente «di quartiere», sono spazzati via dai brand e dai supermercati, eccetera eccetera.
Nei quartieri sotto attacco da gentrificazione avviene la sola e vera «sostituzione di popoli» che esista sotto il cielo. Un popolo (già oggi) meticcio e multiculturale, a basso reddito, viene sostituito da un popolo di affluenti, ricco e monoculturale, devoto alla sola e unica religione aziendalista. Ma la gentrificazione è assente dalle riflessioni identitarie, perché nessuna analisi la afferra se si chiudono gli occhi davanti alla più evidente, quella di classe.
Che ne pensate della proposta di legge di iniziativa popolare, presentata il 27 ottobre dello scorso anno, a conclusione della campagna “Ero straniero – L’ umanità che fa bene” ?
Link della sintesi: https://www.radicali.it/wp-content/uploads/2017/05/erostranierointSINTESIok.pdf
Ps su Diego: o lui è un gran furbo, e bravo, che ha trovato uno spazio libero per vendere la sua aria fritta, oppure è una specie di Keiser Söze al contrario, cioè che finge di essere sveglio ma è uno scemo
Nella prima puntata, i socialisti Sigfried Mayer e August Vogt [1] sono chiamati Siegfried e Karl Vogt. Il primo è una svista, il secondo è un’altra persona: Herr Vogt!
La vignetta “A King of -Shanty” [2] è titolata invece “A King A’Shantee”.
[1] https://www.marxists.org/italiano/marx-engels/1870/vogt.htm (IT) e https://www.marxists.org/archive/marx/works/1870/letters/70_04_09.htm (EN, anche Sigfrid)
[2] https://flashbak.com/the-simian-negroid-irish-depicted-in-english-and-american-cartoons-12727/
Grazie, pare comunque che nessuno dei due titoli della vignetta sia quello giusto, la Library of Congress riporta la pagina con didascalia originale ed è: «The king of a-shantee». Cambiamo subito Sigfried e il nome di battesimo di Vogt.
Segnalo che ieri sera,presso una cittadina siciliana, il “cantante” Povia ha sciorinato il suo campionario di complottismo e allarmismo sobillando l’uditorio con proclami qualunquisti corredati da immagini, video e quant’altro. Tra il materiale utilizzato c’era anche uno stralcio, debitamente mutilato e decontestualizzato, della Lettera indirizzata a Vogt. Il tutto è stato condito da richiami passatisti ai “bei tempi andati” della dominazione borbonica con rilancio populista sul tema dell’Unità d’Italia predatoria. Il cosiddetto cantante ha furbescamente premesso che non è contro gli immigrati in se, proseguendo tuttavia sulla falsariga dell’invasione e della visione inferiorizzante dei migranti come schiavi e non come persone. E’ stata una serata surreale aggravata dal “consensus omnium” plebiscitario dei presenti. Mi ha colpito l’utilizzo strumentale della Lettera suddetta il cui contenuto e ispirazione conoscevo da tempo e che mai avrei creduto di vedere utilizzata a sostegno di discorsi sovranisti di questo genere.
Salve a tutti, leggo Giap da tempo ma non avevo ancora avuto occasione di intervenire nei dibattiti. In realtà volevo segnalare qualcosa che ha a che vedere con la mistificazione del Marxismo da parte dei rossobruni, trattata nel bellissimo racconto in due parti. Mi sono recentemente scontrato su una pagina di divulgazione scientifica su Facebook con un figuro che si presenta come “naturalista” (ovviamente blog-munito) che propugna un’interpretazione assurda ed agghiacciante del fenomeno delle migrazioni umane in un’ottica biogeografica “hardcore”. Io sono paleoantropologo e ingenuamente ho tentato di contrapporre dati ed argomenti, scontrandomi con un muro di mistificazione e ignoranza tout-court della materia. Il succo dei suoi deliri si riassume in due punti:
1- le migrazioni di popoli africani verso l’europa sono assimilabili al comportamento di specie invasive (totalmente errato anche da un punto di vista meramente naturalistico);
2 – I principali mistificatori e danneggiatori delle teorie di Darwin sarebbero fantomatici “no-border di sinistra” che propugnano il darwinismo sociale attraverso la concorrenza sleale voluta a danno dei lavoratori europei (o italiani, non è chiaro questo) da parte dei migranti.
Sarebbe difficile riassumere e discutere gli artifici retorici, lo stravolgimento della realtà e le assurdità scientifiche incastrate a forza in un disegno delirante da costui (non so se sia solo o parte di una corrente di “naturalisti” analoga). Personaggio del quale non c’è traccia, comunque, su research gate, per dire un network di ricercatori, nonostante si definisca “biologo”.
Questo per dire che oltre a Marx si tenta di mistificare Darwin e la genetica, due sostegni scientifici, che lo si voglia o meno, alla scientificamente innegabile uguaglianza fra i popoli. Qualcuno ha avuto disavventure analoghe nel campo? Lo chiedo solo per capire la dimensione del fenomeno.
Ho sentito più di una volta giustificare la xenofobia e/o il razzismo come misure per preservare la biodiversità umana!
Purtroppo l’uso distorto e reazionario del darwinismo ha una tradizione molto lunga, sappiamo bene che dopo essere stato (oserei dire, suo malgrado) la bestia nera dei reazionari per tutto l’Ottocento, nel Novecento Charles Darwin è stato usato per giustificare l’imperialismo europeo e in seguito dai razzisti biologici che orbitavano attorno ai regimi nazifascisti. Su questo c’è stata una battaglia encomiabile fatta dagli evoluzionisti e dai genetisti progressisti, per esempio per smontare le teorie sulle correlazioni tra razza e certe caratteristiche intellettuali.
Io ho citato Malthus che è un caso analogo e che in fondo ispira tutti gli sragionamenti xenofobi di sapore economico. In generale chi tratta la specie umana come se fosse soltanto una specie animale sta preparando qualcosa di molto bieco…
[…] Ein Gespenst nimmt uns mit an die Orte des Klassenkampfes, wo wir sehen, dass bestimmte “marxistische” Diskurse gegen die Einwanderung nicht nur nicht marxistisch sind, sondern auch einen Betrug an den Werktätigen darstellen: an Migranten wie Einheimischen […]
Questo post continua a suscitare prese di posizione, discussioni ed eventi offline.
Ultimo caso: https://xepel.wordpress.com/2018/09/04/marx-ed-engels-razzisti-del-senso-di-fusaro-per-le-citazioni/ «Marx ed Engels razzisti: del senso di Fusaro per le citazioni» – citandoci, demolisce Fusaro sul modo di produzione asiatico e sull’atteggiamento di Marx ed Engels verso le guerre coloniali.
Su SenzaSoste pochi giorni fa: http://www.senzasoste.it/wu-ming-marx-lesercito-industriale-riserva/ «Wu Ming, Marx e l’esercito industriale di riserva» dove si ribadisce il discorso di un certo Diego Fanetti (LOL) sulla questione. Articolo ripreso anche da Contropiano.
Segnalo con stupore e piacere che sono stato anche invitato a tre occasioni offline per parlare di questi post:
– La prima occasione sarà la sera (diciamo alle 21) del 12 settembre a BERGAMO, in un circolo ARCI che si chiama Barrio Campagnola.
– La seconda sarà per un dibattito alla Festa Rossa di Sinistra Classe Rivoluzione a CREMA (CR) il 14 settembre alle 20:30 presso l’ARCI Ombriano.
– La terza sarà il 27 ottobre (ottobre!) a un grande convegno organizzato da Brianza Antifascista a MONZA ma essendo così in là ve lo ricordo più avanti.
Evidentemente abbiamo toccato un punto che molti compagni reputano importante. Ci sono anche altri fatterelli che vi farò sapere, per esempio riguardo alle traduzioni… Stay tuned.
Contro le distorsioni razziste del pensiero di Marx
Audio dell’incontro con Mauro Vanetti al Barrio Campagnola di Bergamo, 12/09/2018.
Durata: 1h 29′.
«Ho conseguito una microfama di “cacciatore di rossobruni”, ma stasera vorrei partire con uno sforzo di empatia.»
Tutti i podcast di Radio Giap Rebelde sono ascoltabili e scaricabili qui.
Segnalo questo intervento di Emiliano Brancaccio perché, a mio modo di vedere, rasenta l’impeccabilità.
→ Contro le sinistre “codiste”
Prima critica duramente il “codismo” – cioè la subalternità strategica – filo-liberal e filo-liberista di certa sinistra, anche ex-“radicale”.
Quest’ultima grida al fascismo senza capire, o fingendo di non capire, che se il pozzo nero straripa è proprio colpa delle politiche neoliberiste, dunque è insensato e controproducente «fare fronte» con chi propugna queste ultime.
Dopodiché Brancaccio passa a denunciare un secondo “codismo”, che definisce anche più pericoloso, ed è lo stesso del quale ci stiamo occupando qui:
«[…] la tentazione, che si diffonde anche tra le file della cosiddetta sinistra radicale, di scimmiottare maldestramente le destre sovraniste e reazionarie nei loro più neri propositi.
Io sono al tempo stesso politicamente inorridito e scientificamente affascinato dalla mostruosa trasformazione, degna del Dottor Jekyll di Stevenson, che alcuni ex compagni hanno subito in questi anni.
Ex compagni che oggi prendono gli immigrati come capro espiatorio di ogni male economico e che prendono le distanze da fondamentali battaglie per i diritti: come quelle per l’uguaglianza di genere, per la libertà e l’emancipazione sessuale e contro ogni discriminazione, le battaglie per l’aborto, per la critica della superstizione, per una cultura laica e progressista nelle scuole.
Vorrei dirlo con chiarezza anche agli esponenti della Linke, di France Insoumise e ai nostrani più o meno disorientati: cedere di un solo millimetro, compiere un solo passo verso le agende politiche delle destre reazionarie, significa rinnegare in un colpo solo una storia più grande di loro.
Una storia che parte dall’illuminismo, che passa per le grandi rivoluzioni rosse, che attraversa il secolo con l’ecologismo, con il femminismo, con la critica della famiglia borghese. E’ la storia di chi interpreta e agisce nel mondo sulle basi scientifiche del materialismo storico e della lotta di classe.»
Sì, lo avevo letto. Anzi, mi aveva indirettamente confermato un pensieruzzo che mi ronza in mente in questi giorni. Provo a condividerlo – anche se rischio di andare un po’ OT, perché si tratta del fascismo storico, e più precisamente della posizione dei comunisti nei confronti dell’antifascismo da parte di altri partiti.
La posizione era, in generale, di netto rifiuto: per i comunisti il fascismo era un prodotto della stessa borghesia che aveva prodotto i partiti borghesi della democrazia liberale. E infatti, gli antifascisti di altri orientamenti politici (compresa gente che stimo, come Joyce Lussu) descrivono i comunisti in uno sdegnoso isolamento rispetto agli altri antifascisti.
Ho sempre valutato in maniera piuttosto ambivalente questo atteggiamento, pensando da un lato che i comunisti avessero ragione dal punto di vista dello sviluppo ideologico, dall’altro che dal punto di vista pratico costituire un fronte comune avrebbe potuto accelerare la cacciata dei fascisti.
Negli ultimi tempi invece mi scopro sempre più vicino a quell’atteggiamento dei comunisti. Non solo perché l’avvicinamento finale agli altri partiti ha significato cedere, non so quanto consapevolmente ma certo non senza responsabilità, alla continuità sotto molti aspetti tra regime fascista e nuovo assetto repubblicano. Ma anche perché, ed è qui l’analogia con la situazione attuale che ho ritrovato nell’articolo che Roberto citava, per le vicende ambigue dell’avvio del regime. È un oppositore del fascismo Luigi Facta? Sul momento sì, propone al re di dichiarare lo stato di assedio; poi però finisce per essere assorbito dal regime stesso. Quanto diversa era l’ideologia di Facta da quella di Mussolini, se è stata possibile una confluenza del genere? E quella di Giolitti?
Insomma, vedo il Pd e le “sinistre” parlamentari come quei liberali delle origini, oppositori più del metodo che dei contenuti dei fascisti. E mi viene da onorare i compagni che non hanno mai smesso di ricordare che quando loro ci manifestavano, contro i fascisti, si prendevano le bastonate di Facta, di Giolitti, di Bonomi.
Un fatto che cito sempre è questo: se dovessimo nominare un leader antifascista non di sinistra nell’Italia degli anni Quaranta, che nome faranno? Be’, Alcide De Gasperi, il capo della Democrazia Cristiana, capo del governo di unità nazionale antifascista.
Alcide De Gasperi votò la fiducia al primo governo Mussolini. Let it sink in: Mussolini fa il discorso in cui minaccia di trasformare il parlamento in un bivacco di manipoli, i deputati della sinistra si indignano e invece c’è qualche verme che applaude e decide che il discorso è stato convincente e chi l’ha pronunciato merita di governare il Regno d’Italia. Tra questi miserabili, un ambizioso spregiudicato quarantenne, figlio di un militare: Alcide De Gasperi.
Quando parliamo di unità nazionale antifascista intendiamo l’unità con questi qua.
Per quanto riguarda i comunisti, il giustissimo atteggiamento sdegnoso verso i borghesi fu spazzato via dalla svolta di Salerno, come ricordi, e a sinistra l’apparato del PCI “rinnovato” (cioè addomesticato su indicazione di Stalin stesso) divenne il più sfegatato sostenitore di ogni iniziativa di annacquamento delle distinzioni tra Resistenza rossa e antifascismo istituzionale monarchico-liberale. Naturalmente la cosa riuscì fino a un certo punto a Togliatti per vari attriti interni, particolarmente forti lungo il confine orientale dove c’era l’influenza di una linea del tutto diversa perseguita dai comunisti jugoslavi.
Questo per dire che il codismo non è una novità, la battaglia per l’indipendenza di classe, che è in prima battuta perlomeno indipendenza di analisi e di indirizzo teorico, non finisce mai perché chi vuole esprimere gli interessi delle classi oppresse sta nuotando per definizione controcorrente: le idee dominanti sono di regola le idee della classe dominante e la classe dominata può sviluppare le proprie soltanto a costo di grandi sforzi.
Traduzione in greco del post: https://gazzettarossa.blogspot.com/2018/12/blog-post.html
Con mio grande stupore, da alcuni mesi sono in corso traduzioni collettive o individuali di questo doppio post in varie lingue (sono a buonissimo punto quelle in castigliano e in inglese). A quanto pare, problemi analoghi esistono anche in altri Paesi, per cui questo testo pare possa entrare in risonanza.
Devo ringraziare moltissimo il lavoro meticoloso del compagno Vaghelis Zikos che ha aggiunto anche delle note per rendere il tutto più fruibile al lettore ellenico.
Traduzione in tedesco del post: https://fhecker.me/2018/07/11/__trashed/
Il compagno Günter Melle, che merita un altro caloroso ringraziamento, ci informa che è in dirittura d’arrivo anche la seconda parte nella lingua madre di Marx…
[…] de “ejército industrial de reserva”. Mal interpretando, de forma oportunista, el análisis de Marx y Lenin, quienes reconocían que la inmigración conllevaba amenazas para la unidad de la clase […]
Ieri due quotidiani latinoamericani, @Desinformemonos e @Kaosenlared_, hanno pubblicato una lettera di denuncia della diffusione di libri e articoli di @DiegoFusaro in Spagna e America Latina.
#GramsciSiFusaroNo
#BoicotFusaro
#DiegoFusaroFueraYa
Qui la lettera: https://desinformemonos.org/desembarca-diego-fusaro-en-america-latina-cuando-la-nueva-derecha-se-disfraza-de-marx-y-gramsci/
https://kaosenlared.net/desembarca-die