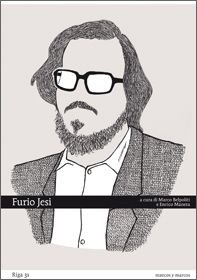 Riga 31
Riga 31
Furio Jesi
a cura di Enrico Manera
e Marco Belpoliti
Presto in libreria (2a metà di novembre)
Libreriauniversitaria – Lafeltrinelli – Unilibro – bol.it – ibs.it .
.
LA QUARTA DI COPERTINA
Mitologo, germanista, storico, traduttore, critico, militante, Furio Jesi (1941-1980) è stato uno studioso dai molti interessi e insieme uno straordinario scrittore. Scomparso a soli trentanove anni, Jesi si è dedicato in modo originale alla storia delle religioni, all’antropologia, alla filosofia, alla critica letteraria, alla traduzione, con un’intensa attività saggistica sul mito nel mondo antico, sulle sue sopravvivenze moderne e sulla sua “tecnicizzazione” politica nel corso del Novecento. Contro l’ideologica nozione di “mito”, ha coniato la definizione di “macchina mitologica”: produzione di “materiali mitologici” che legittimano il potere e ne stabilizzano l’identità. Di questa macchina, attiva nel XX secolo e non solo, ha colto la portata estetica e la capacità di generare nel medesimo tempo spazio letterario, immaginario e utopia, e soprattutto esperienze alternative e irrinunciabili che illuminano l’esistenza. La sua opera è una continua riflessione sulla cultura, sulla costante presenza della sfera mitica e sul suo valore politico e sociale. A trent’anni dalla scomparsa il suo “girare in cerchio” intorno al nesso tra sacro, potere e letteratura è più che mai attuale e offre strumenti per leggere i nostri anni.
Abbiamo immaginato questo volume come un’istantanea del tavolo di lavoro di Jesi dove si trovano i suoi scritti, diversi dei quali inediti o dispersi, ma anche lettere, fotografie, immagini di giornali cui collabora, copertine delle opere, per raccontare la biografia di questo maestro contemporaneo; e insieme, idealmente mescolati sul tavolo, saggi di suoi lettori, pagine di critica, nuovi interventi, poesie, ricordi e racconti a lui dedicati, alternati a pagine che ne riassumono il pensiero e il lavoro intellettuale.
Un libro di Jesi e su Jesi per penetrare nella sua officina letteraria. Nel numero si leggono: un racconto inedito di Wu Ming 1; saggi, interventi, recensioni e ricordi di Georges Dumézil, Ferruccio Masini, Cesare Cases, Giorgio Cusatelli, Franco Volpi, Crescenzo Fiore, Gianni Vattimo, Giorgio Agamben, Andrea Cavalletti, Günter Hartung, Mario Pezzella, Marco Belpoliti, Enrico Manera, Antonio Gnoli, Giulio Schiavoni, David Bidussa, Leandro Piantini, Roberto Roda, Margherita Cottone, Michele Cometa, Angelo d’Orsi, Riccardo Ferrari, Raffaella Scarpa. Disegni di Vito Roma e fotografie di Melina Mulas.
L’EDITORIALE
Furio Jesi è uno studioso dall’impressionante varietà di interessi e dalla straordinaria capacità di scrittura, capace di far saltare i confini tra le discipline attirando su di sé un’attenzione proporzionale alla quantità di temi affrontati e alla complessità dei testi prodotti. Precoce egittologo e critico letterario, si è ritrovato, all’apice di un troppo breve itinerario intellettuale, germanista e mitologo di rilievo: non è facile circoscrivere gli interessi vasti e profondi di questo enfant prodige colto e geniale, di origine ebraica ma agnostico, militante radicale e poligrafo folgorante, che, pressoché autodidatta, seguendo percorsi intellettuali d’altri tempi diventa allievo di Kerényi per poi muoversi in modo originale, sotto l’influenza di Dumézil, Scholem e Lévi-Strauss, sul terreno della storia delle religioni e delle idee, dell’antropologia e della filosofia.
Unendo la curiosità del bambino al lucido rigore dell’intellettuale ha dedicato alla critica letteraria un’attività saggistica ricca di fascino, svolta nel segno di Mann e di Benjamin, coprendo temi che spaziano tra Euripide, Apuleio, Rilke e Pavese, dalla ceramica egizia al teatro politico, dal versante oscuro dell’Illuminismo alla teoria del romanzo, dalla critica epistemologica delle scienze umane all’analisi dell’antisemitismo e della cultura di destra: il comune denominatore è la riflessione sul mito e sulla mitologia, nel mondo antico, nelle sopravvivenze moderne e in relazione alla “tecnicizzazione” politica nel ‘900.
Torinese ma di formazione europea, militante e teorico della «nuova sinistra», dopo anni di lavoro indipendente è approdato all’insegnamento universitario di Lingua e letteratura tedesca (nel 1976 a Palermo, poi a Genova), ambito d’adozione in cui ha svolto un ampio lavoro di traduzione (Rilke, Mann, Bachofen, Canetti) senza appartenere all’accademia e alle sue logiche. In forza di una concezione etica e pedagogica del lavoro intellettuale ha attraversato la storia editoriale italiana degli anni settanta come autore e curatore, tra gli altri, per Utet, Einaudi, Paravia, Adelphi, Bollati Boringhieri, Sellerio, ma anche come pubblicista su riviste come «Storia illustrata», «Comunità», «Nuova corrente», «Resistenza. Giustizia e libertà», «Quindici», e su quotidiani come «l’Ora» e «Tuttolibri» de «La Stampa».
La sua attività sorprendente, soprattutto se messa in relazione con l’arco temporale in cui si è svolta, si misura in una bibliografia molto vasta in cui figurano saggi, articoli, monografie, poesie, un romanzo e una fiaba per bambini. L’archivio domestico testimonia la coincidenza totalizzante di vita e ricerca: libri, foto, ritagli di giornale, schedari, pagine autografe e dattiloscritte recano le tracce di un impegno febbrile e costante svolto contemporaneamente in più ambiti; tra gli anni sessanta e ottanta la sua biografia e il ricchissimo epistolario con figure decisive per la cultura europea e italiana testimoniano una esistenza fuori dalle convenzioni, dai dogmatismi e dalle semplificazioni di ogni sorta. Un approccio alla cultura libero, ironico e corrosivo che è una festa dell’intelligenza.
Sono passati trent’anni dalla scomparsa di Jesi, nell’estate del 1980 per un assurdo incidente domestico: in questo tempo studiosi e lettori sono rimasti catturati dalla sua capacità di sondare il nesso sacro-letteratura-potere senza mai rinunciare a una prospettiva radicalmente illuminista. Per avvicinare una così complessa attività intellettuale questo volume della collana di «Riga» presenta saggi e articoli su preistoria e archeologia, mito e mitologia, letteratura e critica, scritti politici, poesie, lettere, foto, materiali inediti provenienti dal ricco archivio privato.
Abbiamo voluto immaginare il suo ideale tavolo di lavoro, mettendo le opere in ordine cronologico di scrittura (e non secondo una difficile separazione tematica) e inframmezzandole con pagine di critica, appartenenti a diversi stagioni della sua ricezione e a una nuova serie di interventi, secondo un criterio tematico e volutamente anacronico; da questa impostazione segue anche la soppressione della gerarchia interna tra gli autori, che lo stesso Jesi, immaginiamo, avrebbe apprezzato. La narrazione si costruisce secondo l’incedere della lettura ma non esclude l’apprezzamento per frammenti, che nel caso del critico torinese (e forse sempre) recano, quasi fossero organismi viventi, una traccia isomorfica del tutto. E insieme a questo una serie di raccordi, di approfondimenti sul suo pensiero e sul lavoro concettuale, pagine redatte da uno dei curatori del volume, per penetrare più a fondo nell’officina di questo maestro contemporaneo.
Questo approccio fondato sull’idea di connessione e di montaggio, inevitabilmente arbitrario, ha per noi il pregio di rispecchiare il lavoro materiale di Jesi facendo emergere l’officina letteraria di un autore ancora da scoprire, eccezionale e singolare e allo stesso tempo fortemente radicato nella realtà del suo tempo.
Sovvertendo il linguaggio e praticando una teoria politica della scrittura che cercava di delineare nuove forme di soggettività, Jesi ha contribuito come pochi a mostrare quanto la razionalità umana si rispecchi nel mito e nella storia; la sua opera è una continua riflessione sulla cultura stessa, nelle sue accezioni più ampie, incentrata sulla costante e carsica presenza della sfera mitico-sacrale nella cultura “alta” così come in quella popolare e underground. Molto prima dei nostri anni aveva visto che le identità si costruiscono attraverso diverse “macchine mitologiche”, serie testuali di immagini sedimentate, condivise e risemantizzate, documenti che si trasformano in monumenti e che determinano le memorie culturali e le strutture connettive dei gruppi umani.
A sincrono con la più avvertita cultura europea l’uso fondante del mito è stato da lui decostruito e rigettato in quanto matrice di ogni forma di “religione della morte” che sfrutta il passato per legittimare il presente. Contro la superstizione del “continuum storico” (è questa che il critico deve fare brillare) ha avanzato l’idea di una consapevole mitopoiesi “leggera”, racconto infondato che mostra i segni del lavoro dell’autore, e una concezione della ricezione come intermittenza, lampeggiamento e ricorsività, focalizzata sul soggetto di ogni “attualità”.
Jesi è anche un pensatore politico, per lui la cultura di destra era un concetto ampio, di natura teoretica e pratica, che riguardava l’uso della mitologia nella prassi politica: le parole-simbolo sono specifiche di un modo antropologico di essere “di destra”, simili a bandiere capaci di una presa emozionale sull’individuo che disintegra la capacità di riflessione. Per questo per lui la maggior parte del patrimonio culturale era “residuo culturale di destra”, custodito e amministrato dalla classe dominante che su di essa ha eretto la propria razionalità. Anche la cultura di sinistra «dinamitarda» e celebrativa rientra in una retorica del sublime che si trasforma in cultura di destra, monumentale e fondazionale. La destra diventa una categoria ampia che include una gran parte della sinistra; in questo modo la destra esercita ancora oggi un’egemonia reale sulla cultura della sinistra, così da mettere in discussione l’idea, che va oggi per la maggiore, di una trascorsa egemonia culturale della sinistra. Jesi ci aiuta a ripensare l’intera questione del rapporto tra cultura di destra e cultura di sinistra.
Leggere Jesi ed entrare nel suo campo gravitazionale lascia sempre una sensazione di euforico spiazzamento, ma se questo non bastasse, pensiamo che nella caligine di questi anni i suoi scritti possano portare una qualche luce: senza narrazione non c’è vicenda umana e solo riconoscendo nel sapere un dispositivo mitopoietico degli uomini sugli uomini, si può ancora vedere l’utopia. Come intendeva lui, la capacità di pensare e progettare un tempo diverso e migliore rimanendo dentro questo.
L’INDICE
Editoriale — 8
Biografia di Furio Jesi — 13
Wu Ming 1, Estratto da Trommeln in Genua — 18
Ferruccio Masini, Risalire il Nilo — 21
Furio Jesi, Katabasis — 24
Furio Jesi, Scheda editoriale per “L’esilio” — 29
Raffaella Scarpa, Nota sulle poesie di Furio Jesi — 30
Furio Jesi, Il significato sessuale della sporcizia rituale — 34
Furio Jesi, L’archeologia e i riflessi condizionati — 36
Furio Jesi, Carissimo Rex — 42
Furio Jesi, Idolatria e mito — 46
Furio Jesi, Carissimo professor Kerényi — 50
Antonio Gnoli, Travolti da un insolito mito — 52
Furio Jesi, Gli arabi e Israele. Sionismo politico e spirituale — 56
Furio Jesi, Israele, la democrazia e le grandi potenze – 62
Furio Jesi, Perché il Vietnam resiste? — 66
Angelo d’Orsi, Furio, uomo dello scandalo — 70
Franco Volpi, Travolti da un insolito ribelle — 79
Marco Belpoliti, Il sacrificio e la rivolta — 82
Furio Jesi, Trasmissione sulla favolistica — 88
Furio Jesi, Caro Zanzotto — 91
Furio Jesi, Mito e non conoscere — 92
Crescenzo Fiore, Furio Jesi: il mito e la macchina mitologica — 94
Gianni Vattimo, Uno studioso alle fonti del mito — 98
Roberto Roda, La notte e le pietre — 100
Furio Jesi, Cultura d’élite e analfabetismo di massa — 108
Furio Jesi, Lettera a Piancastelli — 112
Furio Jesi, Polifemo e il selvaggio — 120
Furio Jesi, Sui miti contemporanei — 126
Furio Jesi, Introduzione a “Mitologie intorno all’illuminismo” — 130
Enrico Manera, La prima volta della “macchina mitologica” — 136
Furio Jesi, Caro Calvino — 142
Giorgio Agamben, Sull’impossibilità di dire Io — 144
Enrico Manera, Mitologia e società — 154
Georges Dumézil, Mito e storia. Appunti di un comparatista — 160
Riccardo Ferrari, Il maestro e l’allievo — 166
Enrico Manera, Feste fiori sacrifici. Mito è nostalgia — 182
Furio Jesi, Mito — 188
Cesare Cases, Recensione a “L’ultima notte” — 196
Furio Jesi, Microscopio e binocolo sulla cultura di destra — 200
Günter Hartung, Furio Jesi: Cultura di destra — 202
Giorgio Cusatelli, Un difensore della ragione — 210
Furio Jesi, Appunti sulla IX e sulla X “Elegia di Duino” di R.M. Rilke — 213
Margherita Cottone, Jesi legge Rilke: “Le Duineser Elegien” — 217
Furio Jesi, L’immenso, friabile, regno del linguaggio — 232
David Bidussa, La macchina mitologica — 234
Enrico Manera, Mitologie del quotidiano — 244
Furio Jesi, Il giardino notturno di Hesse: un’ipotesi di lettura — 248
Furio Jesi, Mito e immagine — 255
Michele Cometa, L’immagine in Jesi — 258
Giulio Schiavoni, L’uomo segreto che è in noi — 271
Furio Jesi, Walter Benjamin — 280
Mario Pezzella, Mito e forma in Jesi — 283
Leandro Piantini, La mente critica di Furio Jesi — 298
Andrea Cavalletti, Note al “modello macchina mitologica” — 308
Enrico Manera, Memoria e violenza. Immagini della macchina mitologica — 325
Tavola scritti Furio Jesi — 340
Melina Mulas, Il Dalai Lama — 342
PRIME RIGHE DEL RACCONTO DI WM1
 Fu allora, svoltando in Piazza Alimonda, fu allora che vidi la macchina. Piazza Alimonda: omphalos e ultimo avamposto, spazio d’incontro tra vivi e morti, luogo a cui sarei tornato ancora e ancora da pellegrino, per sempre edotto che la sorte di Carlo Giuliani era anche mia, mia e di chiunque era stato lì, perché sarebbe potuto accadere a me, perché ciascuno di noi, nell’istante delle infinite potenzialità, era stato Carlo Giuliani e all’inverso Carlo Giuliani, prima di essere ucciso da un carabiniere, era stato ciascuno di noi e, precisamente, me.
Fu allora, svoltando in Piazza Alimonda, fu allora che vidi la macchina. Piazza Alimonda: omphalos e ultimo avamposto, spazio d’incontro tra vivi e morti, luogo a cui sarei tornato ancora e ancora da pellegrino, per sempre edotto che la sorte di Carlo Giuliani era anche mia, mia e di chiunque era stato lì, perché sarebbe potuto accadere a me, perché ciascuno di noi, nell’istante delle infinite potenzialità, era stato Carlo Giuliani e all’inverso Carlo Giuliani, prima di essere ucciso da un carabiniere, era stato ciascuno di noi e, precisamente, me.
 Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)
Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)


Grazie per la segnalazione, questo non me lo perdo!
Premesso che il libro non me lo perdo neanch’io, anzi ringrazio chi l’ha reso possibile. La lettura di Jesi è stata fondamentale anche per me, conservo gelosamente le edizioni originali di “Mito” e “Mitologie intorno all’Illuminismo”. Il che non mi impedisce di rilevare a posteriori i limiti dell’interpretazione di quella che lui chiamava “la macchina mitologica”. E’ un’interpretazione puramente semantica, che non tiene sufficientemente conto del carattere “mimetico” del mito, già messo in luce da Caillois prima che da Girard. Poi c’è un problema antropologico di fondo: che il mito rappresenti un ordine egemonico del discorso va bene, ma che quest’ordine rimandi unicamente alla giustificazione del potere, risponde a un’interpretazione pan-politica della cultura, che elimina ogni possibilità di fondazione che sia comunitaria e non dispotica. La sinistra è vittima di questo errore, il che spiega l’impossibilità dei figli di diventare a loro volta padri e la sindrome di Peter Pan che inevitabilmente imprigiona l’intellettuale progressista.
Storia lunga, e, parrebbe, infinita: in realtà, circolare.
D’accordo con Claudia. Lavoro straordinario ed inconsueto, sono molto curioso di leggerlo…
@ Valter,
se hai tempo, dài un’occhiata alla discussione in calce al post precedente (“Live in Pavia” etc.). Alcune cose che ho scritto (la mia critica all’approccio derivato da Lévi-Strauss, ad esempio) non mi sembrano distantissime da quelle che hai appena scritto tu. Non sono combacianti, ma occupano in modi diversi uno stesso spazio di argomentazione. Tuttavia, penso che il tuo mini-compendio dell’impostazione antropologica di Jesi non gli renda giustizia: se c’è uno che ha affermato l’ineludibilità di un rapporto col mito (con “materiali mitologici”), quello è lui. Non ha mai detto che il mito sia *solo* mera giustificazione di un dominio. Anzi, la sua posizione è che il mito sia un “niente”, uno spazio vuoto, spazio che non possiamo non tentare di riempire. E se non riusciamo a riempirlo, ci aggiriamo intorno ai suoi bordi, raminghi, a ramengo. Anche se non mi sembra usi mai quest’espressione (che nel post-strutturalismo era un tabù!), tale spinta a riempire quel vuoto è un vero e proprio universale: *tutti* hanno bisogno di un rapporto col mito, tutti ricombinano materiali mitologici in cerca di un senso, di un continuum etc. Ma ripeto, se hai voglia, dài uno sguardo alla discussione dei giorni scorsi.
di sicuro non me lo perdo neanch’io;
ieri ho preso in biblioteca “Spartakus” di Jesi. comincio da questo.
@wm1
le prime righe del racconto mi hanno ricordato che *quei giorni* mi bruciano dentro.
@Wu Ming1
Letto. In effetti, quello che scrivi sulla dittatura dell’ironia (e Busi!) è precisamente quello che mi fa dire da tempo che in Italia (dove l’unica opposizione di sinistra è il cabaret di Zelig) non esiste una classe intellettuale che non sia onanisticamente avvitata nella coazione a ripetere.
Quando poi scrivi:
“Lévi-Strauss si è impegnato a fondo ad analizzare il mito come linguaggio, a tracciare le linee di una scienza del mito, a trovare le serie combinatorie degli elementi di base del mito. Ma quest’approccio tutto razionalizzante, cartesiano, è limitato. Scegliendo di non dare importanza alle emozioni e analizzando il mito come qualsiasi altro aspetto concettuale, Lévi-Strauss se ne fotte del suo aspetto “fusionale” (“l’unico cosmo” del frammento di Eraclito), quindi non coglie la specificità del mito (e del sacro) e ci disarma di fronte alla sua forza. Il mito e il sacro sono visti come prodotto di un pensiero più “arretrato” rispetto a quello dell’intelletto razionale, cioè: prima viene il mito, poi la ragione. L’emozione è solo caos, disordine da superare.”
Addirittura questo avrei potuto scriverlo io.
Chissà se saresti d’accordo sul fatto che l’approccio del nostro grande maitre a penser (Umberto Eco) alla cultura di massa è stato condotto precisamente con questi limiti, cioè unicamente teso alla decodifica semantica e del tutto ignaro del suo carattere mimetico. Il che spiega, data l’egemonia del personaggio e dell’approccio, la resa totale dell’intellettuale italiano rispetto al mezzo televisivo, di cui ha finito col costituire una presenza macchiettistica e sintatticamente subordinata (non stiamo a fare esempi, per carità di patria).
Beh, Valter, avrai visto che in un commento più sotto preciso un po’ i termini della mia critica a Lévi-Strauss (che comunque non mi sogno nemmeno di scartare: dico solo che il suo sguardo sempre distaccato lo trovo mancante di qualcosa) e per spiegarmi uso proprio Umberto Eco all’apice del suo approccio decodificante. Vale a dire: uso i “limiti” di quest’ultimo contro i limiti stessi. Metto… un limite al limite.
@Wu Ming1
La triade di Eco è una variante di quella di Comte. Presuppone un’obsolescenza degli stadi iniziali all’avvento di ciò che segue.
Io sono convinto invece che il mito sia uno stadio aurorale della coscienza, un fenomeno originario e destinato sì all’esplicitazione, ma ogni volta ritornante, come il risveglio e l’uscita dal sonno di ogni mattina, il che ci garantisce (come “il fanciullino” pascoliano) una rinnovata freschezza di spirito, ma anche il costante pericolo di ri-cadere nel pensiero magico.
OT.
Su Eco, comunque, sto scrivendo una cosa che poi ti mando.
@ Valter,
a dire il vero, Eco scrive la stessa cosa in altri termini, cioè che prima o poi si torna sempre al “tipo cognitivo”, alla comprensione immediata e di base di un oggetto (nello specifico del mio utilizzo: il mito). Anche chi ha una conoscenza più approfondita deve affidarsi alla comprensione di base, se vuole condividere l’esperienza con altri. Eco propone l’esempio di uno zoologo esperto di muridi:
Ora, torniamo a come io utilizzo questo “movimento ritornante” dalla comprensione più tecnico-razionale a quella immediata ed empatica.
Fatta salva l’utilità (e addirittura necessità) delle analisi strutturali dei miti, delle ricombinazioni di materiali mitologici etc., prima o poi bisogna fare i conti con il mito come lo esperiamo prima di qualunque teoria, prima di qualunque scomposizione, prima di qualunque divisione categoriale etc. Cioè tornare a dire, di fronte a una narrazione poderosa, coinvolgente, creatrice di legame sociale, che faccia precipitare sul presente un’idea di passato: Ecco il mito. Ecco la sua forza.
Perché, come si è detto più volte, al “bisogno di mito”, alla spinta che vuole riempire quel “niente”, non si può rispondere solo con il “disassemblaggio” dei miti, ma con una mitopoiesi (parola che tendiamo a usare meno di una volta).
E’ il motivo per cui, nella mia vecchia “Lezione su 300“, partivo da ciò che il mio “cervello rettile” aveva provato vedendo il film:
In “Apocalittici e integrati” Eco paragonava la televisione agli affreschi delle cattedrali – una teologia per gli analfabeti – avallando l’ipotesi che la “visività” del mezzo sia una semplificazione dell’elaborazione culturale appannaggio delle classi colte. Io credo che questo sia un grosso errore epistemologico (smascherato da McLuhan che in quel libro Eco “stranamente” non cita mai), ma soprattutto che lo stesso errore si rifletta sul modo d’intendere il mito, che per qualcuno è un’allegoria composta paternalisticamente a scopo pedagogico. Rispetto a quello che scrivi tu sui 300, avrei solo da eccepire che il mito non è semplicemente “cronologicamente” anteriore alla scienza ma anche “ontologicamente”, in quanto sapienza allo stato nascente.
Per me qui l’autore-chiave sarebbe il Vico.
Ma anche Heidegger. Mito come Ursage, “dire originario”.
A parte il fatto che il guru della Foresta Nera non è riuscito a distinguere tra mito genuino e mito tecnicizzato, con le imbarazzanti prese di posizione che conosciamo.
Ogni atto linguistico è un atto di potere, perciò politico; questo non significa vietato. Mi sembra che qualcosa di simile lo dica Barthes in Lezione. Che una società per fondarsi abbia bisogno di miti da retrodatare è ormai arcinoto (per es: tanti piccoli comuni di pochi abitanti negli ultimi anni si inventan santi e ricorrenze da festeggiare per sentrsi paese e far girare l’economia e paano profumatamente le consulenze di storici e antropologi).
Non conoscendo direttamente Jesi, ho letto con curiosità questo post e mi sembra di ritrovare il nuceo della ricerca di Pasolini: rapporto tra sacro-mito-potere.
Comunque complimenti per l’efficacia della vostra scrittura.
Valter, il punto è che per me il mito non è “anteriore” alle altre forme di sapere o di esperire, né ontologicamente né cronologicamente. E’ sempre compresente, contemporaneo a esse. Nel senso che, anche procedendo sempre più in là con le razionalizzazioni, comunque di quel “niente” da riempire, di quel bisogno di narrazione compartecipe e comunitaria, non te ne liberi mai. E’ sempre con te. Noi pensiamo in quel modo, non possiamo farne a meno. Ma forse stiamo andando troppo in tondo e rischiamo di essere criptici.
@ collettivocorpo10,
da Pasolini non si scappa. E’ ineludibile. Ci si tornerà sopra.
Ciau tutti,
Intervengo, superando il momentaneo imbarazzo di essere uno dei curatori del numero di ‘Riga’, Enrico, – grazie a tutti per interesse e complimenti – proprio per il piacere di intervenire a caldo in mezzo a un discorso interessantissimo su cose attorno alle quali ho lavorato per anni, che a partire da Jesi continua a essere decisivo ieri come oggi.
I punti che mi sembrano decisivi sono già stati sottolineati da WM 1 e in qualche modo ripercorsi nel forum precedente a cui lui rinvia, ma provo a riprenderli. Superfluo dire che se dico ciò che diceva Jesi mi riconosco nelle sue posizioni:
il mito non è originario e non è un prodotto dell’origine, è l'”origine” che è una creazione del pensiero mitico e il concetto che viene prodotto da un sapere che si presenta come fondazionale; il senso di un’origine, di una verità, di un di più di senso è la prestazione di ogni materiale mitologico, prodotto dalla mitopoiesi: e ogni cosa può diventare un mito (cfr. Barth e Assmann)
Lo stato aurorale o la prima volta sono creazioni a posteriori che servono a legittimare chi viene dopo sulla base di un prima; fanno parte di un processo di legittimazione che era già noto a chi canonizzò i testi omerici. Ciò che chiamiamo ‘mito’ è stato elaborato ex post da Platone che ne ha fatto un altro da sé della ragione, ma prima di Platone e (Tucidide) non ci sono tracce di una distinzione tra mythos e logos: racconto e discorso sono sinonimi per tutto il mondo greco arcaico.
Quando diciamo ‘mito’ per parlare dei racconti di popoli ‘primitivi’ usiamo un concetto pass-partout ignoto alle culture di riferimento e alle classificazioni locali ed ‘emiche’.
Se per mito intendiamo un corpus di narrazioni antichissime allora sappiamo che già nel paleolitico dovevano esserci narrazioni su qualcosa e che tutti i sapiens sapiens lo fanno, da sempre, almeno da quando parlano (ehm…); ma quando abbiamo a che fare con il ‘mito’, c’è scrittura, uso comunitario e politico che niente a che fare con quella cosa che da Vico ai romantici è stata presa come ‘cavallo di troia’ per introdurre la metafisica nella storia. Una costruzione culturale talmente bella e potente che la vogliamo ancora oggi e ci manca, perché a un certo punto abbiamo deciso che gli antichi ce l’avevano e noi moderni l’abbiamo persa per sempre.
Il mito del mito, direbbe NAncy, che noi scopriamo per dire che l’abbiamo perso.
Vale piuttosto la nozione di ideologia di Dumézil e il fatto che il ‘mito’ sia una traccia di una storia remotissima, ormai sfigurata e resa irriconoscibile da chi credendo di raccontarla la modificava inesorabilmente; tracce di una o diverse società in senso trans-storico, ma risemantizzate e continuamente trasformate in nuove ‘origini’, che a rigore quindi non sono mai tali (cfr. la nozione di origine di Benjamin).
Se poi si parla come mito di elemento trascendentale in qualche modo allora c’è da vedere Cassirer, e non Heidegger che Jesi considerava un mitologo/mistico non diverso da Eliade; qui per me che mi considero post-metafisico e un antropologo più che filosofo si apre una questione ancora più complessa.
Leach criticava tutte le posizioni accomunate da un «postulato ‘vichiano-roussoviano’» ovvero l’idea che la poesia sgorghi naturalmente nell’uomo in quanto espressione immediata di emozioni costituendo la base del processo di «simbolizzazione» che sarebbe la dote specifica dell’Homo sapiens: tale postulato «ammette una progressione evolutiva dell’uomo dallo stato naturale, senza artifici né linguaggio, allo stato culturale, con artifici e con linguaggio, ma scopre la causa efficiente di tale progresso nella stessa potenza inventiva della natura umana. Ma ciò equivale a dire che l’attività intrinsecamente razionale dell’astratta previsione immaginativa potrebbe essere l’attributo di una creatura che non abbia ancora quello strumento primario per simili operazioni mentali umane che è il linguaggio».
Come prendersi per la coda, insomma, corto circuito.
Bisogna dunque presupporre come specifici del processo evolutivo una «serie di mutamenti che agli inizi ebbero luogo casualmente […] e che in seguito in qualche modo divennero una caratteristica geneticamente determinata, condivisa da tutti i membri della specie umana in seguito all’adattamento selettivo. Uno sviluppo evolutivo di questo tipo è un processo storico totalmente diverso da quello dell’invenzione cosciente». (Leach, Natura/cultura, in Enciclopedia Einaudi)
Jesi insomma sosteneva la necessità di dover abbandonare la concezione “ingenua” del mito come ‘essere dell’origine’ che secondo Blumenberg deve essere rovesciata con l’interesse per la ricezione, storicamente e politicamente situata di ogni mito.
Allo stesso modo, come in Wittgenstein e Eco per cui non si può risalire alle origini del linguaggio ma bisogna prenderne atto dei meccanismi, Jesi usa la ‘macchina mitologica’ proprio per uscire da quell’impasse.
Jesi rimane affascinato dalla vertigine dell’originario fino a quando – questa è la tesi che intendo mostrare – a metà degli anni settanta matura uno stile saggistico con il quale ha rinunciato a essere storico delle religioni e teorico dello spirito umano: attraversando il dibattito sullo strutturalismo e approdando a una critica letteraria che è anche critica dell’ideologia.
E qua arriva la questione che WM e noi abbiamo a cuore.
Sapendo che il ‘mito’ non esiste, ma esiste la mitopoiesi e la sua peculiare verità, come fare a non ricadere nelle secche del mito tecnicizzato, fideistico, fascista, etc etc?
Come facciamo ad avere ancora miti e a fondare comunità se sappiamo che tutto è costruito?
La mitopoiesi leggera e letteraria, di cui alle pagine precedenti, è l’unica risposta che mi sembra sensata.
Mitologia che però vaccina dall’idea di trasformarlo in verità metafisica, vettore emozionale che spinge a pensare.
sulla filosofia post-metafisica del mito giro questo.
http://arrigomalera.blogspot.com/2010/10/elementi-di-filosofia-post-metafisica.html
Scusate la torrenzialità.
grazie a tutti per l’attenzione.
enrico
State volando parecchio alto, provo a buttare giù qualche considerazione.
@WuMing1
La risposta di quello che chiami “cervello rettile” alla visione di 300 è, a mio modo di vedere, sempre presente, qualunque storia ci venga narrata. E’ uno dei numerosi processi che, nel caso della lettura, inizia con il riconoscimento morfologico delle singole lettere, procede con l’aggregazione in parole, poi in frasi e così via. Il processo è iterativo, nel senso che il nostro cervello torna più volte su quello che ha recepito. In uno di questi ritorni, che può avvenire durante la narrazione (anche più volte), oppure solo alla fine, a seconda sia della qualità della narrazione sia del livello culturale del lettore, il contenuto della storia, che “inizialmente” (ma in realtà alla fine del processo di decodifica del messaggio) ha causato una nostra reazione emotiva, passa alla successiva fase di analisi che ci consente di dire che quella storia che pure ci ha messo in moto ormoni adrenalina e quant’altro è razzista o sdolcinata o semplicemente inverosimile.
Che tu ti senta “schizofrenico” di fronte a 300, e che tu sostenga che l’analisi tradisce ciò che ami, significa secondo me due cose: che quel film (che non ho visto, NdA) è ben fatto, nel senso che la storia narrata è credibile e coinvolgente; e che tu hai strumenti analitici in grado di “vedere attraverso” (come direbbero gli anglosassoni) quel racconto.
Il fatto che l’analisi razionale di una storia venga dopo la reazione emotiva, non significa affatto che debba cancellarla (non può, in realtà), è solo un effetto collaterale del nostro armamentario per sopravvivere su questo pianeta: uomini che di fronte all’improvviso apparire di una tigre dai denti a sciabola avessero attivato l’analisi razionale *prima* di provare paura sarebbero durati poco. Certamente l’analisi può invalidare l’emozione (non rimuoverla, ripeto), nel senso che a posteriori riconosce che si è trattato, ad esempio, di un falso allarme (non era davvero una tigre dai denti a sciabola), oppure che il narratore, per quanto abile, non è degno di fiducia; ma non vedo in questo una supremazia, perchè se invece la convalida, la cosa principale che rimane è proprio l’emozione.
@ Enrico
come ti dicevo nella discussione precedente, ritengo che la mitopoiesi “leggera”, la ricombinazione letteraria, il lavorare mettendo bene in mostra i procedimenti, possano senz’altro essere *buona prassi* critica, ma non siano sufficienti come “contravveleni”.
A “giocare” coi materiali mitologici in questo modo rischia di essere (anzi, quasi certamente sarà) un’élite, un Parnaso politico-letterario di “avveduti”. E quelle ricombinazioni finiranno per rivolgersi a pochi.
Al contrario, i tecnicizzatori “parlano alla panza” della gente, investono le masse an-alfabetizzate con getti mitici di grande potenza.
Se questa prassi della mitopoiesi “leggera” non scade già in cazzeggio, e se vuole accettare la sfida del “popolare”, prima o poi si troverà di fronte al proprio limite, e si ritroverà costretta a *fare sul serio*. E’ più o meno quello che abbiamo esperito nel passaggio dal Luther Blissett Project a Wu Ming, quando abbiamo avuto la fase “soreliana”, con il “mito di lotta” etc.
E a quest’altezza si presenta un nuovo problema, cioè: rientra dalla finestra la tecnicizzazione, perché a fare mitopoiesi non può essere un gruppo separato, che sia “cellula” o “cenacolo”.
Dev’essere un soggetto collettivo più esteso, protagonista dei conflitti, a far sorgere dal basso narrazioni forti, partecipate, in perenne evoluzione, in cui il soggetto possa auto-rappresentarsi nel flusso dell’esperienza e della lotta. Storie che non siano evocate da “stregoni” dell’Agit-Prop, bensì dalla comunità stessa, e condivise, ri-raccontate, *tenute vive*, continuamente irrigate (WM2 cita spesso la metafora kerenyiana del mito come fango che va tenuto bagnato altrimenti diventa terra arida).
Con tutti i limiti e i difetti di quell’esperienza, mi sembra che negli ultimi anni gli unici a tentare consapevolmente questo “impossibile” siano stati gli zapatisti. Quell’esperienza è stata dimenticata troppo in fretta, associata alle sconfitte strettamente politiche che non ha saputo (né poteva) evitare, e a un certa perdita di “smalto” mediatico (i “turisti rivoluzionari” sono modaioli, rivolgono le loro attenzioni dove c’è più glamour). Sarebbe ora di tornare ad analizzarla, vedere quali erano i punti di forza e quali le cose da non riproporre.
@ alexpardi
sono un grande fan dei tuoi apologhi “neolitici” :-)
Guardalo, 300. Scaricalo o noleggialo. In meno di due ore, fornisce un catalogo di tutte le insidie che abbiamo di fronte nella sfida contro i tecnicizzatori.
Comunque sì, stiamo “volando troppo alto”, troppi nomi di filosofi e antropologi etc. Sforziamoci tutti, io per primo, di essere comprensibili e dare il maggior numero di riferimenti possibile senza diventare kilometrici. Quando nominiamo un tizio, aggiungiamo due paroline due su qual era la sua teoria etc.
Ecco, quando nel mio commento sopra ho detto che Wu Ming ha avuto una fase “soreliana”, intendevo dire che ragionavamo (*più o meno*; per modo di dire) come costui:
http://www.filosofico.net/sorel.htm
@WuMing1
Gli è che non avendo studiato o letto nulla di quello di cui si parla, mi tocca di partire dall’eta della pietra :-)
@Malera
Daccordissimo che il mito dell’origine è la prima notizia che abbiamo circa un’origine ma non su questo:
“Ciò che chiamiamo ‘mito’ è stato elaborato ex post da Platone che ne ha fatto un altro da sé della ragione, ma prima di Platone e (Tucidide) non ci sono tracce di una distinzione tra mythos e logos: racconto e discorso sono sinonimi per tutto il mondo greco arcaico”
La sostanziale sinonimia dei termini non toglie che ben prima di Platone fosse evidente lo sforzo di emancipare la filosofia dal linguaggio immaginoso dei poeti. Senofane di Colofone e soprattutto Parmenide di Elea sono lì a mostrare quanto fosse importante per loro giungere a un pensiero che assume il pieno controllo del significato, oltre l’ambigua spontaneità delle immagini. Semmai Platone è colui che recupera al “mito” un significato positivo riproponendolo in chiave allegorica.
Quanto all’irritazione che termini come “aurorale” provocano alla coscienza illuministica, che nell’aurora vede la negazione del pensiero più che il suo embrione, ci vuol altro che una liquidazione sbrigativa per sbarazzarsene.
Se Vico e compagnia ti sembrano solo agenti del Vaticano incaricati di introdurre di soppiatto la metafisica nella storia, la psicanalisi come mitologia della “scena primaria” è un modo solo più laico per riproporre l’ineludibilità dell’archetipo.
Stavo già scrivendo quanto segue prima di leggere WuMing1 sui “troppi nomi ecc.”. Quindi mi scuso, ma copio e incollo con qualche nome e qualche riga di troppo.
Se il tema è “l’interzona” tra “l’impossibilità del mito genuino e il mito non-ancora-tecnicizzato”, mi permetto di invitare a sperimentare il banale accoppiamento, ma sempre a forte rischio d’incesto, tra l’operare di scienza e poesia: vecchio progetto che accomuna due diverse modalità di invenzione dallo statuto parimenti politico, che pure formano una coppia sempre sospetta. Ma se fosse l’abbandono di ogni loro possibile convergenza un rischio ancor più grave della sanguinosa celebrazione novecentesca della loro coincidenza? Fu allora il mito (tecnicizzato) della scienza – e non la scienza – ad essere catturato nell’estetizzazione della politica. E se avessimo in seguito buttato l’acqua della modernità con il suo bambino prodigioso? Credo che la necessità di una ritualità laica sia il vero insegnamento e non semplicemente l’epilogo grottesco di una stagione straordinaria di pensiero e di ricerca – il positivismo – in Italia cancellata da destra prima e da sinistra poi, in nome del malinteso di una cultura umanista. Eppure i figli di quella tradizione, con le loro rituali conferenze alla “Société française de philosophie”, compaiono in formidabile sequenza nei nostri ammirati discorsi, fino ad oggi, quando citiamo gli epigoni della stagione francese del pensiero del ‘900. È davvero la scienza che si fa letteratura in Lévi-Strauss, quando la ricerca scientifica dimostra la forza mitopoietica del proprio compito infinito e della propria azione retroattiva sul vero originario del pensiero materialista: «Le jour où l’on parviendra à comprendre la vie comme une fonction de la matière inerte, ce sera pour découvrir que celle-ci possède des propriétés bien différentes de celles qu’on lui attribuait» (Id., La pensée sauvage). Perciò a fianco della “mitopoiesi leggera e letteraria” vorrei fosse sempre ben visibile la finalmente dichiarata pesantezza delle sue condizioni di possibilità, il rigore della ricerca scientifica che Enrico conosce tanto bene: innanzitutto quella che ne è l’occulta matrice, nella disciplina e nell’accuratezza dell’esercizio filologico. Il mito politico deteriore è la risoluzione semplicistica della scienza nella formula della sua applicazione, tanto quanto la riduzione della letteratura al proprio esito felice senza lo sforzo e la fatica della parola “pesata”, non compromessa con l’ovvietà, né troppo tecnicizzata. “L’interzona” della letteratura è certo anche quella della politica, poiché l’apertura all’invenzione rompe con il cattivo infinito dell’(auto)ironia, lo sforzo si concede un esito capace di prendersi sul serio: con leggerezza, ma sul serio, dichiarando le proprie intenzioni. Tale apertura è anche quella della scienza, perché in tutti i casi si tratta del “momento” (inerziale) della verità, del suo prender corpo attorno ad una posizione di soggetto la cui garanzia (ma anche il cui rischio costitutivo) sta nella tradizione da cui non siamo ancora usciti e con cui non possiamo non continuare a fare i conti: quella tradizione che volendosi luminosa pretende di uscire dal mito e che per questo teme di precipitarvi rovinosamente ad ogni passo, e della cui dialettica niente affatto esaurita dobbiamo interamente farci carico. Non credo che oggi possiamo salvarci dal mito senza saperci fare con il mito della scienza: “saperci fare” come con un sintomo che, direbbe Lacan, è la nostra singolarità. Visto che la discussione si era aperta con i topi di Badiou, chiudo su uno dei maestri indiscussi della sua generazione, che in piena stagione lacaniana il giovane Alain intervistava con deferenza e ammirazione: – Badiou: «Intendete dire che l’espressione “conoscenza scientifica” è un pleonasmo?» – Canguilhem: «Mi avete compreso perfettamente. Una conoscenza che non è scientifica non è una conoscenza. Affermo dunque che “conoscenza vera” è un pleonasmo; che “conoscenza scientifica” è un pleonasmo; e anche “scienza e verità”; e che tutte queste cose sono la medesima cosa. Ciò non significa che non ci sia per l’uomo alcuno scopo o alcun valore oltre la verità, ma significa che non si può chiamare conoscenza ciò che non lo è, e non si può dare questo nome a una forma di vita che non ha niente a che vedere con la verità, ovvero con il rigore».
@wu ming 1
ok, provo ad andare più veloce e diretto
si, vero: bisogna evitare l’idea dell’élite illuminata e riprendere l’egemonia culturale dal basso, sottraendo alla destra de panza l’immaginario e le coscienze.
Ma lo puoi fare solo se non crei nuovo mito pesante, altrimenti allevi legioni di idolatri di segno opposto alla tecnicizzazione fascista, un po’ come il sur-fascismo di Bataille e Caillois, che non riuscì neanche a uscire dalla massa.
emozione sì altrimenti noin c’è legame sociale, ma apertura alla riflessione. detto altrimenti: noi intellettuali che parlano troppo come noi dovrebbero pensare al legame sociale e non disperare luttuosamente sulla perdita; viceversa credo che una massa non ragionante forgiata su temi ‘nostri’ sarebbe comunque altra forma di società che non condivideremmo, quindi credo che si debba fare una forma di mitologia nuova, che demitologizza al tempo tesso.
@valter
(commento ancora molto tecnico)
Platone e Senofane sono tecnicizzatori; il loro logos è divino, è metafisica che innerva di senso la storia, certo loro ne erano convinti e non sono machiavellici simulatori.
Mi fraintendi: embrione del pensiero implica che ci siano già le possibilità trascendentali di pensare, e non che quete si formino in fieri.
Vico e compagnia non sono ‘ agenti del Vaticano’ ma è evidente che volevano introdurre la metafisica nella storia; la psicanalisi è mitologia della “scena primaria” èd un modo solo più laico per riproporre l’ineludibilità dell’archetipo, siamo d’accordo. Tutti i miti ‘funzionano’ perché non abbiano altro: la mitologia che chiamo metaspsicologia funziona meglio di quella che chiamiamo metafisica, perché il suo fondamento è antropologico e non trascendente-metafisico-ontologico.
io non nego che i miti esistano nelle nostre vite, vorrei fosse chiara la sua natura ‘storica’, archetipo è un prototipo sedimentato nei millenni. la cui origine aurorale (termine che adoro) è tale in termini neurofenomenologici, un prodotto dell’immaginazione trascendentale che rielabora esperienze radicate nel corpo.
grazie a tutti
@ Enrico,
escludo a priori, certo, la “massa non ragionante forgiata su temi ‘nostri’”. Vado/andiamo in cerca di esempi non episodici di consapevole produzione mitologica auto-organizzata, orizzontale, proveniente “dal basso” e “annaffiata” dalla creatività, almeno finché è possibile. Da qui anche il nostro interesse “jenkinsiano” per fan-fiction, mash-up, riappropriazione dal basso di certe icone e certi prodotti pop, e altri fenomeni del genere. L’interesse non è per i *risultati* di tali processi, ma per il funzionamento di quelle comunità informali, dove persone non si limitano a ricevere e fruire prodotti e materiali della cultura di massa, ma hanno voglia di ri-manipolarli. Mutatis mutandis, questo può farci capire qualcosa su come proporre materiali mitologici in una comunità più politica, impegnata in una lotta? Secondo molti osservatori, sì.
Ovviamente, ogni ragionamento di questo tipo deve tenere conto del contesto sociale, dei rapporti di forza, della composizione di classe etc. (a seconda del frasario prediletto da chi legge). La manipolazione creativa della cultura maya non ha impedito il “riflusso” del sostegno internazionale all’EZLN etc.
Per l’aggettivo “jenkinsiano” cfr. qui:
http://www.wumingfoundation.com/italiano/outtakes/culturaconvergente.htm
ottimo, grazie
ora scappo in classe, che ho in programma Filippo IV il Bello contro Bonifacio VIII e i templari: uno sballo…
le pagine a questo proposito di Eco ne ‘Il pendolo di Foucault’ sono indimenticabili.
volevo solo dire che prima nella fretta vicino a Caillois e Bataille ‘massa’ va sostituito con nicchia.
Ne parlerò con il mio analista di questo lapsus.
e hai ragione assolutamente: se posso sintetizzare:
il materiale mitologico non è il fine, ma è il mezzo che crea legame nella comunità servendosi di comunicazione declinata al futuro.
Dopo Furio Jesi, ci sarebbero anche altri da riproporre sul tema.
Qualcuno di voi si ricorda Gianni Carchia (“Orfismo e tragedia”, “Estetica ed erotica” ecc) ?
Di Jesi ho letto “Mito”, “Demone e mito (carteggio con Kerényi)”, “Spartakus. Simbologia della rivolta” e l’importantissima introduzione a “Ventura e sventura del guerriero” di Dumézil. Sulla scrivania mi aspetta “Il linguaggio delle pietre” e, presto, il libro di prossima uscita di cui si parla qui.
Apprezzo molto Jesi per il suo spirito militante e, più nello specifico, per aver sempre difeso Dumézil sia dalle strumentalizzazioni della destra che dalle denigrazioni di certa “sinistra” (in proposito si veda l’introduzione a “Ventura e sventura del guerriero”).
Tuttavia diverse sue analisi e conclusioni – soprattutto sul piano politico – non le condivido. Dieci anni fa scrissi una recensione a “Spartakus” molto critica (http://www.leftcom.org/it/articles/2000-12-01/rivolta-e-rivoluzione-per-furio-jesi-una-recensione). Rileggendola oggi la ritengo un po’ grezza e forse ingenerosa, ma ancora valida nella sostanza.
Dietro la critica allo “pseudomito dell’età dell’oro di perfetta giustizia” c’è in Jesi e in tanti altri la sfiducia nella rottura rivoluzionaria, e questo è comprensibile visti gli esiti della Rivoluzione bolscevica. Ma è sbagliato. L’Ottobre rosso e tutto ciò che è girato intorno ad esso (l’uscita dalla guerra, la più grande armata volontaria della storia, la rivolta spartachista, la comune di Budapest, la nascita dell’Internazionale, il biennio rosso in Italia…) è stato il momento in cui il più recente motto “un altro mondo è possibile” si stava davvero realizzando.
Quando i signori della terra tremarono davvero.
Mi pare un “mito” abbastanza solido, se liberato dai tanti falsi miti che ci hanno costruito sopra.
Solo un appunto sulla concezione del mito in Jesi. “Di là dai tentativi di apologia metafisica del mito o, per converso, di demitologizzazione o comunque di negazione dell’essenza-sostanza del mito, la necessità più urgente ci sembra quella di indagare il funzionamento dei meccanismi della macchina mitologica – anche se ciò impone di collocare fra parentesi il problema relativo all’essere o al non essere del mito in sé e per sé.” (Jesi, “Mito”).
Indagare i meccanismi della macchina mitologica. Benissimo. L’essere o il non essere del mito in sé e per sé è invece un enigma del tutto metafisico. I miti non sono una cosa sola. Sono racconti, e come tali, un miscuglio di menzogne e verità, di storia e fantasia, di archetipi e modelli sociali, di saggezza millenaria e tecnicizzazioni interessate…
Io non credo che ci sia bisogno di inventare nuovi miti. Millenni di storia umana hanno sedimentato nella cultura di ognuno di noi un’immensa mole di miti da cui attingiamo continuamente. La tecnicizzazione la lasciamo al nemico che vive di menzogne. Noi invece dovremmo fare come gli spartachisti (http://www.bwbs.de/UserFiles/Image/Weltgeschichte/Spartakusbund_1916.jpg) che semplicemente dicevano: NOI siamo Sigfrido, e il drago è il capitalismo.
Certo, così come un mito non può essere, semplicemente, “distrutto” (la demitizzazione è un compito impossibile), così un “nuovo mito” non può essere inventato dal nulla. I materiali mitologici sono il prodotto, come scrive Giacomo, di millenni di storia umana. Si tratta di attingere a quel patrimonio senza riprodurre narrazioni alienanti (miti tecnicizzati, appunto).
Dove non sono d’accordo è sul fatto che la critica alla pseudo-età dell’oro (ai “bei tempi” di una supposta uguaglianza ancestrale) implichi una sfiducia nella rottura rivoluzionaria. Ribadire, persino ad nauseam, che “i bei tempi non ci sono mai stati” significa vaccinarsi da narrazioni reazionarie che trovano spazio (benché marginale) anche “a sinistra”, come l’anarco-primitivismo alla John Zerzan, con la sua ricostruzione dozzinale di un’umanità che ha cominciato ad andare a ramengo col neolitico, mentre il paleolitico è la dimensione che dovremmo recuperare etc.
Quanto a Jesi, non solo in Spartakus non abbandona mai il fianco degli spartachisti (e spiega che quella di Luxemburg e Liebknecht fu un raro esempio di “propaganda genuina”, “autentico linguaggio della verità”); non solo cerca un approccio a una “letteratura ideologica [che sia] davvero proletaria, non [solo] letteratura accessibile al proletariato”; non solo descrive i limiti della rivolta senza domani e la sua strumentalizzazione da parte dei “mostri” del capitale; ma nel finale del libro scrive che “Il domani è attuale perché i rivoluzionari lo preparano”.
@giacomo
conosco la tua recensione di ‘Spartakus’, e sono lieto di poterti scrivere, mi sembrava che ci fossero dei fraintendimenti,
in primis l’usare lettere di Kerényi molto precedenti per spiegare quelle successive (lo scambio sul demonico è precedente alla ‘svolta’ marxista)
in secondo luogo per le accuse a Jesi di essere sostanzialmente un socialdemocratico moderato e riformista. Premesso che il testo è tortuoso e non a caso inedito, forse lui non l’avrebbe mai pubblicato così:
riassumo veloce
per Jesi quella rivolta era destinata al fallimento ed era strategicamente insensata;
la scelta di condurla a termine risponde a una logica escatologico-sacrificale che dovrebbe essere estranea ai movimenti rivoluzionari perché alimenta il mito del sacrificio e della battaglia perduta da un lato e rafforza la reazione da un altro.
Jesi lì diceva sostanzialmente: insabbiamento a fino che i tempi per la rivoluzione non sono maturi; il mito alimenta la rivolta e non ne possiamo fare a meno ma guai a fare come Sorel (che non a caso diventa uomo di destra) e a costruire miti/agiti in quadro simbolico cognitivo che rafforza i simboli e i poteri del capitalismo.
Mi permetto di linkare la mia recensione recente («Il Ponte», 9, 2010)
http://arrigomalera.blogspot.com/2010/09/rivolta-e-speranza.html
a sostegno di quanto dice WM1, c’è anche uno splendido articolo che andrebbe riscoperto “Il giusto tempo della rivoluzione” uscito su Resistenza. Giustizia e libertà», ottobre, 1970, p. 11
Lì lo Jesi militante indica in Luxemburg «il sogno di un rinnovato umanesimo» di stampo rivoluzionario:
«la rivoluzione non sarà una nel tempo: […] l’emancipazione dal condizionamento borghese, che prelude alla duratura conquista del potere, sarà raggiunta solo se le eredità borghesi […] verranno colmate dal proletariato di una rinnovata qualità morale, tale da consentire di rivolgere contro la borghesia le sue stesse armi, di superare l’antinomia fra pensiero per sé e pensiero per gli altri, vita a sé e vita con gli altri […]. Stabilire quale sia il tempo della rivoluzione è contribuire a renderlo prossimo».
Contro «un senso della storia super-umano» si tratta di far valere il fatto che «gli uomini “fanno da sé” la storia» e di considerare l’«utopia» come «concreto alimento ideologico dei movimenti rivoluzionari esterni alla Russia», un’utopia che «un concreto pessimismo distingue da quelle della rivoluzione riuscita una volta per tutte».
In altri termini:
l’utopia è, conformemente alla sua origine letteraria, strumento di critica sociale dell’esistente: dall’immaginazione mitica viene la spinta ad agire nella storia per realizzare un progetto collettivo teleologicamente orientato all’emancipazione. Il che in termini pratici voleva dire opporsi al classico marxismo-leninismo, rifiutare tanto il socialismo reale di stampo sovietico quanto l’approccio socialdemocratico e nello specifico la linea politica del Partito comunista italiano. Per l’area della Nuova sinistra libertaria in cui Jesi cercava la propria collocazione, insieme a Tito Perlini e altri, la teoria luxemburghiana era un punto di riferimento in questo senso.
@valter
Carchia era un filosofo straordinario e la sua morte prematura (anche lui…) ha impedito che venisse fuori adeguatamente: è in sintonia con Jesi, entrambi torinesi furono allievi di Albino Galvano e Carchia, più giovane allievo di Vattimo e in accademia a Torino, faceva molti seminari con i materiali di Jesi, di cui sono rimaste tracce.
Sul rapporto mito e letteratura, filosofia romantica del mito etc etc e rapporto con la Mythos Debatte (su tutti Hans Blumenberg, Elaborazione del mito, 1979) vanno assolutamente insieme.
Così Carchia:
«Mito […] se anche si dischiude nell’umano è però il suo trascendimento: […] riconoscimento insieme della radice naturale dell’uomo e del carattere oltreumano dello spirito. Il mito è […] la consapevolezza che la verità per l’uomo è sempre un accadere, qualcosa che si dà attraverso narrazioni, metafore simboli ma insieme, è la consapevolezza che narrazioni, metafore e simboli non sono la verità. […] Una filosofia del mito che non sia semplicemente il nostalgico rivolto della ragione demitizzante non si può pensare altrimenti che come un’esperienza del presente.»
in Mito, Esperienza del presente e critica della demitizzazione, «aut aut», n. 243-244, (a cura di G. Carchia e M. Pezzella), la Nuova Italia, Firenze, 1991
@ Arrigo
giusto, la citazione del carteggio con Kerenyi nelle recensione è fuori luogo.
@ Arrigo e WM1
Può sembrare paradossale, ma in “Spartakus” Jesi critica proprio l’elemento utopico per eccellenza che è insito nel marxismo, ossia l’eventuale (non certo ineluttabile) futura conquista dell'”età dell’oro”: il comunismo.
Quando nel libro Jesi parla dello “pseudomito dell’età dell’oro” non si riferisce al comunismo primitivo e ai bei tempi che furono, ma al comunismo prossimo venturo, figlio della rivoluzione. Leggo: “Così va inteso il futuro dell’assoluto marxista: non l’estremo futuro, l’età d’oro, ma il giorno che viene subito dopo l’oggi, il giorno in cui forse il dolore dell’oggi si trasformerà in bene. Bene relativo, futuro relativo: la coscienza della maggior parte degli attivisti del marxismo massimalistico non sfugge a questa limitazione.” (Jesi, “Spartakus”, pag. 87).
Bene relativo, futuro relativo. Certo. Bisogna vedere QUANTO relativo. E’ necessario lottare qui e ora per il pane e il lavoro, ma se si abbandona la visione strategica del conflitto per il raggiungimento dell'”estremo futuro” – l’età dell’oro, l’utopia, la rivoluzione – non resta che il riformismo, per quanto radicale. Dal mio punto di vista (molto di parte) la Nuova Sinistra, cioè l’area a cui si avvicinò Jesi uscendo dalla CGIL, affossò “l’utopia” insieme ai socialdemocratici che giustamente combatteva, e arrivò a teorizzare il “contropotere”, ossia la possibilità di gettare le basi qui e ora della nuova società senza passare dal via, cioè dalla rottura rivoluzionaria. Quest’abbandono del grande sogno (frutto anche della ripulsa per gli orrori dello stalinismo)contagiò all’epoca quasi tutte le avanguardie, tanto che anche Camatte – teorico bordighista! – finì per ritirarsi in una specie di comune hippy fuori città…
Ci credo che oggi il nostro “immaginario mitico” è così debole. I nostri predecessori hanno gettato alle ortiche l’utopia e ci hanno lasciato solo l’ANTI.
L’antifascismo, l’antirazzismo… benissimo. E poi?
@ Giacomo,
qui ovviamente tocchiamo divergenze – strategiche e filosofiche – di fondo.
Per me una rottura rivoluzionaria non può che porsi nell’immanenza dei conflitti. E, appunto, non è mai assoluta, non può esserlo. Non esisterà mai LA cesura rivoluzionaria definitiva, la mitica “volta-per-tutte”, la Frattura che ci porterà per sempre in una condizione irreversibilmente libera da ogni alienazione, in uno stato di perenne auto-realizzazione e felicità collettiva. Sarebbe la fine di tutto, di ogni trasformazione e dialettica, della stessa condizione umana. Questo comunismo (che io immagino noiosissimo) ricorda una sorta di “equilibrio termodinamico”, che noi sappiamo essere uno stato inerte e indifferenziato.
Per me il movimento al comunismo è simile a un asintoto, un avvicinarsi indefinitamente. Galeano lo ha spiegato molto bene ricorrendo alla metafora dell’orizzonte. Il comunismo è l’orizzonte, io continuo ad avvicinarmi a esso, passo dopo passo, senza mai raggiungerlo, perché il mio stesso avanzare lo sposta in avanti.
Anche questa è una bellissima narrazione, certamente non meno bella di quella dell’Età dell’Oro.
Le rotture rivoluzionarie non avvengono necessariamente “hic et nunc”, ma certo in un tempo “terreno”, immaginabile, “praticabile”.
Il mito utopico/chiliastico della vittoria *definitiva* (con ingresso in una “Storia oltre la Storia”, una specie di Tempo Sacro) ha certamente agito da sprone per la lotta, da catalizzatore di speranze collettive, ma è stato anche il più facilmente tecnicizzabile, e quindi il più frequentemente tecnicizzato. Nella sua versione secolare e marxista rivoluzionaria, questo mito ha nutrito due opposti “deviazionismi”:
1) l’iper-soggettivismo insurrezionale soreliano;
2) l’attendismo eterno che in nome di un comunismo talmente perfetto (chimicamente miracoloso!) da essere inconquistabile sacrifica ogni “risultato apprezzabile anche se non assoluto”. Vedi gente tipo “Lotta comunista” etc.
[Per non dire della narrazione anarchica, in cui il potere sembra una specie di malattia che l’umanità ha contratto non si sa bene come e da cui un giorno potrà guarire per sempre! Ma per favore…]
L’Età dell’Oro non si situa esclusivamente nel passato ancestrale né nell’estremo futuro, ma in un tempo *altro*, inesperibile, sottratto al continuum delle nostre vite. E’ trascendenza, non immanenza.
In quel passo di Spartakus Jesi pone l’accento sulle “provvisorie e parziali conquiste di benessere e conquista sociale” perché sta facendo una critica (nello specifico) a come Eliade descrive il marxismo e (in generale) alla rivolta spontaneista. Sta insomma, in un colpo solo, colpendo il pensiero trascendente di destra e il primo “deviazionismo” di cui dicevo sopra.
Se ci fosse meno determinismo antropologico, cioè se si pensasse che ci si avvicina alla redenzione non solo grazie ad una de-strutturazione materiale del dominio ma anche ad una catarsi interiore (in realtà le due cose sono la medesima, ma è il primato della libertà sull’oggettività delle condizioni materiali) sarei (ancora) dei vostri.
Temo che l’anarchismo sia più vicino al mio modo di pensare, ma l’ineluttabilità del dominio per me è meno misteriosa, perchè in una narrazione mitica che la ragione declina in teologia si chiama peccato originale.
Un abbraccio fraterno e commosso a tutti quelli che hanno scritto in questo thread.
Valter, a me certa teologia interessa. Ad esempio, mi interessa la riflessione “di sinistra” – è solo per rendere l’idea! – sulla teologia politica: Benjamin, Scholem, Taubes, Badiou, Tronti, Agamben, il gruppo “Epimeteo” etc. E non precludo a nessuno un pensiero del trascendente, anzi: il trascendente va pensato. Non fosse altro per capire cosa sia l’immanente.
Quello che *non* mi interessa è riproporre versioni “laicizzate” dei miti dell’Origine, della Caduta (the “fall from grace”) e del Ritorno all’armonia perduta.
Ad esempio, nel primitivismo il Peccato Originale è riproposto in forma di separazione dall’Eden paleolitico, con la rinuncia alla nostra “ferinità”. Tutti i nostri guai cominciano con la stanzialità e l’agricoltura. Abbiamo offeso Madre Terra etc. Dobbiamo riconquistare la nostra ferinità, attaccare la tecnologia, riorientarci verso comunità di cacciatori-raccoglitori (anzi, loro dicono “raccoglitori-cacciatori”) etc.
Altrove ti ho visto scrivere (e come sai sono d’accordo) che Marcuse ha un approccio “semplicistico”; che dire allora di questi altri, che al suo confronto sono dei punkabbestia?
Nemmeno di fronte a questo genere di narrazioni credo sia fecondo l’approccio “demitizzante”, la semplice dimostrazione del loro “non-stare-in-piedi” etc. Credo che si debba essere affermativi, non negativi, cioè: raccontare la civilizzazione (le civilizzazioni) in altri modi, con altri sguardi. Sviluppare narrazioni alternative a quelle della Caduta, che poi sono attigue alle narrazioni della Decadenza: c’è sempre un passato lontanissimo in cui tutto era armonia, e un certo punto, zac!, ci sono cadute le balle a tutti quanti! :-O
Ovviamente, per un credente c’è piena libertà di tematizzare il peccato originale, di interrogarsi su esso etc. E c’è piena libertà di credere al giudizio universale. Quella che voglio evitare è una certa coazione a ripetere che porta a traslare quel pensiero (tra l’altro, in forme meno consapevoli e più misere, povere di mistero) in ambito politico. L’interesse per la teologia politica deriva anche dalla voglia di evitare trasposizioni coatte e impoverimenti.
Sulla questione della libertà, la mia posizione è questa: io come soggetto sono tanto più libero quanto più sono consapevole di quel che mi condiziona, determina e riproduce come soggetto. Sono libero di fronte al mito se so che è in funzione una macchina mitologica. Sono libero nelle mie scelte se tengo per inteso che sono condizionate da dispositivi (socio-economici, politico-giuridici, culturali in tutte le accezioni del termine). Sapendo come funzionano questi dispositivi, posso cercare i loro “punti ciechi”, le zone in cui il loro funzionamento è difettoso, meno stringente, più impacciato.
@tutti
quando si tratta di delineare scenari attuali mi trovo in difficoltà, mi trovo più a mio agio con la diagnosi e l’analisi storicizzante, per scoprirmi ‘messianicamente’ in attesa di qualcosa alla Benjamin, sapendo che sta all’umano realizzare questo qualcosa.
Anch’io penso alla ‘rivoluzione’ in termini di un asintoto, o di un ideale regolativo, una filosofia del ‘come se’, parafrasando Kant e usandolo in termini politici: un obiettivo che serve per tenere alto lo sguardo, da realizzare di volta in volta nelle condizioni storiche contingenti, ognuno/ogni soggetto politico collettivo come può.
Una dei miei ‘mantra’ preferiti è la «rivoluzione che comincia a casa, preferibilmente davanti allo specchio del bagno» di cui cantavano gli Hüsker Dü di Bob Mould in Warehouse songs and stories, 1987, e con questo anch’io credo nella ‘catarsi interiore’ come pre-condizione di ogni cambiamento sociale.
E questo mi piace di Jesi, che quando arriva a delineare modalità pratico-operative, da uomo di cultura decideva di optare per un sapere critico, l’ironia e la parodia che salvassero il meglio della tradizione umanistica, rilanciando una mitologia-narrazione (che implica anche la sua critica) e che sia discorso dell’immaginazione che ‘lega senza fondare’. Certo è un gioco in difesa, che si limita ad additare benjaminianamente «nuove forme di soggettività che attendono di essere istituite».
Ha ragione anche Bardok quando fa notare che questa stessa posizione e il meglio di tanta cultura umanistica e post-strutturalista hanno tralasciato la scienza, condannando il positivismo migliore a ‘riduzionismo scemo’ e scegliendo la metafisica, anche nella sua decostruzione, come discorso, piuttosto che la scienza: e lo dico da ignorante, cresciuto nella cultura europea rimasticata in Italia, che oggi vorrebbe sapere qualcosa delle basi neurali della coscienza e di un naturalismo olistico non riduzionista che si associ all’antropologia materialistica (per questo apprezzo molto i territori solcati da WM quando parla di Lakoff, ma anche Sacks etc etc).
Sugli intellettuali anni settanta e sulla contro-cultura che ci impedisce di costruire:
hanno sbagliato nel momento in cui pensavano che la scrittura post-metafisica fosse intrinsecamente rivoluzionaria. Cioè che minando le logiche della metafisica ne derivasse necessariamente la rivoluzione.
Per intenderci certi passi di Jesi sono da mal di testa, e ci passi le giornate a sbattere la testa contro il muro, al punto che molti lo reputano incomprensibile.
Un certo stile ‘alla Derrida’ e un malinteso relativismo post-modernista di cui anche Foucault è responsabile hanno allontanato molte persone dalla filosofia, mentre gli storicisti e gli accademici della crusca rimanevano tali e certo non si ‘convertivano’ al materialismo;
in più, se molti l’avevano previsto, quasi tutti erano impreparati a fronteggiare adeguatamente la manipolazione ideologica dei mezzi di comunicazione di massa, che retroagisce sulle capacità cognitiva delle generazione successive da essa forgiate.
Ricambio l’abbraccio comunitario
@arrigo e altri
se si pensa allo strutturalismo (non il post-) come una continuazione – con ben altre armi – del progetto positivista, e se si pensa in particolare al modo in cui Althusser legge Marx attraverso la lente del problema del rapporto scienza/ideologia, diventa impossibile trattare la questione politica della macchina mitologica senza tematizzare il “mito” moderno della scienza e della sua macchina giuridica e politica, di cui si è celebrata forse prematuramente la scomparsa (non cogliendone le metamorfosi), ma anche del progetto marxiano.
Sulla scrittura post-metafisica: altro che rivoluzionaria! è diventata la base materiale del capitalismo avanzato, della disseminazione del consumo. Se Badiou è sembrato a molti così necessario, è proprio perché la sua “teologia politica” (paolina) si basa sulla posizione del problema della produzione delLE verità, ovvero sulla rifondazione della filosofia CONTRO l’opinione (sì, ancora una volta…). E non credo si tratti di un mito come un altro, se non altro perché è quello di chi appartiene a quella tradizione materialista che intende il pensiero come una prassi rivoluzionaria e cerca in questa direzione la produzione del legame sociale: nella direzione in cui scienza e immaginazione non sono opposte
@ Tutti
non butterei Foucault nel mucchio: soprattutto negli ultimi anni intuì gli “inghippi” di cui stiamo parlando e cercò di imporre al suo lavoro una svolta, non più focus su discorsi e dispositivi, ma focus sul soggetto (ebbene sì, glielo riconosce anche Badiou in Piccolo pantheon portatile), sulla verità (la “parresìa”), sulle possibili pratiche di libertà per sfuggire all’inesorabilità dei discorsi di un’epoca. Ivi compreso il discorso postmodernista/relativista, fatto di inesistenza della verità e totale arbitrio delle interpretazioni.
Nonostante la vulgata su di lui, quel discorso è *l’esatto contrario* di quanto Foucault sosteneva e metteva in pratica. Foucault si prefiggeva, nello studiare un’epoca, un discorso e una disciplina, di individuare il *preciso significato*, la *verità* del discorso di quella disciplina in quell’epoca. Lo dice meglio di me Paul Veyne nel suo recente libro dedicato al suo vecchio amico, Foucault: il pensiero e l’uomo.
Non possiamo dire con certezza in quale direzione sarebbe proseguita la sua ricerca, ma secondo Badiou, par di capire, presto o tardi avrebbe ri-incrociato la strada delle filosofie del soggetto, e affermato con chiarezza che la sua preoccupazione era sempre stata l’universale. Che, anche qui nonostante la vulgata, Foucault non rigettava a priori; semplicemente, diceva che un universale antropologico andava tenuto come ultima istanza, e solo se strettamente necessario, estremo approdo della ricerca dopo avere scartato ogni altra ipotesi.
@WM1, su una possibile teoria del soggetto in Foucault esiste questo ciclo di lezioni di Agamben:
http://www.youtube.com/user/egsvideo#g/c/A2A023B42118C95D
che s’inserisce in un discorso più generale qui:
http://www.youtube.com/user/egsvideo#g/c/FC995510473C7566
Non ho ancora finito di vederli, ma sono pieni di ottimi spunti. In generale il canale youtube della EGS è una miniera d’oro…
@ eFFe,
sì, è vero, c’è un sacco di roba, hai fatto bene a segnalarlo. Si parva licet (Agamben è un grande della filosofia, io sono solo un lettore, un dilettante “infarinato”), le letture agambeniane di Foucault hanno alcuni passaggi e aspetti che mi perplimono, comunque ben vengano.
Che quella di Foucault sia una filosofia del soggetto, secondo me davvero non ci piove. Certo, non è una filosofia del Soggetto Sovrano e Autodeterminato, dell’Uomo con la U maiuscola Protagonista della Storia, ma il rapporto tra potere e libertà, tra “produzione di soggettività” e libera scelta, è *il* tema di fondo di tutte le sue riflessioni.
grazie per la segnalazione e il giusto raddrizzamento del tiro: sono stato ingeneroso con Foucault e tranchant.
Quello che volevo dire che il genere letterario filosofico post-moderno che affronta la complessità in alcuni casi è reso astruso da un uso spericolato della sintassi e della scrittura creativa, che rendono un cattivo servizio alla filosofia e ne facilitano la trivializzazione e il fraintendimento; peraltro apprezzo quella cultura (che mi ha vaccinato dalla metafisica idealistica e dall'”ontologia della presenza”, ovvero il fatto che ci sia un essere che coincide tout-court con il linguaggio verbale) e la credo fondamentale e storicamente contestualizzabile,
così come credo nella buona fede e della sincera militanza intellettuale e pedagogica di quella generazione,
oggi però bisogna, almeno in certi contesti fare un passo indietro, perché sempre meno allievi sia di scuola superiore che di università (vedo e sono costretto anche a valutare entrambe le categorie) abbiano gli strumenti per affrontare direttamente quei testi e in genere la letteratura filosofica.
a proposito di sintassi a rotta di collo: ci riprovo, scusate
‘oggi però bisogna, almeno in certi contesti fare un passo indietro, perché credo che sempre meno allievi sia di scuola superiore che di università (vedo e sono costretto anche a valutare entrambe le categorie) abbiano gli strumenti per affrontare direttamente quei testi e in genere la letteratura filosofica.
sul passo indietro, o due in avanti
Quella generazione – non solo Foucault, ma anche il miglior Deleuze ecc. – è stata una generazione straordinaria, ma forse nella sua opera non ha lasciato trasparire a sufficienza quali fatica e disciplina hanno posto le condizioni della loro produzione intellettuale.
Il loro lavoro, così importante e pieno di promesse, era pur sempre il prodotto di una formazione fortemente castrante, e il loro pensiero costituiva – all’interno di quella – uno straordinario atto di liberazione. Ma ciò da cui si sono e ci hanno liberati erano forse (anche) le condizioni di produzione materiale di quel pensiero. Resta insomma il problema di come sia pensabile un legame sociale senza (infrazione della) legge; o come direbbe Zizek in psicoanalitichese: se il super-io ti dice “godi!” non c’è niente che puoi fare per liberartene.
Balibar ricorda che Althusser, proprio mentre studiavano insieme Marx, li invitava tutti a farsi seriamente il culo su Hegel, prima!
L’imperativo “Godi!” da parte del super-io/Capitale.
Berlusconi è una perfetta antropomorfosi di tale imperativo. Berlusconi separa il Padre (la figura istituzionale di capo del governo) dalla Legge. Tutta la sua condotta e il suo linguaggio esortano a sciogliere la legge, a ignorare ogni limite, a condonar(si) qualunque infrazione (purché non intacchi la proprietà, ovvio):
“Italiani che mi votate, non c’è nulla di male a evadere le tasse, andare con le ragazzine, fare i falsi in bilancio etc. Italiani che mi votate, io dico che uno può fare quel cazzo che vuole!”
Di fronte a questa retorica rovesciata (un Potere puttaniere, pappone, “libertino” e caciarone anziché sessuofobo, castratore etc.), ogni discorso anti-repressivo, genericamente libertario, da Reich a Marcuse all’anarchismo, ogni appello alla liberazione del “principio del piacere” è condannato, se non alla superfluità, quantomeno all’inefficacia, perché è un’opzione di cui il potere si è già appropriato. E questo lo avevano capito bene, arrivandoci ciascuno per la propria via, proprio Foucault e Pasolini.
Credo che a un andazzo così si possa iniziare a rispondere, appunto, con il rigore, l’autodisciplina, il senso del limite, e una *etica del lavoro*, espressione – per comprensibili motivi – disprezzatissima presso la generazione di cui stiamo parlando, da Toni Negri a De Andrè: “A un Dio fatti-il-culo non credere mai” etc.
“Etica del lavoro” intesa come la spiegavo qui recensendo un libro di Philopat:
http://www.wumingfoundation.com/italiano/Giap/nandropausa11.htm#34
«…storie di persone che si sbattono insieme. Mi torna alla mente Diesel di Eugenio Finardi: “E io amo questa gente che si dà da fare / che vive la sua vita senza starsela a menare”. Ecco, Philopat racconta di gente che si dà da fare: si dà da fare a scoprire, a occupare e gestire, resistere e rilanciare, produrre e creare, tenere contatti.
Quella a cui dà voce Marco, in fondo, è una robusta etica del lavoro. L’affermazione suonerà paradossale, ma è perché in italiano con la parola “lavoro” si indicano troppe cose diverse. Qui con “etica del lavoro” intendo lo sbattimento per qualcosa che si ritiene importante, la soddisfazione di vedere premiati i propri sforzi, la gioia di avere fatto bene qualcosa, la spinta a fare ancora meglio la prossima volta, senza deludere chi ti sta accanto o di fronte e crede in te.
Eh sì, mica ne esiste una sola, di etica del lavoro. C’è quella del “buon viso a cattivo gioco”, autoillusione che indora la pillola e fa accettare un impiego infame, e poi c’è l’altra, che è anche quella dei punx, di chi gestiva il Virus, di chi mandava avanti le autoproduzioni, di band come i Contropotere che si smazzavano duecento concerti e decine di migliaia di chilometri all’anno, spingendosi fin nei posti più sperduti per aiutare piccoli collettivi etc.»
X Wu Ming 1
Guarda, di De Andrè mi viene in mente anche quella canzone che adoro (a dire il vero mi piacciono tutte): “Il fannullone”. Ma credo che l’etica del lavoro che intendi tu la praticasse pure De Andrè che s’impegnava in qualcosa che amava fare come le band che hai menzionato, come anche gli scrittori, gli attori, i registi e tutti quelli, artisti o no, che hanno la fortuna di poter fare qualcosa che amano e possibilmente riuscire anche a viverci.
Sbattersi facendo ciò che piace e in cui si crede e ben diverso che sbattersi facendo qualcosa che non piace e in cui non si crede.
sbattersi per qualcosa in cui si crede, e se fosse questa la liberazione del principio del piacere?
La vecchia “etica del lavoro”, sacrificale e rinunciataria, fu criticata giustamente da De Andrè e molti altri. Il verso riportato viene da “Coda di lupo”, e il “dio fatti-il-culo” è Luciano Lama nelle vesti di generale. In visita all’università, invita gli indiani/studenti a fare come quegli indiani/operai che hanno già deposto le asce. Il minimo che si possa dire è che non fu molto convincente… Come risposero gli arringati è cosa nota:
http://www.youtube.com/watch?v=5P_UAydblTQ
Correggo un’imprecisione, Paolo: dobbiamo liberarci dell’imperativo “Godi!”, non del principio del piacere. Senza quest’ultimo, non potremmo nemmeno “sbatterci facendo qualcosa che ci piace” :-)
L’art.54 della Costituzione che mi dice che devo lavorare con “disciplina ed onore” e la spiegazione che mi ha dato Maurizio Viroli mi ha pienamente convinto:
l’onore non si intende essere uomini d’onore ma è l’onore degli onesti, il riconoscimento dovuto a chi rispetta i principi dell’onestà e non quelli di un particolare rango.
Il concetto di disciplina nulla ha in comune con l’insieme delle tecniche costrittive che Foucault descrive in “Sorvegliare e punire” ma (ovviamente) come “consapevole e lucida assimilazione della direttiva da realizzare” (Gramsci)
Ci si sente un po’ Grunf del gruppo TNT ma la Costituzione è sempre la Costituzione.
p.s.
scommetto che la nota sul frattempo è nata da una mia domanda sulle donne – manager a wm4 a Modigliana, mi sa che ho fatto traboccare il vaso a Modigliana, sorry :-)
la chiave a stella?
mi viene in mente anche mario rigoni stern, quando diceva: “una catasta di legna, tirata su bene in squadra, e’ bella”. ed e’ vero. anche gli attrezzi da lavoro sono belli. e’ possibile raccontare il lavoro? intendo dire quello non alienato, quello come potrebbe essere e come talvolta e’. sento confusamente che in questi tempi, tra ruby e marchionne, su questo tema c’e’ un grande vuoto di narrazione.
Beh, il progetto di Gilbert Simondon era più o meno questo: un’etica e una politica della “technicité”, ovvero del lavoro all’altezza di ciò che state dicendo voi, inteso come continuazione indefinita del processo di ominizzazione, e iniziato appunto – secondo la lezione di Leroi-Gourhan – con la produzione tecnico-simbolica (cfr. soprattutto *Du mode d’existence des objets techniques*). Oggi Bernard Stiegler vorrebbe continuare su questa strada…
Mi sa che ci stiamo rapidamente allontanando dal focus – seppure vasto – della discussione, che era: Jesi, il mito, le tecnicizzazioni etc. Io a questo punto attenderei l’uscita del volume, per riprendere tutte le questioni.
@ Bardok
va bene, però la prossima volta riassuntini + link divulgativi. Non può bastare il name-dropping, altrimenti diventa un gioco elitario ed escludente…
Ma se un neofita volesse cominciare a leggere Jesi (prima di affrontare Riga) in modo graduale, da cosa dovrebbe iniziare? Non potete suggerire una bibliografia minima, 2/3 titoli, please?
Insomma un po’ di ABC per noi che ci siamo sentiti, nel leggere i commenti, degli ignoranti globali…
@ WuMing1
hai ragione, chiedo scusa, ho contribuito a “sfocare”
chiedo scusa anch’io. la discussione e’ molto interessante e sto imparando un sacco di cose.
grazie ancora a tutti per l’attenzione, dopo tre anni che mi scortico il cervello su queste cose sapere che ci sono lettori/trici attenti/e è un balsamo, e mi conforta, visto che anche io sono un post-moderno calvinista cognitivo asceta del lavoro intellettuale con mania di perfezionismo e ansia da prestazione, e ho rischiato alcune derive autistiche non da poco…
Detto questo: per avvicinarsi a Jesi, con il taglio che abbiamo evidenziato, io partirei, come entry level, per Attualità e per facilità di reperimento da
– L’accusa del sangue (1973), Bollati 2007,
– Mito (1973), la cui edizione più recente è Aragno 2009, altrimenti Mondadori 1989 si trova ancora nelle bancarelle
– Cultura di destra (1978), Garzanti (1993)
poi, per la critica letteraria e un po’ più complessi,
-Lettura del ‘Bateau Ivre’ di Rimbaud (1972), Quodlibet, 1996
– Esoterismo e linguaggio mitologico (1976), Quodlibet, 2002
-Letteratura e mito (1967), Einaudi 2002
-Materiali mitologici (1978), Einaudi, 2001
a quel punto, se vi siete assuefatti,
– Spartakus (1967), Bollati 2000
– Germania segreta (1967), Feltrinelli 1995
– Mitologie intorno all’illuminismo (1972), Lubrina, 1990
quasi tutto ha ottime pre- o post-fazioni.
e comunque nessuno qui è ignorante, no davvero, penso lo sia chi non si fa’ toccare mai da nulla, non chi non conosce qualcosa che altri conoscono bene,
abbraccio comunitario
:-)
Bello anche il cammino formativo tripartito!
Dipende dal grado di consapevolezza che uno ha intenzione di raggiungere …
@ arrigo malera,
grazie delle indicazioni di lettura!!
Penso che passerò subito al livello 3: come ho fatto, da settecentista, a mancare “Mitologie intorno all’illuminismo”?
@ arrigo malera: ora mi stampo il tuo commento con i consigli di lettura graduali. Era quello che volevo. Grazie! ;-)
@arrigo malera
grazie per i consigli.
io son partito con Spartakus, solo perché in biblioteca era l’unico disponibile e l’ho preso. :-)
Ho cominciato a sistemare e pubblicare sul blog in inglese alcuni appunti sul “Potere Pappone” in Italia:
http://www.wumingfoundation.com/english/wumingblog/?p=1448
Sono intesi come un contributo utile agli stranieri, che non si capacitano di che cazzo stia succedendo qui da noi. Ho cominciato a prenderli in albergo durante l’ultimo mini-tour londinese. Che dite, ha senso tradurli anche in italiano?
non vorrai mica che gli stranieri ne capiscano più de noantri spero? Poi vabbe’, io di mio ci provo a leggerli in inglese.
Per quello che ne ho capito mi sembrano appunti interessantissimi, voto per la traduzione e pubblicazione in italiano.
Comunicazione di servizio, sul sito di «Riga» sono stati appena pubblicati dei pezzi che abbiamo escluso per motivi di spazio dal numero cartaceo. Li trovate nella sezione ‘extra’.
Dei bonus, insomma, tra tutti segnalo un bel ‘coccodrillo’ di Cesare Mannucci, scritto nel 1980 e un mio pezzo sulla ‘gastronomia mitologica’ che racconta lo Jesi più divertente, quello che usa il manuale di cucina di Escoffier per decostruire la scienza del mito,
Enjoy!
http://www.rigabooks.it/index.phpidlanguage=1&zone=9&id=853
@WM1 ho letto (qualcosa mi è sfuggito) e penso che abbia molto senso tradurre e pubblicare i tuoi appunti in italiano.
@arrigo malera ho provato e il link non funziona. Non so se è un problema del mio browser o se il link contiene un errore…
forse nel copia e incolla ho sbagliato qualcosa,
così dovrebbe funzionare
http://www.rigabooks.it/index.php?idlanguage=1&zone=9&id=853
e poi al fondo cliccare su ‘extra’ e compare un menu di sei articoli
@arrigo malera
ora funziona.
grazie
@wu ming1
ho letto la parte su Berlusconi, e sì, secondo me è utile che sia tradotta, riprende e amplia il discorso sul principio del piacere e sull’imperativo ‘Godi’ e affronta il discorso sulle scienze cognitive, cosa assai utile che vorrei approfondire.
grazie!
@ wu ming1
Mi sembra interessante l’idea di attivare in Italia una discussione seria sulla “ragione populista”, in parte nata in ambito anglofono dal libro di Ernesto Laclau, “On populist reason”, perché noi siamo proprio il terreno di coltura per una serie di sperimentazioni politiche “populiste” in un contesto di capitalismo avanzato (Laclau, esponente del postmarxismo british, con strumenti classici analizza la “presa” sulla massa del discorso politico di destra, e sostiene che sia necessario elaborare una contro-retorica populista di sinistra che si appoggi sulle istituzioni, in una prospettiva – credo – in senso ampio gramsciana).
E soprattutto mi sembra interessante il tentativo di costruire una convergenza tra psicoanalisi e scienze cognitive (le posizioni che tu hai riportato di Zizek-Lacan e Lakoff), quando invece i protagonisti del dibattito si sono invece esplicitamente chiusi le porte in faccia. Mi sembra che le potenzialità di lettura politica da parte di una psicoanalisi in grado di guardare in faccia il lato “duro” della psicologia sperimentale siano ancora molte.
Tuttavia, oltre al Lacan-Zizek del Godimento superegoico che tu citi, mi sembrerebbe importante considerare il Lacan dei “4 discorsi” (Il seminario XVII, Il rovescio della psicoanalisi, del 1960-70, contemporaneo alla teoria dei discorsi di Foucault), che mostra come l’oscillazione dal discorso del padrone al discorso dell’università (altrove, con qualche variazione, “del capitale”) è un’oscillazione strutturale al potere: non c’è un’alternativa ma un gioco di rimando continuo tra potere patriarcale che usa la legge per nascondere il godimento e apertura capitalista al godimento come fonte energetica per il consumo compulsivo delle merci. Il “doppio” discorso del Berlusq sembra davvero una geniale sintesi tra discorso ufficiale del padrone moralista e discorso nascosto del compagno di merende: che incanala l’impulso rivoluzionario nel mercato delle magliette del Che e nella retorica libertaria (del tipo: “Guardate come sono democratico: lascio che tutti mi critichino liberamente!”). In questo senso il discorso di Berlusq sembra la continuazione coerente del nuovo patto tra stato e capitale (che forse negli anni ’90 in Italia è stato “felicemente” siglato) che Lacan intravedeva il 3 Dicembre 1969 quando, durante un incontro molto polemico con gli studenti a Vincennes, criticava la prospettiva “progressista”:
«i primi a collaborarvi, e proprio qui a Vincennes, siete voi, perché svolgete la funzione di iloti di questo regime. Non sapete nemmeno che cosa vuol dire? Il regime vi mette in mostra. E dice – Guardateli godere».
Scusate se intervengo après coup, ma è da giorni che lotto per spuntare una password.
Mi dichiaro amico e collega di Arrigo Malera, grazie al quale sono venuto a contatto con l’esistenza, se non ancora il pensiero, di Furio Jesi.
Ho studiato a Vincennes-Saint Denis con Badiou e sono un deleuziano pentito (non al punto da non continuare a trovare in nonno Gilles inesauribili spunti di gioia e resistenza).
Mi sono poi avvicinato alla scienza cognitiva e lì ho finalmemnte trovato una residenza agevole.
Per farla breve, è da più giorni che desidero chiedervi – a proposito di materialismo e rifondazioni razionali della filosofia – se conoscete, e che ne pensate, la lettura di Lévi-Strauss fatta dal suo allievo Dan Sperber, che è il mio orientatore relativamente alla Critica della cognizion rilevante: http://www.cognitionandculture.net/Dan-s-blog/levi-strauss-in-a-cognition-and-culture-perspective.html
Su psicanalisi e scienze cognitive, mi sentirei di sconsigliare Zizek (anche per averne tradotto un libretto) e di consigliare piuttosto, per chi volesse tentare sintesi tra discipline finora ben poco comunicanti, di dare un’occhiata alla cosiddetta “neuropsicanalisi”.
Vittorio Gallese, che è uno deigli scopritori dei Mirror Neurons se ne interessa: non è filosoficamente rigoroso, almeno dal punto di vista dei filosofi cognitivi, ma quello dell’intersezione neuro/psico è un terreno interessante che varrebbe la pena non lasciar colonizzare ai soli tecnocognitivisti.
Volevo scrivere: “sulle scienze cognitive mi sento di sconsigliare Zizek”…
Ma in effetti anche sulla sua varietà di lacanismo ci sarebbe forse da ridire.
[…] Per conoscere Furio Jesi. Un’anteprima […]
@Deleuze
grazie per le indicazioni. Personalmente non so nulla di Dan Sperber, ma la questione mi sembra interessante, e parzialmente nello spirito (qualche volta anche nella lettera) delle ricerche di Lévi-Strauss.
Ricordando però che l’inconscio è “fuori”.
A proposito di quel che diceva Bardok sul fatto che (lo dico con parole mie) certa retorica post-strutturalista è oggi pervertita a lingua del capitale, vi segnalo che Fare Futuro cita Deleuze e si è appena inventata il “patriottismo rizomatico”:
http://www.ffwebmagazine.it/ffw/page.asp?VisImg=S&Art=9951&Cat=1&I=immagini/Foto%20L-N/noicredevamo_int.jpg&IdTipo=0&TitoloBlocco=Politica&Codi_Cate_Arti=27&Page=1
@ Deleuze (il commentatore amico di Enrico, non il filosofo preso in ostaggio dai finiani)
grazie delle indicazioni. Su Zizek, non giudicare da un “librettino”, i suoi scritti “instant” e d’occasione sono a volte ripetitivi, anche tirati via, e il gusto per le boutades a volte gli prende la mano, ma i suoi testi più densi contengono molte cose interessanti, da lì in un modo o nell’altro bisogna passarci, se si vuole mappare (e mettere a buon frutto) il pensiero radicale contemporaneo.
Straordinario l’innesto Deleuziano! “Il rizomatico in un solo paese” è davvero un’invenzione sconcertante… ma che spiega molte cose.
Su Zizek “The sublime objetc of Ideology” e “Il soggetto scabroso” mi sembrano fondamentali (un po’ meno “The parallax view”), il resto è spesso copia-incolla, ma ovviamente non ho letto tutto.
@WuMing1
A proposito delle diverse rappresentazioni che abbiamo di Lacan, non so se hai letto di J. A. Miller,” I paradigmi del godimento” (solo il primo saggio del libro, intendo). Mi sembra fondamentale per una discussione sul concetto di godimento che si sta utilizzando nell’altra discussione su Berlusq, e che forse non tutti sanno essere una rielaborazione del concetto di pulsione di morte. Penso che su questo valga la pena di passare direttamente attrverso Lacan bypassando Zizek, e il saggio di Miller è una buona via d’entrata.
Lascio qui questa considerazione: decidi tu se l’invito sia troppo “accademico” per essere utile a quella discussione.
Nel precedente post:
non “su” Zizek, ovviamente, ma “di” Zizek
Ho letto alcune cose di/su Miller. Mi sembra importante l’idea che la costruzione di un’etica debba fondarsi sull’assunto che (taglio con la mannaia!) siamo tutti “psicotici”, cioè abbiamo tutti un rapporto squilibrato col simbolico, e lenire questo “male” è il fine di una ricerca di ethos da parte del singolo. Ho capito bene? Se ho capito bene, mi conferma che, anche procedendo per vie diverse, si può arrivare a destinazioni simili, perché – sia chiaro: con tutt’altre premesse e tutt’altro quadro concettuale – io qui ci ritrovo la stessa tensione dell’ultimo Foucault.
Sì, per Lacan un rapporto equilibrato con il simbolico sarebbe l’adesione incondizionata all’ordine sociale, la garanzia della riproduzione sociale della perfetta corrispondenza tra principio del piacere e principio di realtà nell’organizzazione pubblica – la governance – del “servizio dei beni”. Insomma l’oppio laico dei popoli. Ma (per fortuna!) la pulsione di morte “irrompe” nell’ordine simbolico, questo accade anche quando il super-io (che pure ha fondato quell’ordine) inizia a distruggerlo con imperativi irrealizzabili. Quando la pulsione di morte si presenta sotto la forma dell’imperativo “godi” la situazione diviene paradossale: il godimento va sempre contro la legge, eppure qui si ha una legge che ti obbliga a godere, e questo produce un mare di sintomi.
Ora, da questo gioco l’individuo non può uscire, perché avviene su di un’altra scala, la scala che produce appunto individuazione.
Ma ci sono molti modi di giocarlo, e questo (mi par di capire) è ciò che tu intendi – foucaultianamente – per “ricerca di ethos da parte del singolo”. Ecco, direi che corrisponde abbastanza a ciò che Lacan intendeva dicendo che “bisogna saperci fare con il sintomo”.
Secondo Badiou (lo scrive in “Piccolo pantheon tascabile”, dove la testimonianza personale su Foucault è una delle più toccanti), se non fosse morto così bruscamente, lasciando interrotti così tanti filoni di ricerca, presto o tardi Foucault avrebbe “fatto i conti” con Lacan, si sarebbe cimentato con quelle teorie. Un interessante “what if” del pensiero. Non mi pare implausibile. Tu che ne pensi?
Mi scuso innanzitutto per la lentezza della replica… che sarà peraltro deludente.
Non credo proprio di avere una risposta fondata, non conosco abbastanza bene Foucault. Diciamo che, detta da Badiou, la cui opera da “Teoria del soggetto” in poi è davvero una “resa dei conti” con Lacan, l’affermazione suona un po’ una proiezione. D’altra parte tutta quella generazione ha dovuto fare i conti con Lacan, e non so se nei testi di Foucault si possa trovare più di qualche traccia sul suo modo di farli.
Però, però
potrebbe essere davvero una strada interessante, che indica peraltro una reciprocità di effetti: ho sempre pensato che Foucault avesse giocato un ruolo importante nel passaggio del vecchio Lacan (fine ’60) da una teoria del linguaggio a una teoria dei discorsi. Diciamo che sarebbe bello costruirci attorno un gruppo di lavoro! Negli ultimi anni ho lavorato quasi esclusivamente su Simondon, però conosco un po’ di gente che ha studiato molto approfonditamente Foucault leggendo anche parecchio di Lacan e Badiou. Se t’interessa coinvolgerli per una discussione online basta che tu mi faccia sapere, si può provare.
Magari aspettiamo di avere le idee un po’ più chiare. Comprese le idee su come evitare che diventi un tedioso pippone a più mani :-D Stiamo già tirando un po’ troppo la corda, e infatti in fondo a ‘sto thread siam rimasti solo noi due!
Comunque, negli ultimi corsi al Collège de France Foucault “scopre le carte” e dimostra che la sua è una filosofia del soggetto, senza possibili equivoci. E più di quanto lo stesso Badiou gli riconosca in quel testo (scritto a caldo dopo la morte di M.F., e con l’ipotesi finale basata quasi solo su uno stralcio d’intervista). Dopo anni trascorsi a studiare il funzionamento dei dispositivi e dei condizionamenti, Foucault va a fondo nelle possibili pratiche di “decondizionamento” da parte del soggetto (che per lui è il singolo). Un’autodisciplina, un “governo di sé”, una pratica di verità genealogicamente ispirata alla classicità greca e romana, con grande attenzione per i cinici, per gli stoici etc. C’è una tensione etica fortissima, anche un tentativo di fare i conti coi propri “demoni”. Non è implausibile quel che scrive Badiou. Va anche ricordato che Foucault in gioventù aveva studiato a fondo (e insegnato all’università) la psicanalisi, aveva conosciuto Binswanger e scritto un’introduzione al suo saggio sul sogno etc.
Sì, in effetti le pippe a più mani sevono di solito alle istituzioni per riprodursi in un ambiente sterile che non è il caso di ricreare artificialmente anche qui :), almeno non nella modalità “accademica”.
Conosco abbastanza l’ultimo Foucault per comprendere come la “cura di sè” sia soprattutto un’etica della sottrazione ai dispositivi di potere. Il punto è che nella psicoanalisi lacaniana il potere è proprio ciò che è costitutivo del soggetto… E a questo punto getto l’ultima braciola sul fuoco – ovvero un’altro personaggio del pantheon – il cui pensiero è fortemente aromatizzato alla psicoanalisi: l’assoggettamento di cui parla Althusser è anche soggettivazione (come la castrazione per la psicoanalisi), dunque è possibile vivere senza ideologia, ovvero come “processo senza soggetto” (come pura singolarità)? La risposta è no. E di questo un’etica della cura di sè deve farsi carico. L’ultimo Foucault se ne fa pienamente carico? Non so. Mi piacerebbe.
Ma a questo punto siamo decisamente off topic (si dice così, vero? perdona, sono un forumanalfabeta), e sono scomparsi tutti, quindi… a presto o tardi, anche altrove…
Il punto mi sembra essere questo: per Foucault non esiste soggetto fuori da ogni dispositivo, perché la soggettività è il prodotto di dispositivi, non è una condizione ontologica originaria. La soggettività è immanente, non c’è il Soggetto Sovrano indipendente. Però la soggettività, nel momento in cui comprende di essere giocata, condizionata, influenzata, *prodotta*, in quello stesso momento eccede il gioco, o acquisisce la potenzialità di eccederlo, di trovare i punti ciechi dove il dispositivo non funziona, e uscirne. Non uscire da *tutti* i dispositivi, ma metterne in crisi uno, riconfigurando quindi l’insieme, guadagnando spazio per manovre non prevedibili.
Beh, sì, il punto è proprio questo, non soltanto per Foucault, ma un po’ per tutti quelli che abbiamo citato sinora, fino ai viventi: Balibar, Badiou, Rancière. Diciamo che ciò che tu dici è proprio la base di una straordinaria discussione durata almeno 3oanni e sepolta lentamente nel corso del ventennio successivo (’80-’90).
Ciò per cui tutti questi avevano con tanta forza litigato tra di loro era però la strategia: come mettere in crisi i “dispositivi”? con una lotta di posizione o rivoluzionaria? si tratta di una lotta per la quale vale l’opposizione istituzionale/contro-istituzionale? è possibile costruire tecnicamente il legame sociale? la psicoanalisi da che parte sta? e la scienza? e il partito? ecc. ecc.
E nel frattempo i media hanno cancellato progressivamente lo spazio per quella discussione (la biopolitica ha cancellato, neutralizzato – insieme – menti e tempo). Se quei problemi ora sembrano riemergere qua e là, è forse perché la discussione può ora svilupparsi in spazi di tipo “politico”, contro le politiche della pura governance dell’economia. Solo in questi spazi quei problemi diventano sensati e percepiti come fondamentali.
Ma: è possibile aprire uno spazio “politico” su una scala più ampia? Forse l’emergenza ambientale potrebbe offrire oggi questa opportunità, se non ne affidassimo le soluzioni all’etica del capitalismo (peraltro ampiamente superata, almeno nella sua versione protestante)
…vabbè, tanto eravamo già fuori tema da un pezzo
Questo è *il* problema. Il problema dei problemi. Il meta-problema.
Direi di rimettere la palla al centro, e approfittare del prossimo post sul “Potere Pappone” per proseguire la discussione da quest’epicentro.
non sono più intervenuto ma ho seguito tutto, e imparato molto,
grazie
e
Ehi, “Riga” è uscito oggi! In libreria, oppure ordinabile dai link nel post quissopra.
[…] vecchia conoscenza: su Giap, a fine 2010, discutemmo della sua precedente uscita "jesiana", ovvero il n. 31 della rivista Riga, curato da lui e da Marco Belpoliti, interamente dedicato allo studioso torinese. Numero che resta […]