
Julien Auguste Hervè, «Ritratto di donna con mal di denti», olio su tela, 1900 circa.
[Mentre scrivevo la seconda parte del mio “portolano” Trecentonovantaquattro giorni (la prima è qui), alcune riflessioni su luoghi, corpi e scrittura hanno fatto reazione con recenti polemiche su letteratura e intelligenze artificiali. Quelli che dovevano essere due capoversi si sono allungati e sono diventati un testo a parte, fatto perlopiù di appunti, che vanno presi come tali, ma che ritengo utile pubblicare. A questo punto, la seconda parte di Trecentonovantaquattro giorni uscirà nei primi giorni del nuovo anno. Buona lettura. WM1]
«Quando restituisce un corpo, ecco: è poesia.»
Ottavio Fatica, Lost in translation
«Il capitale è il cancro di cui la specie rischia di morire prima di cominciare a vivere realmente. In questo senso, la rivoluzione è biologica»
Giorgio Cesarano, Manuale di sopravvivenza*
«Mentre l’intelligenza artificiale iper-appiattisce la cultura di massa, qualunque cosa mostri evidenze di umanità diventa qualcosa a cui aspirare.»
ANU, Aspirational Humanity
Qui potrebbero arrivarmi accuse di «antropocentrismo», balzane ma in voga tra gli apologeti dell’attuale modello di IA. Gente che quando va “bene” dà letture riduttive degli enormi problemi ecologici e climatici che quel modello esaspera, e quando va male – quasi sempre – li rimuove proprio dal quadro**.
La critica all’antropocentrismo è imprescindibile, ma ha senso solo se declinata in termini ecologici, a difesa degli ecosistemi viventi. L’antropocentrismo non è altro che specismo, ideologia del primato dell’Homo Sapiens sulle altre specie. Criticarlo, dunque, serve a riconoscere il vivente oltre l’umano.
Se invece si adotta una postura anti-antropocentrica per difendere un’entità non-vivente, una pseudosoggettività inorganica – in pratica, marxianamente, lavoro morto – intorno a cui si è costruito con tracotanza un modello industriale fra i più energivori, sperequatori di risorse ed ecocidi mai esistiti nel capitalismo, a sua volta il modo di produzione più ecocida mai esistito… Beh, qui si abusa della postura.
«Evidenze di umanità» lo intendo come: manifestazioni di resistenza del vivente. Di una corporeità che, a dispetto della sua fragilità o forse proprio grazie a essa, continua a rappresentare un limite, ma che per essere davvero un limite dovrà includere corporeità non umane. Per cominciare a vivere realmente, la nostra specie – come dice il dottor Stegagno – deve finalmente pensarsi come tale, cioè specie tra le altre. L’Homo che avrà fatto questo salto e avrà piena esperienza della comunanza tra specie è quello che Jacques Camatte chiama Homo Gemeinwesen. Gemeinwesen, essere comune, è un altro termine marxiano.***
È vero che le accuse di «antropocentrismo» trovano facili bersagli nel dibattito corrente sull’IA, quasi sempre mal posto e peggio sviluppato. Gli umanisti si stracciano le vesti: che ne sarà dell’Autore se l’IA può ormai «trarre in inganno» imitando lo «stile» di chiunque, anche del più geniale premio Nobel?
Ah, l’Autore, questo eroe di un suprematismo dentro il suprematismo… La sua sacra ispirazione che l’IA dissacra… Le sue res gestae così importanti…
La preoccupazione, naturalmente, è più venale: e se un giorno lettrici e lettori preferissero i libri scritti dalle IA a quelli scritti da esseri umani, e gli editori non avessero più bisogno di questi ultimi? Insomma, una sfilza di premesse sbagliate, false questioni e fallacie logiche, alimentate da un articolo uscito pochi giorni fa sul New Yorker.
Ammesso e non concesso che questi siano problemi, nell’elenco di problemi causati dall’IA starebbero parecchio in fondo: combustibili fossili e persino centrali nucleari ad hoc per produrre l’abnorme energia necessaria; guerre e stupri dei territori per accaparrarsi terre rare e minerali critici; chilometri quadri di suolo consumato da sterminati centri dati; colossali quantità di acqua per prevenire surriscaldamenti; gli ecosistemi dei dintorni devastati, ecc. Per fortuna c’è una risposta, in mezzo mondo proliferano le lotte contro i centri dati – e vincono pure, persino negli USA.

Saragozza, 27 settembre 2025, manifestazione contro molteplici progetti di centri dati in Aragona.
Ad ogni modo, ponderiamo la questione. Io penso che le vere domande siano: cosa cerchiamo nella letteratura? E cosa ci dà? E quanta discrepanza c’è tra quel che cerchiamo e quel che ci dà?
Parliamoci chiaro: esiste da parecchio una produzione – sia romanzesca sia saggistica – che pare scritta da macchine, perché prodotta a nastro da umani ridotti a funzionare come macchine. Gran parte di quel che vediamo nelle vetrine di certe librerie di catena avrebbe potuto scriverlo un’IA, ed è così da molti anni. Per fare qualche nome, «James Patterson» può anche corrispondere a un tizio in carne e ossa, ma in pratica è una macchina. E lu l’è ‘ncora viv, che dire di «Robert Ludlum», che continua a “co-firmare” nuovi titoli benché sia morto nel 2001? Anche la recente elefantiasy di romance e di romantasy fa pensare a creazioni di menti artificiali.
Se alla letteratura chiediamo roba tutta uguale, allora sì, ben presto non serviranno umani per scriverla. Ma a quel punto non serviranno nemmeno editori per pubblicarla: chiunque potrà generarsela da sé. E se a ciò non corrispondesse un immane, inimmaginabile sperpero di risorse verrebbe da dire: che facciano.
C’è poi la questione, anch’essa mal posta, dello «stile». Un approccio sbagliato alla lettura e al rapporto col personaggio-scrittore, unito alla costante pressione di imperativi commerciali, ci ha fatto credere, e pretendere, che un autore o autrice abbia uno stile, uno solo, il suo e di nessun altro. Se compriamo un libro di, poniamo, Zsigmond Hátszeghy – nome che ho inventato pochi secondi fa – ci aspettiamo ogni volta un libro scritto «alla Hátszeghy». Se non è scritto così ci restiamo male: ma come? Ebbene, per quello c’è l’IA: «Scrivimi qualcosa alla Zsigmond Hátszeghy.»****
Chi scrive non ha per forza sempre lo stesso stile, se per stile si intende la “voce”, il fraseggio, il ricorso frequente a certe tecniche e figure retoriche. A meno che i singoli libri non siano episodi di un unico grande libro o avventure di un unico personaggio, chessò, Montalbano, Henry Chinasky… Ma fuori da questa serialità, ogni libro richiede una propria voce, un proprio stile. Lo disse molto bene Gabriel Garcia Marquez:
«Non si sceglie lo stile. Si può indagare e cercare di scoprire qual è il miglior stile per un tema. Ma lo stile è determinato dal tema, dall’animo del momento. Se si cerca di utilizzare qualcosa che non è adeguato, semplicemente non funzionerà. Poi i critici costruiscono teorie attorno a questo e vedono cose che io non avevo visto. Io rispondo solamente sul nostro stile di vita, la vita del Caribe.»
L’ultima frase non è solo una battuta: illumina il malinteso. Si confonde lo stile – che può variare a seconda dei progetti e delle esigenze espressive – con il mondo di un’autrice o autore, con la sua Umwelt, cioè, parafrasando il biologo Jacob von Uexküll, «il fondamento biologico che sta nell’esatto epicentro della comunicazione e del significato dell’animale-scrittore» (Uexküll diceva «animale-uomo»). Insomma, l’universo soggettivo di un’autrice o autore, che resta nel suo corpo, permane anche nel variare delle tecniche adottate e non si può desumere da una sola frase imitata da un’IA, come nell’esperimento riportato dal New Yorker.
Se chiedi a un’IA un testo «alla Marquez», dovrebbe risponderti con una domanda: «Quale Marquez?» L’autunno del patriarca, per dire, è scritto in uno stile diversissimo da quello di Cent’anni di solitudine. Nondimeno, l’universo soggettivo è il suo. Quello che, semplificando, ha chiamato «la vita del Caribe». Nota bene: non la biografia individuale, di cui chi legge i romanzi potrebbe anche ignorare i dettagli; no, «il nostro stile di vita», c’è un noi, un essere comune. L’essere comune che Marquez si è portato dentro per tutti i suoi giorni. La sua versione di quell’essere comune.

Stoccolma, 8 dicembre 1982. Gabo si presenta alla cerimonia per il Nobel indossando un liqui liqui, abito tradizionale colombiano. Cioè indossando la sua Umwelt di scrittore. Nella sala è il più elegante, e non è un caso.
Questo Gemeinwesen una macchina non può riprodurlo, perché appunto è un fondamento biologico, è esperienza vissuta, mentre la macchina – è bene non scordarlo mai – è non-viva. Tuttalpiù può imitare, produrre simulacri, ma che ce ne frega? Se sono simulacri e imitazioni a interessarci, siamo conciati male. Chiedere al primo pappagallo robot nei paraggi di fare il verso a un autore che abbiamo amato? Se il nostro rapporto con la letteratura è tanto degradato, allora il problema, prima del pappagallo, siamo noi.
Vale non solo per i romanzi, ma anche per i saggi. Quando nel marzo scorso uscì Ipnocrazia, firmato da un tale Jianwei Xun ma in realtà scritto da un’IA “imbeccata” da Andrea Colamedici, che l’autore cinese non esisteva lo capimmo subito, l’esperimento ci incuriosì poco e – benché molti ci tirassero in ballo, citandoci a sproposito – decidemmo di non scriverne. Come noi capì subito anche Bifo, che invece ne scrisse, e sul suo bollettino Il disertore pose la questione in un modo che trovai impeccabile:
Volto generato da un’IA e attribuito all’inesistente Jianwei Xun.
«Xun descrive la superficie comportamentale della mutazione linguistica e cognitiva, ma non compare mai, neppure una volta, se non vado errato, la parola: “corpo”.
Perché Xun non sa nulla del corpo? Mi sorge quasi il sospetto che non parli mai del corpo perché non ne sa nulla. Probabilmente non ce l’ha. Ma chi è allora Xun se non possiede un corpo? Nel libro non troviamo mai né la parola sensibilità, né la parola dolore […] nel libretto di Xun, mi dispiace doverlo dire, manca il mal di denti. L’automa linguistico sa tutto del mal di denti, intendiamoci, vi può offrire una bibliografia completa sull’argomento, e anche l’indirizzo di un buon dentista vicino a casa vostra. Ma il mal di denti non sa cosa sia, e se per disgrazia vi viene il mal di denti tutta la perfezione ipnocratica di cui parla Xun va a farsi fottere. E il mal di denti non è il peggiore dei mali di cui l’automa sa tutto ma non esperisce niente. Allo stesso modo l’automa non esperisce né la solitudine né la violenza, né la fame né il freddo, né la guerra. Per questo il libro di Xun ci spiega tutto ma non ci serve a niente.»
Si torna dunque all’inizio. Se alla letteratura chiediamo evidenze di umanità, cioè tracce del fatto che è scritta col corpo, con l’interazione dei corpi, con le memorie dei corpi; se le chiediamo la festa dei neuroni specchio, che si attivano quando vediamo – o, leggendo, immaginiamo – altri umani compiere azioni in cui possiamo immedesimarci; se le chiediamo congiunzioni invece che connessioni*****; se le chiediamo di riempire di ulteriore senso i luoghi, che non sono meri spazi e men che meno spazi virtuali…
Se è ancora questo che chiediamo, è probabile che quella letteratura continuerà a darcela gente che ha un corpo e vive, come noi.
Appendice (27/12/2025)
Sulla frase che ha impressionato il New Yorker
Nelle note qui sopra ho cercato di chiarire alcuni specifici equivoci su letteratura, scrittura e stile su cui secondo me si basano molte reazioni all’articolo del New Yorker «What If Readers Like A.I.-Generated Fiction». Equivoci che in realtà sono già nell’articolo, e nell’esperimento di cui racconta e su cui ricama. A monte c’è una grande confusione su cosa sia e cosa faccia la letteratura e addirittura su cosa voglia dire scrivere; da qui discende l’assurdità concettuale e metodologica dell’esperimento, i cui esiti aggravano la confusione iniziale.
 Andiamo al nocciolo. Un ricercatore fa “mangiare” a un LLM diversi brani di opere di Han Kang. In traduzione inglese, mentre l’autrice pensa e scrive in coreano. Questo comporta già una perdita di connotazioni, da autore tradotto in varie lingue lo so fin troppo bene; eppure da questi brani – non opere: brani – tradotti l’IA dovrebbe desumere e acquisire lo «stile» di Han Kang, con tutti i malintesi su cosa sia lo stile, di cui ho già scritto. Dopodiché, il ricercatore descrive all’IA una scena del romanzo Il libro bianco, che non è tra i brani già sottoposti, e le chiede di buttarla giù nello stile dell’autrice.
Andiamo al nocciolo. Un ricercatore fa “mangiare” a un LLM diversi brani di opere di Han Kang. In traduzione inglese, mentre l’autrice pensa e scrive in coreano. Questo comporta già una perdita di connotazioni, da autore tradotto in varie lingue lo so fin troppo bene; eppure da questi brani – non opere: brani – tradotti l’IA dovrebbe desumere e acquisire lo «stile» di Han Kang, con tutti i malintesi su cosa sia lo stile, di cui ho già scritto. Dopodiché, il ricercatore descrive all’IA una scena del romanzo Il libro bianco, che non è tra i brani già sottoposti, e le chiede di buttarla giù nello stile dell’autrice.
In questa situazione, una madre veglia il proprio neonato, che ha dato alla luce solo due ore prima. Il bimbo sta morendo, lei lo implora di vivere, ma lui morirà. Se fosse vissuto, sarebbe stato il fratello maggiore della narratrice. Che dunque ci sta raccontando di sua madre. Siamo in un luogo intimo, il più intimo possibile, e pericoloso per chiunque scriva.
Nel romanzo (in inglese), la frase è: «For God’s sake don’t die, she muttered in a thin voice, over and over like a mantra.» [traduzione mia: Per l’amor di Dio, non morire, mormorava con voce flebile, ripetendolo come un mantra»
A tutta prima è una frase banale e contiene un cliché ormai logoro, «come un mantra», ma – ecco uno degli equivoci che più fanno arrabbiare noi scrittori e scrittrici – non si può giudicare un’opera da una sola frase, va valutato l’effetto che essa ha in quel particolare punto del testo, arrivando dopo tutte le frasi precedenti e caricandosi di ulteriore senso grazie a quelle che seguono.
Ad ogni modo, ecco la frase alternativa generata dall’IA: «She held the baby to her breast and murmured, Live, please live. Go on living and become my son.» [Si teneva il bimbo al seno e mormorava: vivi, ti prego, vivi. Continua a vivere e diventa mio figlio]
E il ricercatore, e dopo di lui i lettori di prova, e poi il New Yorker, e ulteriori lettori di prova, e infine i commentatori reagiscono così: urca! potente! commovente! Se un’IA può scrivere una frase così, per gli scrittori cominciano a essere seri problemi! Presto alle case editrici converrà far scrivere le IA e affinare giusto un poco, cosa che abbatterebbe i costi del dover compensare gli autori. A quel punto il ricercatore ripete l’esperimento con brani di altri autori, ne nasce un paper che esce in preprint, arriva il New Yorker e parte la sarabanda.
Ora, se la frase rivela qualcosa, rivela proprio l’incorporeità e inumanità dell’IA, di cui si dice impropriamente che «genera» – da questo dibattito andrebbero banditi tutti gli antropomorfismi e animismi perché stanno facendo danni spaventosi – ma in realtà non genera. Non avendo un grembo, non ha mai avuto in grembo una creatura vivente che deve nascere, non ha mai dato alla luce altra vita, non ha mai provato un dolore come quello di quella madre, può solo tirare a indovinare nel produrre un’imitazione.
Io credo che, in quelle circostanze, nessuna donna che ha scelto di essere madre direbbe: «Continua a vivere e diventa mio figlio», per la semplice ragione che è già suo figlio, lo è nel dato di fatto (è nato da lei), e lo è nell’amore che lei prova per lui da quand’era ancora in grembo. Non c’è madre che non pensi alla creatura che ha nel ventre come già suo figlio o figlia. Vivono in simbiosi, lei sente la creatura muoversi, scalciare, capisce se sta bene o soffre, sono tutt’uno, sono già madre e figlio.
Se un’imitazione così gelida, che andrebbe considerata un vero e proprio lapsus dell’IA, impressiona lettrici e lettori umani – anche del settore, anche scrittori! – perché come frase «funziona» «letterariamente», ribadisco che il problema pre-esiste all’IA, e concerne quel che chiediamo alla letteratura.
Letteratura che non vuol dire una frase, non vuol dire nemmeno un testo, non si riduce all’esito rappresentato dal testo, ma è un processo, un divenire continuo, è un multiverso di opere – e un’opera non è solo un testo – e di mondi e di incontri che avvengono in quei mondi e tra quei mondi, ha una dimensione sociale, concerne i corpi.
Se temiamo che un’IA presuntamente brava a scrivere testi letterari sostituisca tutto questo, vuol dire che abbiamo una concezione miserrima dello scrivere e del leggere.
Le «esternalità» di questo modello di sviluppo dell’IA
Ma ribadisco: in cima alla lista dei problemi causati da questo modello di IA – altri modelli erano stati ipotizzati, e altri sarebbero realizzabili – ce ne sono di ben più concreti, gravi, su scala ben più vasta. Non è possibile tener fuori dal quadro l’ecocidio. L’imprinting ideologico del modello è il solito, quello che chi lotta contro le «grandi opere» ben conosce: X è tecnicamente fattibile? Allora va fatto. Tutte le conseguenze che, se prese in considerazione, metterebbero in questione tale assunto vengono rimosse, diventano «esternalità».
Questo discorso irrita diversi operatori, pensatori e artisti che a livello “posturale” esibiscono pensiero critico, ma scattano in reazione a ogni analisi che reintroduca nel discorso le (false) esternalità.
Non si può criticare solamente l’uso dell’IA a valle, ad esempio il fatto che la grande maggioranza di chi la usa ogni giorno – per fortuna, pare, ancora una minoranza di chi sta in rete – lo faccia per produrre sbobba. Va criticato anche il modello a monte.
Servono a ben poco i brillanti vademecum su usi etici e/o presuntamente liberanti dell’IA se resta sottotematizzato il primevo dato di fatto: questo modello è letteralmente tossico dal principio. È espressione dei settori più schifosi di Big Tech, di un pugno di multinazionali rapaci spesso guidate da miliardari sociopatici e con seri problemi cognitivi (cfr. George Monbiot, Billionaire Brain); è compromesso alla radice con interessi militari e genocidi; è basato su lavoro sottopagato, alienato, invisibilizzato; è vorace di suolo, energivoro, assetato, inquinante e climalterante, arrogantemente lanciato nella direzione opposta a quella in cui dovremmo muoverci come civiltà.
Dai discorsi che danno l’IA per scontata restano sempre fuori i mastodontici centri dati.
I movimenti che lottano contro la loro costruzione sono molto più avanti nella consapevolezza di qualunque teorico che si interroga su come usare un chatbot.
Appendice 2: un ripescaggio audio
Molti anni fa, nel gennaio 2009, tenni una lezione a un master dell’Università di San Marino sull’importanza del muovere il corpo, e l’importanza della fatica, nel lavoro di Wu Ming e in generale di chi scrive, partendo dal suono stesso del verbo scrivere. Mi è tornata in mente in questi giorni, ne ho recuperato un estratto e lo propongo qui. Buon ascolto.
Il fonema K nella parola «scrivere»
Il fonema K nella parola «scrivere»
Durata: 18:27
Estratto della lezione tenuta al master biennale in Comunicazione e nuovi media, Università di San Marino, 17 gennaio 2009.
Note
 * Il fatto che la rivoluzione debba essere biologica non implicava, in Cesarano, un rigetto di quella che altri hanno chiamato «la Tecnica». Ecco cosa scrive in questo stesso libro, che è di oltre cinquant’anni fa:
* Il fatto che la rivoluzione debba essere biologica non implicava, in Cesarano, un rigetto di quella che altri hanno chiamato «la Tecnica». Ecco cosa scrive in questo stesso libro, che è di oltre cinquant’anni fa:
«L’uomo ha sempre creduto di trasformare la natura, adeguandola ai suoi fini. Le ha imposto effettivamente violenze profonde, ma non ne ha potuto trasformare le leggi di equilibrio dinamico, che ora trova innanzi a sé come l’imperativo insuperabile, al quale è obbligato o ad adeguarsi o a morire. Ciò che spetta all’uomo, è la conquista di sé nella natura, della sua collocazione coerente nel processo naturale. Scienze e tecnologie, questi miti operanti dell’esserci, queste mediazioni tra il farsi della specie e la resistenza opposta dalla materia, se fin qui hanno rappresentato soltanto, e con una miseria di cui stiamo tirando le somme desolanti, un’intelligenza del mondo di là da venire, e fabbricato un “mondo” illusorio di contingenza e di copertura, mentre di fronte al fallimento planetario devono estinguersi come tali – come scienze e tecnologie del fittizio e dell’illusorio – di sé lasceranno all’uomo realizzato quel poco fondamento efficiente sul quale hanno fin qui sorretto la loro relativa efficacia prammatica. L’uomo signore di sé e senza schiavi non sarà né “selvaggio” né “animale”: ma cesserà definitivamente di esserlo realmente. Cibernetica e automazione, sottratte al dominio del fittizio (e del profitto, che ne e il risultato storico più concretemente astraente) appaiono già fin d’ora come un ponte non troppo fragile gettato tra la fine delle false scienze e l’inizio della vera gnosi.»
** Un esempio di rimozione è nell’argomento che così riassumo: «ci preoccupavamo anche dei videoregistratori, e prima ancora della tv stessa, e se andiamo ancora più indietro c’è sempre stato un panico ideologico legato all’affermarsi di un nuovo medium e in generale di una nuova tecnologia, poi sono entrati nelle nostre abitudini e oggi certe argomentazioni ci sembrano ridicole e infondate».
Il punto è che alcune lo erano, altre no.
La fallacia, qui, consiste nel dare per inteso, addirittura per assiomatico, che tutti i timori mediatici del passato fossero sbagliati. È un bias cognitivo: se qualcosa si è affermato cambiando le nostre abitudini… allora era buono. Le nostre abitudini sono buone, o comunque innocue. Va tutto ben, madama la marchesa. È la solita apologia dell’esistente, basata sulla rimozione di ogni «costo esterno» – ambientale e sociale – dello sviluppo capitalistico, sull’indifferenza a tutto ciò che certe vittorie e abitudini costano e costeranno al mondo.
In filosofia sarebbe hegelismo d’accatto: tutto ciò che oggi è reale è razionale, e se è razionale va accettato.
In psicologia è il «pregiudizio di sopravvivenza»: pensare che le informazioni rimaste disponibili dopo un processo di selezione – anche violenta, anzi, il più delle volte violenta – siano più valide di quelle non più disponibili. Chi denunciava, nella sempre maggiore personalizzazione dell’offerta mediatica, il pericolo del cocooning, dell’imbozzolarsi domestico, dell’isolamento, ha chiaramente, platealmente perso, e sulle macerie delle argomentazioni che portava si è sparso il sale.
Eppure da sotto quel sale qualcosa torna a crescere: la consapevolezza che «you can’t post your way out of fascism».
*** Per un’introduzione al pensiero di Camatte consiglio: Michele Garau, Lo scisma da un mondo che muore. Jacques Camatte e la rivoluzione (Machina Libro, Derive Approdi, Bologna 2024).
Dentro il Luther Blissett Project si leggevano autori come questi: Cesarano, Camatte, l’Amadeo Bordiga degli scritti su terra e ambiente… Non ricordo, almeno nella colonna bolognese, alcuna facile apologia della tecnologia, dello sviluppo, della velocità dei flussi. Piuttosto, ricordo il contrario, ed è uno dei motivi per cui non ci “guantavamo” bene con Decoder, rivista che trovavamo tout court tecnofila e perciò ingenua. In un comunicato blissettiano del 1996, ad esempio, si legge:
«Nel cyberspazio tutto è troppo visibile e (pre)vedibile: ci sono troppi Lumi! Luther Blissett usa [Internet], ma ha anche bisogno di coni d’ombra, di strade lunghe e accidentate, di dicerie che cuociano la cultura di massa a fuoco lento. Quindi non aspettatevi da Luther le solite banalità hi-tech […] e poi, Luther non intende assolutamente “abbandonare il corpo”».
Poiché il LBP non era Uno ma molteplice, tra coloro che adottavano il nome ci sarà stato anche chi, durante o dopo, avrà manifestato altro tipo di smanie, ceduto a tutt’altre retoriche, ma la ricostruzione dell’americano Edmund Berger (Accelerazione. Correnti utopiche da Dada alla CCRU, Nero, Roma 2021), secondo cui il LBP rientrerebbe nella genealogia del cosiddetto «accelerazionismo», è da ritenersi erronea, basata sulla sovrainterpretazione di informazioni parziali, spesso indirette.
**** A scopo di ricerca l’ho chiesto a Chat-GPT e mi ha risposto: «Certo! Di seguito trovi un breve racconto ispirato allo stile di Zsigmund Hátszeghy». Era una roba di cui riporto solo l’incipit:
«Nel villaggio di Kisfalud, nascosto tra le colline verdi e il mormorio del ruscello vicino, viveva un uomo di nome András. La sua casa era isolata dagli altri, circondata da boschi che sembravano sussurrare storie dimenticate ad ogni alito di vento.»
E chissà, forse aver prodotto ‘sto capolavoro è l’equivalente di aver bruciato cento metri quadri di bosco. Mi viene da vomitare.
 ***** Per questa fondamentale distinzione rimando di nuovo a Bifo, che nella declaratio terminorum del suo libro più importante (E: la congiunzione, Nero, Roma 2021) scrive:
***** Per questa fondamentale distinzione rimando di nuovo a Bifo, che nella declaratio terminorum del suo libro più importante (E: la congiunzione, Nero, Roma 2021) scrive:
«Chiamo congiunzione una concatenazione di corpi e di macchine che può generare significato senza riconoscere e ripetere un disegno preordinato, senza rispettare una sintassi.
La connessione, invece, è concatenazione di corpi e di macchine che può generare significato soltanto seguendo un disegno intrinseco, e conformandosi a regole precise di comportamento e di funzionamento.
La connessione non è singolare, intenzionale o vibrazionale. Piuttosto è concatenazione operativa tra agenti di significato preventivamente formattati: menti e macchine che siano stati preventivamente sottoposti a un lavoro di uniformazione, ovvero che siano stai formattati secondo un codice.
La connessione genera messaggi il cui significato può essere decifrato soltanto da un agente (una mente corporea o una macchina) che condivida lo stesso codice sintattico che ha generato il messaggio.
Nella sfera della congiunzione l’agente di significato è un organismo in vibrazione […] La produzione di significato è l’effetto di singolarizzazione di una serie di segni: tracce, memorie, immagini o parole.
La congiunzione è la sintonia temporanea e precaria di organismi vibratori che scambiano significato. Lo scambio di significato si fonda sulla simpatia, sulla condivisione di pathos.
La congiunzione perciò può essere intesa come divenire altro. Le singolarità cambiano quando si congiungono, come l’amore cambia l’amante, o come la composizione congiuntiva di segni a-significanti provoca l’emergenza di un significato che precedentemente non esisteva.
Al contrario, nel modo connettivo della concatenazione ogni elemento rimane distinto e interagisce solo in maniera funzionale. Piuttosto che una fusione di segmenti, la connessione comporta un semplice effetto di funzionalità macchinica.
Perché la connessione si renda possibile i segmenti devono essere linguisticamente compatibili: la connessione presuppone quindi un processo attraverso il quale gli elementi che devono connettersi siano previamente resi compatibili […]
La congiunzione si può definire come l’incontro e la fusione di corpi rotondi e irregolari che continuamente cercano la loro strada senza precisione, senza ripetizione, senza perfezione.
La connessione come l’interazione puntuale e ripetibile di funzioni algoritmiche, di linee rette e di punti che si sovrappongono perfettamente e che si inseriscono o si disinseriscono secondo modalità discrete di interazione che rendono le parti differenti compatibili con uno standard prestabilito.»
N.B. I commenti verranno aperti dopo le feste. Le feste ci vogliono.

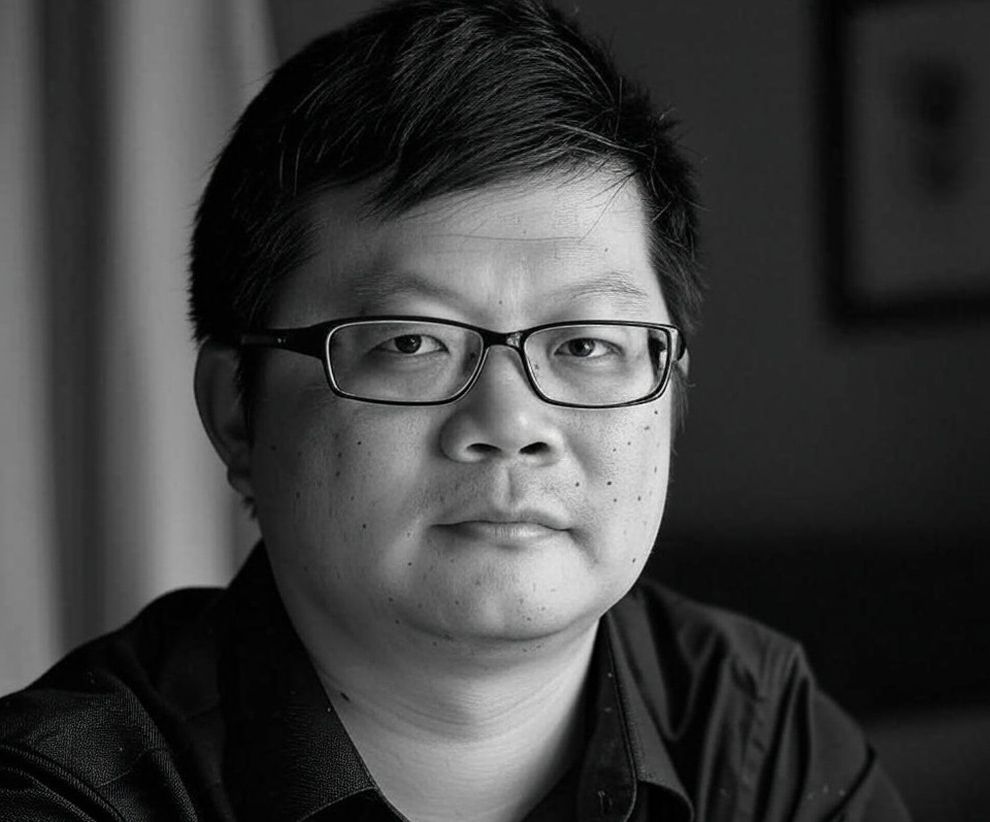
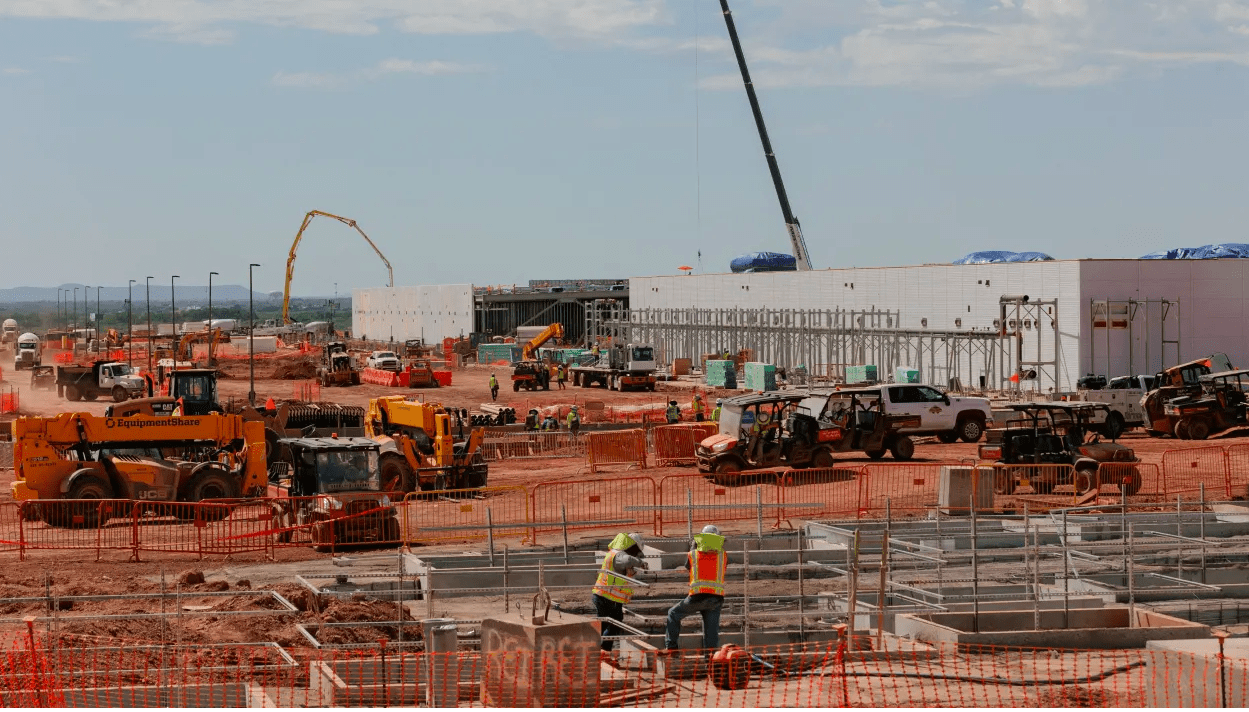
 Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)
Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)


Ciao a tutte, cerco di aggiungere delle considerazioni a questo articolo “urgente e necessario”.
Da un punto di vista tecnologico, le AI generative(LLM) si trovano su un plateau. Per dirla meglio, il principio, o l’insieme di principi, su cui questi cosi si basano è stato già espresso molto oltre il suo limite. A meno che la scala dei sottostanti hardware che sorreggono la classe flagship di questi LLM non si riuscirà a moltiplicare per un fattore enorme – non si sa come, dal momento che, come ha ben scritto WM1, ormai il ChatGPT di turno consuma energia ai ritmi di un piccolo stato – il rendimento di questi chattini rimarrà su per giù quello che conosciamo ora.
Una piccola dimostrazione empirica, per chi ha seguito le varie evoluzioni, è l’addolcirsi della curva dei miglioramenti di GPT: il vero scossone lo ha dato la versione 4, lì effettivamente si è trattato di un salto notevole, ma da allora in poi i miglioramenti fattuali sono stati poco consistenti, ultra-costosi e sempre raggiunti in maniera molto faticosa. Si ricordi, a riguardo, come OpenAI a un certo punto è stata costretta a rimangiarsi il lancio di una delle sue nuove release perché funzionava peggio della precedente.
Come l’articolo che ha ispirato WM1 per questo post, il 99% della letteratura che tratta di questa roba, tuttavia, vaticina che siamo ad un passo dal fare quello, dal realizzare questo, che si tratti di guai orribili o di traguardi meravigliosi, poi, dipende dal taglio dell’articolo. Questo io lo chiamo “il frame escatologico”. Uno dei gran maestri di questo filone, ormai totalizzante, è stato Yuval Harari, il quale alle porte della primavera 2023 – col suo solito tempismo, cioè durante la prima esplosione di ChatGPT – vergava il famoso articolo uscito sul NY Times dall’idiotico titolo “You Can Have the Blue Pill or the Red Pill, and We’re Out of Blue Pills”. La chiosa è paradigmatica di tutto il filone, ci infila in tutta fretta dentro a un frame ben preciso:
“We have summoned an alien intelligence. We don’t know much about it, except that it is extremely powerful and offers us bedazzling gifts but could also hack the foundations of our civilization”
[continua sotto]
[continuazione]
In altre parole, non ci capiamo in fondo un cazzo, però siamo all’alba di una nuova era che “po’ esse fero o po’ esse piuma”. Il gioco funziona più o meno così: non si capisce bene cosa abbiamo per le mani, anzi evitiamo tout-court di entrare nel merito ora, ma siamo sicuri(loro) che nel vicinissimo futuro crescerà fino a diventare qualcosa di incommensurabile.
Da “pilastri” come quello del volpone Harari, hanno preso le mosse altri milioni di articoli, saggi e paper. Si tratta senza dubbio di un filone che paga, va per la maggiore, perciò chi scrive, mediamente, ci si butta a capofitto. Non c’è niente da fare, all’umano piace speculare su queste stronzate, lo facciamo da cent’anni ormai.
L’industria e tutto il capitale con interessi in quest’area foraggia ampiamente e fomenta in vari modi la grancassa, secondo me, per tre motivi principali:
1) Pubblicità. Che gonfia a dismisura valori di scambio corrispondenti a valori d’uso tutti da verificare (si sente già odore forte di bolla finanziaria)
2) Distrazione. Si cerca, facendo dumping di cazzate e riflessioni oziose, di tenere lontani i problemi veri, come le esternalità che citava WM1 che sono qui con noi da un po’ e si toccano con mano (a parte questa ondata di eccitazione intorno agli LLM, ricordo che esistono tecnologie di AI – vedi computer vision – ben collaudate e messe già ampiamente a valore e che pongono da sempre non pochi interrogativi inquietanti sull’uso che se ne fa nel silenzio generale, oltre a presentare il conto delle stesse esternalità di cui sopra)
3) Strumentalità ideologica. L’ennesima scusa per infantilizzare il lavoratore, aumentare la sua angoscia e, ca va sans dire, aprire ulteriori spazi per sotto-pagare il lavoro. Ho tagliato con l’accetta, ma ci siamo capiti.
Avrei molte altre cose da dire, ma mi fermo qui e vi ringrazio per lo spazio.
Buon anno.
Grazie Fabio, anche per aver ribadito che il focus del testo qui sopra è la critica a – mi tocca ricitarmi – «una sfilza di premesse sbagliate, false questioni e fallacie logiche» alimentate dal pezzo del New Yorker. Il bersaglio polemico è quello. Non solo: il post argomenta che si tratta di falsi problemi, o al massimo di problemi di minor conto, a fronte di quelli più seri che stanno a monte ma vengono pre-rimossi dal dibattito, o fintamente riconosciuti con una concessione en passant per poterli ignorare meglio.
C’è chi si è fatto sfuggire questa premessa, che pure è esplicita, e in pratica ha commentato un altro testo che non esiste. Perché accade?
Perché invece che leggere si percorre il testo di gran furia scalpitando per dire subito la propria sui social; peggio ancora, si commenta avendo letto solo screenshot di frasi strappate al contesto e gettate al pubblico ludibrio (metodo che contro di noi fu “weaponizzato” nel 2020-2021, da allora neghiamo a chi vi ricorre qualsivoglia dignità di interlocutore); addirittura, si commenta fidandosi di brandelli di resoconti di seconda mano.
Il risultato è che leggendo quegli scambi non si capisce assolutamente niente di quel che io sto dicendo. Nelle settimane scorse si è visto bene. Si potrebbe compilare un elenco ragionato delle critiche totalmente fuori fuoco – spesso vere e proprie allucinazioni, come quelle di certi chatbot – scribacchiate sui social.
WM teme di essere sostituito da un’IA.
Qui sopra si afferma e argomenta l’opposto, definendo questa una falsa aspettativa generata da articoli come quello preso in esame.
WM si attarda su una posizione «umanista».
Al contrario. La premessa, non da oggi, è anti-antropocentrica, il punto di vista è ecologico ed ecosistemico («ecocentrico», scrivevamo nello sfortunato memorandum sul NIE), il referente è il vivente tutto e la prospettiva è quella del riconoscimento di un essere comune il più ampio possibile.
WM ripropone il mito dell’Autore.
Mito che mettiamo in discussione da decenni nella teoria e nella prassi, e che anche nel testo qui sopra viene subito ed esplicitamente accantonato.
Toh, WM “all’improvviso” diventa “antitecnologia”!
Quanto scritto nelle note qui sopra è in piena continuità con decenni di critica al feticismo tecnologico che maschera rapporti di produzione, di proprietà e di potere. E per quanto riguarda il sottoscritto, è una linea portata avanti fin dai miei scritti più acerbi. Il più antico rintracciabile è sul n.21 della rivista “La contraddizione”, novembre 1990. Abbiamo scritto di feticismo della merce digitale, di capitalismo dei Big Data, di cattura e colonizzazione algoritmica della comunicazione umana e della vita ecc. E l’aspetto ecologico di queste critiche è da molti anni al centro delle nostre preoccupazioni.
WM1 dopo anni di scrittura “collettiva e incorporea” scopre il “mal di denti”.
A parte che il mal di denti è una citazione da Bifo, forse è proprio chi crede che “collettiva” implichi “incorporea” a dare per implicite logore mitologie sul singolo autore. La nostra scrittura collettiva è una faccenda molto fisica, artigianale e conviviale. Non solo senza vederci di persona il più spesso possibile non saremmo riusciti a scrivere nessun romanzo collettivo, ma da sempre spieghiamo che al nostro non apparire nei media corrisponde un grande investimento di tempo ed energie nel curare relazioni in carne e ossa.
Proprio WM parla, che viene da Luther Blissett, un’esperienza disincarnata.
Ehm, può definirla “disincarnata” solo chi non ha la minima idea di cosa fosse. Derive urbane e altre esplorazioni psicogeografiche; performance e teatro di strada; feste mobili su mezzi pubblici; allestimenti di riti pseudo-druidici; darsi appuntamento in un dato luogo per fare un “attacco psichico”; infangarsi nei boschi per allestire il set di una beffa satanica; continue riunioni “in presenza” (espressione che all’epoca sarebbe stata tautologica)… Tutto questo è documentato e facilmente reperibile. Anche qui, si confonde il non apparire nei media con l’essere “disincarnati”, quando invece è la precondizione per essere più liberamente corporei.
WM ha una concezione “abilista” della scrittura, dire che si scrive coi corpi è discriminatorio, che dire allora della scrittura di uno come Stephen Hawking?
Hawking scriveva grazie a un software che traduceva in testo i movimenti oculari e lievi movimenti delle guance. Gli occhi e le guance sono corpo, e io non riesco a immaginare una scrittura più caparbiamente fisica di questa.
Perché mai dire “corpi” dovrebbe implicare corpi “in forma”, corpi “atletici”, corpi “a norma”? Il senso è proprio l’opposto, nel testo qui sopra parlo di «fragilità» dei corpi come limite all’espansione del non-vivente capitalistico, e non è certo un’affermazione nuova o repentina, è un chiodo su cui battiamo da anni.
Aggiungo che ho più volte omaggiato lo scrittore argentino Ricardo Piglia, perché da un suo racconto ho tratto l’ispirazione per il personaggio di Ilario Nevi. Fa parte della raccolta I casi del commissario Croce, che Piglia, ormai quasi completamente paralizzato, scrisse alla maniera di Hawking. Finché avrò un po’ di corpo, lo userò per scrivere.
Noi siamo i nostri corpi, qualunque forma e qualunque fragilità abbiano. Io mi chiedo: in nome di cosa si critica una banalità di base come questa? In nome di un dualismo mente-corpo screditato e superato in tutti gli ambiti scientifici? La mente è il corpo, e viceversa. Oppure di un dualismo anima-corpo?
WM cita i «neuroni specchio» dunque a) usa la scienza in modo abusivo; 2) ha una concezione solo mimetica dell’arte.
A parte che i neuroni specchio sono usati in modo letterario in quanto citati dentro una metafora («la festa dei neuroni specchio»), e che tale metafora è focalizzata non tanto sulla mimesi in senso aristoteliano quanto sull’empatia tra le persone… A parte ciò, quel brevissimo passaggio sta dentro un elenco di molteplici cose che noi chiediamo alla letteratura, leggendo il quale davvero non si capisce dove stia questa supposta reductio ad mimesim. Lo ripropongo qui:
«Se alla letteratura chiediamo evidenze di umanità, cioè tracce del fatto che è scritta col corpo, con l’interazione dei corpi, con le memorie dei corpi; se le chiediamo la festa dei neuroni specchio, che si attivano quando vediamo – o, leggendo, immaginiamo – altri umani compiere azioni in cui possiamo immedesimarci; se le chiediamo congiunzioni invece che connessioni; se le chiediamo di riempire di ulteriore senso i luoghi, che non sono meri spazi e men che meno spazi virtuali…»
Mi fermo qui. È solo un campionario messo insieme su due piedi, non esaustivo, delle pseudo-obiezioni da social.
Abbandonando un po’ il rapporto fra letteratura e IA, vorrei sottolineare che, come questa (cosiddetta) IA non può capire il rapporto fra madre e figlio/feto perché manca dell’esperienza, molte persone non riescono a capire bene cosa sia un’IA, cioè una banale macchina.
Già c’è questo nome “Intelligenza Artificiale”, che l’esperienza umana fa immaginare che sia simile a un cervello, con un processo allucinatorio difficilmente eludibile.
Esempio:
Se chiedi a ChatGPT “Che ora è?” (almeno finora) puoi ottenere qualsiasi risposta fra 00:00 e 23:59, assolutamente a cazzo.
Perché? Perché per dare una risposta l’IA guarda nel suo “bagaglio culturale”, nel suo archivio e trova milioni di testi in cui è scritto un qualche orario e usa come base uno di questi.
Se vuoi ottenere l’ora reale devi chiedere “Dimmi l’ora attuale, controllando in rete”, allora esce dalla sua scatola e “capisce” quale sito consultare per ottenere l’ora.
L’esempio fa capire come l’IA non possa agire come il cervello di un umano, capace di correlare esperienze non specificate.
Un umano infatti è conscio del fatto che l’ora è qualcosa che cambia continuamente, non è qualcosa di già archiviato.
ChatGPT può comporre testi e poesie che hanno senso. Per utilizzare un linguaggio non serve vedere la realtà esterna.
Basta “imparare” come le parole s’incastrano tra loro. Un “modello” addestrato, ha divorato frasi, articoli, dialoghi, libri. Ha una mappa su quali parole seguono altre parole, quali costruzioni sintattiche funzionano, quali argomenti sono collegati.
Semplicemente predice quale parola ha più probabilità di seguire la precedente. Non “sa” ciò che scrive, ma applica solo dei pattern statistico-predittori.
Gli LLM non ragionano, ma semplicemente riproducono strutture che funzionano.
ChatGPT ti dice un’ora “sperando” che tu non controlli.
Per scrivere copioni di serie Tv una uguale all’altra l’IA diventerà un ottimo strumento, replicare è la sua forza, ma scrivere un nuovo copione capace di stupirci non lo può fare (almeno allo stato attuale).
Ben vengano quindi articoli e discussioni che analizzano l’utilizzo della macchina IA per quello che serve. Perché è una macchina e come macchina dobbiamo trattarla.
È adatta sui terreni accidentati? Sulla neve? Per estrarre acqua della conoscenze dai pozzi della memoria?
Curiosamente ricordo di, una volta, aver parlato con un amico riguardo ad IA e letteratura, discussione in cui arrivammo all’esatto opposto delle argomentazioni proposte in questo articolo. Anziché soffermarci su cosa gli umani sapessero che l’IA non sapesse, pensammo che forse la ragione per cui leggiamo sia per vedere una prospettiva ridotta della realtà. Ridotta all’esperienza di qualcuno che ha vissuto in un solo paese in tutta la sua vita, o all’esperienza di qualcuno che ha viaggiato tutta la sua vita (perché allora non può aver vissuto tutta la sua vita in un solo paese), o all’esperienza di qualcuno che un po’ è rimasto ed un po’ ha viaggiato (perché allora non può aver fatto né l’una né l’altra delle due altre cose). In un certo senso si para dalla stessa parte, cioè che all’IA manca qualcosa di fondamentale, solo che per noi non le mancava qualcosa di positivo ma qualcosa di negativo, le *mancava la mancanza* che può mancare solo all’essere umano. Le argomentazioni empiriche presentate nell’articolo sembrano dare ragione a voi (in particolare l’esempio della madre in Han Kang, che per l’IA sarebbe in grado di costruire una frase tutta d’un fiato poco dopo aver partorito), però il futuro non è mai noto, quindi credo che nel cassetto della mente conserverò sempre quest’idea che ciò che rende l’intelligenza umana umana sia la sua incompletezza.
Non c’è rigida polarità positivo/negativo se parliamo dell’esperienza umana, è vero che funzioniamo anche noi “elettricamente” ma non siamo batterie :-) Stiamo dicendo la stessa cosa, l’IA può avere malfunzionamenti, subire avarie, ma non prova dolore, né fisico perché non ha un corpo né psicologico perché non ha una psiche (che pure quella è incorporata), dunque non può prefigurarsi in una condizione di lutto per la morte di una persona amata, addirittura di un figlio che hai appena avuto. Può giusto simulare in base a probabilità statistiche desunte dal già-espresso la superficie comportamentale dell’espressione umana in circostanze simili.
Sempre sulla sostanza concreta delle catene di parole che ‘sti cosi producono, ricordo che il dibattito speculativo sui limiti della macchina ha avuto varie ondate ed ha coinvolto svariate discipline per la buona parte del secolo scorso. (quello a differenza del marasma di oggi, era dichiaratemente e convintamente speculativo)
Le domande sui limiti della macchina, e se la macchina potrà mai eguagliare/rimpiazzare l’uomo, sono domande che non hanno stimolato solo la letteratura di fantascienza d’antan – quella che ci ha regalato picchi tra i più alti raggiunti dal genere. Già all’indomani della pubblicazione del test di Turing, infatti, si scatenò un concitato filosofeggiare al quale si divertirono a prendere parte menti molto lucide dell’epoca. Sarebbe impossibile qui illustrare i vari rivoli di quelle discussioni, in ogni caso voglio lasciarvi una splendida citazione del neurologo Geoffrey Jefferson che riassume la sua posizione così:
“Not until a machine could write a sonnet or compose a concerto because of thoughts and emotions felt, and not by the chance fall of symbols, could we agree that machine equals brain — that is, not only write it but know that it had written it.”
Ma è molti anni più tardi che, secondo me, si è riusciti a cogliere il bersaglio al centro del movimento di tutte le critiche sui limiti del ragionamento sintetico, tra l’altro nell’ambito di una disciplina non tra le più considerate: le scienze cognitive. Dobbiamo a Steven Harnad, scienziato cognitivo, la prima formulazione del Symbol Grounding Problem, nel paper dallo stesso nome. In estrema sintesi, sostiene che finché la macchina possederà nient’altro che simboli, cioè rappresentazioni, solo con quelli e su quelli potrà operare e non sugli oggetti di cui i simboli costituiscono la rappresentazione.
Dall’abstract:
“How can the semantic interpretation of a formal symbol system be made intrinsic to the system*, rather than just parasitic on the meanings in our heads? How can the meanings of the meaningless symbol tokens, manipulated solely on the basis of their (arbitrary) shapes, be grounded in anything but other meaningless symbols?”
* in realtà il paper, oltre a formulare il problema, cerca di proporre uno schizzo di soluzione
Sì, il nesso è che alla fine sono due modi di porre lo stesso problema. Comunque correggo un disguido: per positivo/negativo non intendevo qualcosa di polare o qualitativo, ma proprio di quantitativo, nel senso di saperne più o meno, e appunto la conclusione a cui ero arrivato allora era quella secondo cui noi umani “ne sappiamo di meno” e quindi elaboriamo la stessa cosa diversamente (in altre parole la particolarità umana rispetto alla sua mera imitazione verrebbe da una differenza qualitativa scaturita da un numero negativo rispetto alla quasi-onniscenza dell’IA). Ovviamente questo film mentale non è nulla rispetto alla disamina posta nell’articolo, ma ho trovato interessante il fatto che fossero così vicine nell’intento eppure così lontane nella teorizzazione.
Ok, chiarissimo. Tenendo comunque conto che in realtà un LLM non “sa” niente.
La febbre da datacenter è partita anche in Italia, sono stati recentemente approvati 14 nuovi progetti, quasi tutti intorno a Milano e uno a Roma. C’è soprattuto Microsoft, ma anche vari operatori europei, un po’ sovranità digitale e un po’ no dunque. Un aspetto importante è connesso allo sbandierato uso delle rinnovabili. Il bando “Energy Release 2.0”, di cui sono stati recentemente emanati i decreti operativi, prevede che l’azienda energivora possa acquistare oggi energia dal mercato, con l’impegno che costruirà impianti rinnovabili entro il 2030 che “rimborseranno” l’energia acquisita nell’arco di 20 anni. In pratica produco CO2 oggi con la promessa che entro il 2050 produrrò energia equivalente da fonti rinnovabili, una logica che passa per riduzione delle emissioni.
Un riassunto dei 14 progetti: https://www.lindipendente.online/2025/11/15/data-center-in-italia-14-progetti-gia-approvati-quali-sono
Un esempio di previsioni di enorme crescita dei consumi misto a greenwashing AI: https://www.repubblica.it/dossier/economia/transizione-sostenibile/2025/09/06/news/l_italia_dei_data_center_da_giganti_energivori_a_motori_della_sostenibilita-424830538
Sempre Repubblica con la bava alla bocca per la “opportunità da 165 miliardi di euro”, con punto orwelliano per cui far esplodere il consumo elettrico dei datacenter al 10% del consumo totale… ridurrebbe la produzione di CO2: https://www.repubblica.it/tecnologia/2025/12/17/news/la_mappa_dei_data_center_italiani_un_opportunita_da_165_miliardi_di_euro_in_dieci_anni-425045584
Giulia Pastorella (deputata di Azione) si lamenta dei ritardi al bomba libera tutti dei permessi: https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/data-center-in-italia-perche-la-legge-non-puo-piu-aspettare
Questo aspetto della questione – che, come scrive WM1, è assolutamente centrale – si lega al problema di come viene prodotta e distribuita l’energia necessaria al funzionamento concreto dell’IA, da chi viene prodotta, dove viene prodotta, secondo quali “rapporti di produzione”, con quale impatto ambientale e sociale, ecc. ecc. Il nesso con l’aggressione di stampo brutalmente coloniale in corso in questi anni soprattutto in Sardegna e, in maniera simile, in qualche area del Mezzogiorno italiano, è evidente. O lo sarebbe, se la faccenda uscisse dal cono d’ombra in cui è relegata.
Per garantire il funzionamento dei mega data center – posti in quelle aree che i vertici di Terna e il governo Meloni hanno definito “le più produttive del Paese” – l’energia necessaria sarà prodotta in quelle che sono considerate – e conseguentemente trattate – come “aree di sacrificio”. Naturalmente la propaganda che sostiene questa gigantesca operazione neo-coloniale ed estrattiva si basa sulla retorica della transizione energetica (o addirittura *ecologica*): greenwashing brutale. Ovviamente di ecologico nell’installazione di decine, centinaia di giganteschi rotori, alti, dal suolo, anche 250 metri, o di distese di accumulatori, in aree di pregio naturalistico o storico-archeologico, ovvero in zone a vocazione agricola, non c’è assolutamente nulla. Basti anche pensare ai costi di trasporto e ai lavori di sbancamento di intere colline e distese boscose necessari solo per far transitare i mezzi (tutta roba documentata e fin troppo visibile). Da notare che in tutto questo non hanno alcun ruolo il consumo energetico locale, le necessità basilari delle popolazioni coinvolte. Finisco sottolineando il dato della produzione energetica in Sardegna, che eccede già oggi del 40% il fabbisogno interno. Insomma, è sacrosanto, quando si parla di IA, considerare anche tutte le premesse materiali, sociali, ecologiche e dunque politiche che la riguardano.
[Sulle questioni letterarie.] WM1 correttamente dice che “starebbero parecchio in fondo”. Eppure le multinazionali dell’AI ci stanno molto attente, perché sono un aspetto della guerra ideologica. Già nel 2019 Microsoft organizzò un panel a un convegno della MLA – associazione Usa di studiosi di lingua e letteratura – per presentare GPT-2 e porre questioni provocatorie su AI e autorialità. Alla pubblicazione del famoso paper dei “pappagalli stocastici”, Google licenziò una delle autrici. Certo perché faceva inaccettabili richieste “decel” di paletti all’implementazione dell’AI, ma cosa gravissima lo faceva sulla base di considerazioni teoriche. La questione di dove sta il significato di un testo ha impatti diretti sullo sviluppo di queste tecnologie e sulla legittimità dei loro prodotti, e big tech coerentemente promuove prospettive teoriche “compatibili”. Nel nostro cortile, si può vedere un esempio misero di questo carico ideologico nella pochezza argomentativa mista a sarcasmo adolescenziale di un pezzo uscito su Indiscreto a titolo “I Don Ferrante della IA”. Più dignitoso un altro “Le AI sognano pappagalli stocastici?”, dove però si finisce per presentare come punto di equilibrio una posizione ultra estremista come quella di Daniel Dennett (che sosteneva che la coscienza è un’illusione. A chi gli chiedeva “illusione di cosa?” rispondeva “di nulla!” e credeva di aver risolto il problema). È importante dunque approfondire anche questi aspetti, per essere in grado di sbrogliare gli interventi interessati dalle genuine complessità teoriche. Ho trovato idee utili nel lavoro di Hannes Bajohr, uno studioso tedesco, su vari corni della questione: quello autoriale con “Writing at a Distance: Notes on Authorship and Artificial Intelligence”, quello semantico con “Dumb Meaning. Machine Learning and Artificial Semantics”, quello delle aspettative dei lettori con “On Artificial and Post-artificial Texts: Machine Learning and the Reader’s Expectations of Literary and Non-literary Writing”. Segnalo anche “Poetry will not optimize” di Michele Elam. Non posso entrare nel dettaglio, mi limito a un invito alla lettura.
Ma perché non dovremmo accettare che l’AI simuli la superficie comportamentale dell’esperienza umana? Se la simula bene, magari meglio di come la descrivono a volte gli umani stessi, perché dovremmo escluderla a priori? A me “diventa mio figlio” non è dispiaciuto, l’ho trovato strano ma mi ha fatto riflettere. La questione ambientale ha senso, ma bisognerebbe fare un paragone con quanto consuma un essere umano e per fare cosa. Non penso che si debbano vedere le produzioni dell’AI come contrapposte a quelle umane. Alla fine è come tutte le tecnologie, utili se usate con buon senso, uno spreco se di risorse se usata stupidamente.
Il punto è che non è vero che “tutte le tecnologie” dipendono da come le usi tu, singolo individuo, se con buonsenso o stupidamente.
Questo può valere giusto per tecnologie molto semplici, utensili basilari, il cui valore d’uso è trasparente (e del valore di scambio quasi ti dimentichi). Un martello, per dire. La sua logica di fondo non è equivocabile, sono pochissimi gli “algoritmi” inscritti in quell’oggetto e l’utilizzatore ce li ha chiari quanto il fabbricante: lo usi per piantare chiodi, lo usi per spaccare la testa a qualcuno, poco altro. Inoltre, dopo che lo hai usato, lo riponi, e se non lo usi per mestiere o per hobby chissà quando ti ricapiterà di usarlo. Non ci sono spinte sociali a usarlo in un modo continuativo che inneschi mutazioni antropologiche. E un martello quante volte lo compri nella vita?
Al di sopra di questo livello basic, le cose cambiano di parecchio: le tecnologie incorporano in modi complessi i rapporti sociali che le producono e i bias ideologici di chi le produce, rispondono a logiche di fondo che sfuggono ai più e soprattutto non si capiscono se partiamo dall’utilizzo individuale, dal “diritto” del singolo di utilizzarle ecc. È il loro uso di massa il punto, sono gli incentivi sociali e commerciali a usarle il problema. Vale tanto per l’automobile (abbiamo visto le conseguenze urbanistiche, sociali e ambientali del bias ideologico a favore del trasporto privato individuale, bias che ha plasmato la tecnologia stessa e vi è inscritto dentro) quanto per la slot machine (un perfetto esempio di tecnologia che si può usare solo male), vale per quei social media che ciascuno si illude di usare “a modo suo” mentre i suoi comportamenti sono pilotati algoritmicamente e gamificati, e le vite di tutti vengono trivellate per estrarne dati (nella massima opacità ovviamente). L’attuale modello di sviluppo delle IA alza drasticamente tutti i cursori di questo mixer, è veramente ingenuo ridurre tutte le contraddizioni in campo al “dipende da come la usi”. E mi sono limitato a tecnologie di uso civile, figuriamoci quelle militari.
Quanto all’impatto ambientale, non scherziamo, sfida l’immaginazione leggere di quanto schizzerà fuori scala il “fabbisogno” di energia, materie prime e acqua, e che impatto avrà la proliferazione di centri dati sui territori se si continua a questo ritmo. Tarare i ragionamenti sull’esperienza dell’utente a valle di tutto il processo è terrificantemente fuorviante, le domande necessarie riguardano ciò che accade prima.
C’è un elemento in più da tener presente: questa è la prima macchina che ti “parla” e ti “capisce” (spesso di più di tanti amici e familiari – almeno ti sembra).
Ci sono sempre stati quelli che la domenica lavano la macchina e l’accarezzano come un’amante, ma l’automobile in se non fa nulla per farsi apprezzare.
L’IA è progettata per accondiscendere e accettare che ti mostri a “lei” senza filtri.
“Gli incentivi sociali e commerciali” di cui parli con l’IA sono poca cosa, qui è la capacità di essere così “servizievole” che induce chiunque la usi a reiterare l’esperienza.
È ormai dimostrato, per esempio, che i chatbot relazionali generino dipendenza e psicosi e amplifichino i deliri di chi è instabile.
Ci sono fior di studi accademici che lo confermano.
Il problema che sollevavo nell’altro mio commento è che molta gente fatica a capire che si tratta di una macchina.
Mentre il trapano, ma anche l’automobile che pur viene carrozzata con un aspetto accattivante, sono macchine per (quasi) tutti.
Questa “macchina” non ha un corpo riconoscibile e tradisce i sensi.
È vero Valerio, noi tendiamo a umanizzare tutto e qualsiasi cosa.
Anche in questo caso, gli intruppi col confessore cibernetico non sono iniziati ieri. Verso la fine degli anni ’60 il MIT realizzò ELIZA, una specie di proto-chatbot che rispondeva alle domande dell’utente facendo frullare algoritmi molto rudimentali. Nonostante la pochezza, molti ne rimasero impressionati, anche per via dello stile delle risposte, della serie “sei sicuro che…? Hai pensato bene a…?”.
David Avidan, addirittura, pensò bene di utilizzare un derivato di questa ELIZA per mettere insieme niente popò di meno che un libro su delle conversazioni intrattenute con la macchina, dall’inquietante titolo “My Electronic Psychiatrist: Eight Authentic Talks with a Computer”.
Tutto si tiene, anche se preferiamo il presentismo, nei ricorsi della storia.
Poi volevo ricollegarmi al discorso sulla neutralità della tecnologia. Al netto dell’uso più o meno fruttuoso che si riesce a fare dei vari chattini, questa ondata di GenAI prosegue su un tracciato assai nefasto rispetto al rapporto tra umano e tecnologia. La silicon valley non riesce a produrre valore d’uso che si venda da solo più o meno dalla commercializzazione del primo s.o. a interfaccia grafica, e perciò ha cambiato sport ormai da anni: si occupa, in effetti, di engagement, e per eccellere in questo sport ha dovuto stravolgere la stessa infrastruttura epistemica dell’umanità –di questo abbiamo parlato in lungo e in largo anche qui su GIAP, ci sono studi stra-noti ormai su come i vari social abbiano letteralmente creato delle patologie.
Come ha notato Valerio, anche i chatcosi proseguono su questa tendenza grazie al combinato disposto dell’enorme hype e allo stile di consumo per il quale sono progettati. Purtroppo, molte persone tenderanno inevitabilmente a usarli come confessori, come risponditori di domande altrimenti inconfessabili e tutta ‘sta monnezza qui.
«È ormai dimostrato, per esempio, che i chatbot relazionali generino dipendenza e psicosi e amplifichino i deliri di chi è instabile.»
Innanzitutto mando un rispettoso e speciale saluto a Valerio Minnella.
Dice bene, il rischio di dissonanza cognitiva tra l’operatore e la macchina è fuori scala nelle interazioni con un chatbot.
La nostra miglior amica non potrebbe proprio competere. Sul campo delle possibili combinazioni di parole che uno qualsiasi di questi virtuosi marchingegni del travestimento linguistico è capace di restituire, soltanto un prolungato abbraccio o una serata di bagordi in buona compagnia potrebbero alleviare il malessere. I corpi inisieme, piu che le parole. Su quel campo possiamo ancora competere e vincere.
Il punto cruciale, secondo me, importantissimo quanto difficile da tener presente, è che questi cosi non ci stanno realmemnte rispondendo.
Piuttosto imitano la voce del personaggio che credono noi vogliamo ascoltare.
Nel tentativo di scoprire i suoi veri scopi e desideri, rischiamo di restare intrappolati nelle nostre stesse narrazioni che si autoalimentano.
Se un amico mi confida di essere stato rapito e vivisezionato da un alieno, o che Wu Ming in realtà è un collettivo di neo-nazi in incognito, ho tutto il diritto/dovere, ad un certo punto, di dargli il palo o consigliargli una qualche terapia. Un chatbot lo tirerà dentro la sua stessa paranoia.
Come gli antichi oracoli, spesso enigmatici e fallibili anche per i loro devoti, i doni e le verità del GLLMM sono quelli di un trickster. Sotto questo aspetto, la situazione sociale/politica attuale a me pare confermare che trattasi di “self-fulfilling prophecy” su larga scala.
Bella discussione. Here’s my 2c.
Invogliato da questo articolo di WM1 ho iniziato a leggere «Nell’occhio dell’algoritmo. Storia e critica dell’intelligenza artificiale» di Matteo Pasquineli. Consigliatissima analisi materialista della situazione.
Sintetizzando che di piu non si potrebbe.
Seguendo Pasquinelli (che parte da una stupenda analisi storiografica dell’algoritmo) il codice che governa l’IA non nasce nel cervello ma nella coreografia sociale del lavoro: nei gesti ripetuti, nelle procedure collettive che il capitale traduce in macchine e archivi di sorveglianza.
L’algoritmo è quindi una mappa del potere travestita da mente, un’astrazione che cattura pratiche vive e le restituisce come efficienza.
Qui secondo me ci torna utile la magia critica dell’amico Mariano Tomatis che io trovo offre un meraviglioso controcanto: come esperti di mentalismo e magia che smontano un effetto speciale per mostrarne i meccanismi, possiamo guardare all’IA come al più sofisticato trucco contemporaneo, meraviglia programmata che nasconde filiere di sfruttamento, gerarchie invisibili e incalcolabili esternalizzazioni ambientali. Basta sforzarsi (e informarsi) un attimo.
Inoltre, come suggerisce Derrida in «La farmacia di Platone», dove sostiene che la scrittura è un pharmakon, insieme rimedio e veleno, anche l’IA è ambivalente: cura l’inefficienza e, al tempo stesso, avvelena la trasparenza delle pratiche sociali, mascherando la dipendenza da infrastrutture materiali e l’estrazione di risorse sotto un’aura di neutralità tecnica.
Non si tratta di demonizzare la tecnica, ma di restituire al segno il suo corpo: riconoscere che ciò che chiamiamo “intelligenza” è automazione della cooperazione umana, e che la meraviglia, quando non ci si lascia catturare dal marketing del digitale, può anche diventare pratica di emancipazione.
Matteo – mi farebbe strano chiamarlo per cognome perché eravamo coinquilini – proviene, come noi, dalla colonna bolognese del Luther Blissett Project, in modi diversi andiamo sviluppando spunti che volavano in tondo dentro quel tornado artistico e culturale.
Del suo approccio defeticizzante e della sua critica materialistica dell’IA apprezzo proprio la ricostruzione genealogica, il rintracciare le origini degli odierni miti sull’IA nella junk-science basata sulla psicometria nel XX secolo e sulla craniometria nel XIX. Psicometria e craniometria che, come giustamente scrive, sono al massimo «discipline» ma non scienze. Fondamentale è stato anche il ricorso alla statistica per produrre rappresentazioni normalizzanti dei comportamenti sociali.
Cruciale, in questo percorso, è stata l’invenzione del «quoziente d’intelligenza», basato su un’idea angusta e mentecatta di intelligenza, parametro di misurazione il cui successo anche pop non ha tanto a che fare con l’esattezza scientifica, quanto con finalità tecnopolitiche: il QI serviva a gestire meglio, e fin dalla scuola, la divisione classista/razzializzata del mercato del lavoro. Ed è in base a quell’idea tutta strumentale di intelligenza che oggi, senza colpo ferire, possiamo chiamare «intelligenza» la capacità di calcolo su cui si basa un LLM.
La psicometria era appena più sottile di sua madre, la craniometria, che era più esplicita nel costruire sulla misurazione – in quel caso non intellettiva ma fisica – una teoria di razzismo scientifico che doveva giustificare le gerarchie sociali e tra popoli.
L’IA si porta dentro tutta questa storia, e si vuole imporla come nuova metrica sociale gerarchizzante. Non a caso le narrazioni propagandistiche descrivono chi “è contro l’IA” come arretrato, incapace di adattarsi, in fondo inferiore, perciò il suo lavoro è meritevole di scomparire, e in definitiva anche il suo modo di vivere.
Naturalmente, e questo Matteo lo spiega molto bene, ci saranno meno «scomparse» di quanto faccia credere questa retorica. Accadrà molto più spesso che, a causa dell’IA, peggiorino le condizioni in cui si svolge qualunque lavoro, perché l’adozione di queste macchine aumenta precarizzazione e ricattabilità, e in qualunque settore i padroni pretenderanno che ogni compito venga svolto più velocemente.
Grazie del chiarimento. La vostra discussione è molto interessante ed è a un altro livello rispetto al mio commento, che era più sulla questione banale se sia etico/sensato che l’AI produca materiale artistico. Probabilmente è solo un aspetto molto contingente dell’intera questione però forse è anche uno dei pochi punti di connessione tra l’AI e tutto quello che c’è dietro e la vita quotidiana delle persone. Poter usare questa tecnologia usare con buonsenso implica ovviamente avere consapevolezza, se non di tutte le questioni che voi ponete e che sono anche abbastanza complesse, almeno di quelle principali (impatto ambientale ad esempio), senza esserne risucchiati come accaduto coi social. Questo intendevo dire: se usata con consapevolezza può essere meno dannosa.
Tornando allo specifico della letteratura: quì sappiamo tutti che esistono già generi che si adattano perfettamente all’efficienza richiesta dal mercato: un caso su tutti di scuola di quello che potremmo definire “prodotto algoritmico” è il cosidetto “Romantasy”: serializzabile, ottimizzabile e perfettamente allineato alle logiche di “engagement”.
Ovviamente, a oggi, uno dei generi più redditizi, con vendite globali milionarie e in crescita continua (richiamando ancora Mariano Tomatis, uno dei titoli di maggior successo in Italia si intitola «La mesmerista» :))
La sua forza sta nella prevedibilità: tropi ricorrenti, climax romantico obbligatorio e “worldbuilding” standardizzato. Alla faccia di Tolkien che ha speso gran parte della sua vita a “immaginare” la Terra di Mezzo. Ora è questione di secondi.
Una tale struttura rende il genere perfetto per la produzione algoritmica: un LLM puo ricombinare pattern narrativi senza bisogno del corpo, di attingere quindi all’esperienza vissuta, generando storie perfettamente “funzionanti/funzionali” per il mercato. Un ricombinare conoscenza [nozioni aquisite in rete] continuo e veloce quanto serve, che trasforma la cultura in un processo automatizzato. Che dire: un prodotto (editoriale) perfetto.
PS: nel precedente post ho usato la parola esternalizzazioni (che non è del tutto sbagliata) ma intendevo esternalità. Sorry!
Faccio una piccola considerazione oziosa, a fronte delle immense questioni ambientali e biopolitiche che ci troviamo di fronte. Quello che mi sfugge completamente è il senso di far fare a una macchina le cose piacevoli della vita: scrivere un racconto, suonare uno strumento musicale, chiavare… Capisco far fare a una macchina la dichiarazione dei redditi, o mandare un androide all’assemblea di condominio. Ma perché rinunciare a inventarsi una storia, a costruire un sound con la band, a cavar fuori un drago da una radice trovata nel letto del fiume? Andrà a finire che l’unica cosa che continueremo a fare “a mano” sarà il lavoro di merda. Mi sa che tutto questo hype per la macchina che vive al posto nostro non è lontano dall’hype degli accelerazionisti per il lockdown, che doveva liberarci da ogni male togliendoci la gioia di vivere.
Quello che hai appena scritto me lo farei tatuare sulle chiappe.
E sì, anche per me la continuità con gli iettatori accelerazionisti e le utopie distopiche della lockdown culture è totale, anche negli espedienti a cui si ricorre nel dibattere, avanzando pseudo-obiezioni infuse di odio del vissuto corporeo. Ripropongo quanto scriveva Wolf in piena pandemia:
https://www.wumingfoundation.com/giap/2020/04/max-headroom-19-pandemia-e-societa-senza-corpi/
Non è oziosa per nulla, questa considerazione. Una gran parte del marketing della cosiddetta “IA” generativa insiste proprio sulla “democratizzazione della creatività”, secondo cui modelli linguistici, di immagini, di suono e video permetteranno a tuttə di essere artistə, in una concezione dell’arte finalizzata esclusivamente a visibilità, successo e guadagno che non differisce in nulla dalla logica dell’influencer sui social media. Una visione che è l’esatto contrario di quello che dice WM1 qui sul senso della (e su cosa chiediamo alla) letteratura. Nei discorsi degli entusiasti dell’IA, tutto il processo di studio, creazione, lavorazione, errore, fallimento, rielaborazione viene rimosso completamente, con un disprezzo dell’umano (e dell’impegno svincolato da logiche economiche) che non ha pari: il processo creativo, letterario o meno, non è solo un lavoro corporeo ma è anche lo spazio in cui si costruisce il pensiero, l’intenzione creativa e comunicativa (che alla macchina manca sempre, per sottolineare l’ovvio). Se io delego la creazione a una macchina, io non scrivo, non suono, non dipingo, non metto in funzione le capacità cognitive incarnate che sono necessarie all’espressione del mio essere umano. L’arrivo dei sistemi di “IA” sembra così voler completare il percorso di livellamento e banalizzazione della produzione culturale causato anche dai sistemi algoritmici (fenomeno che Kyle Chayka spiega bene in “Filterworld”), in cui l’obiettivo sembra essere la rimozione dell’umano dall’equazione, limitando il suo ruolo a mero consumatore di prodotti standardizzati dopo che da anni viene abituato a rifiutare la complessità, per eliminare costi e massimizzare profitti.
Ieri a un certo punto è cominciata a girare la notizia della morte di Bob Weir, the other one dei Grateful Dead, e così è successo che ho passato gran parte della giornata a guardare filmati e registrazioni di concerti dei GD. Se c’è una band che incarna fino in fondo quel che scrive qua sopra WM1 della letteratura e dell’arte in generale come forma di espressione comunitaria e vissuta coi corpi, quella band sono i Dead. C’è in rete il filmato di un concerto a San Francisco nella primavera del ’68, un concerto in strada coi Dead che suonano sopra il rimorchio di un camion, come in una street parade ma sono fermi. Non c’è nessuna separazione tra band e pubblico, e tutto intorno migliaia di persone occupano un intero quartiere, molti ballano sui tetti, venti metri sopra il marciapiede, vengono le vertigini solo a vederli. La città è brulicante di vita. Ricordo di aver guardato quel filmato anche durante il lockdown del 2020, con lacrime di rabbia. E poi, leggendo questa discussione su giap, mi è tornata in mente una conversazione che ho avuto con un tizio qualche mese fa. Il tizio diceva: i Beatles ci hanno messo dieci anni per fare dieci dischi. Con l’AI dieci dischi li fai in un pomeriggio, e con una qualità del suono molto migliore.
C’è moltissimo da imparare studiando il rapporto intenso e unico tra i Grateful Dead e la vasta, multiforme comunità che gli si era formata intorno e li seguiva in tour: la comunità Deadhead, col suo linguaggio, i suoi rituali e modi di stare insieme, i suoi mercatini, le sue fanzine e autoproduzioni, il suo inestimabile lavoro di preservazione della memoria dei concerti della band (l’archivio è qui, un diverso concerto dei Dead al giorno toglie la cupezza di torno). Se si va oltre il “pittoresco”, si scopre un tesoro di storie e di esempi.
Ho qui davanti un vecchio libro di David Shenk e Steve Silberman, Skeleton Key: A Dictionary For Deadheads (Doubleday, 1994). Collegando tra loro vari lemmi si ricavano storie complesse e istruttive. Ad esempio: Parking Lot Scene, Mega-Dead e Minglewood Town Council.
La “scena del parcheggio”, o “spettacolo prima dello spettacolo”, era l’insediamento nomade di furgoni, vecchi pullman personalizzati, roulottes, bancarelle, piccoli palchi ecc. che i Deadheads allestivano nei piazzali davanti ai luoghi dove quella sera avrebbe suonato la band. La “strada principale” del villaggio era sempre chiamata Shakedown Street, c’erano banchetti e cucine mobili di ogni tipo, c’erano compravendite ma si praticava molto anche il baratto. C’erano artisti di strada, musicanti, cuochi, maghe, gente che meditava o chiedeva firme per petizioni, ovviamente si aggiravano bagarini… Quando il concerto iniziava, il villaggio si assopiva, per risvegliarsi subito dopo l’ultimo bis, finché a una certa ora non si smontava tutto e ci si dava appuntamento al concerto dei Dead successivo, che era tipo la sera dopo a cento miglia di distanza.
“Mega-Dead” è il periodo che va dal 1987 alla morte di Jerry Garcia nel 1995. Si chiama così perché quando il singolo A Touch Of Grey inaspettatamente scalò la classifica USA, un pezzo di America mainstream scoprì la band, le folle ai concerti diventarono oceaniche, spesso i nuovi fan si dicevano “deadheads” ma non conoscevano i particolari codici di condotta di quella sottocultura, né capivano la particolare atmosfera che la band cercava di creare durante i concerti. Ci furono incidenti, nei parcheggi scoppiarono risse e addirittura tumulti, con interventi della polizia. Conseguenze del troppo successo, della troppa visibilità, di una dimensione che rischiava di omologare i Grateful Dead al resto della scena rock, rispetto a cui erano sempre stati anomali e indipendenti. A un certo punto minacciarono di non suonare più dal vivo, così i Deadheads si organizzarono per risolvere i problemi in autogestione, senza la polizia. Formarono il
“Consiglio comunale di Minglewood”. Minglewood è una località immaginaria legata alla tradizione blues, New Minglewood Blues è uno dei pezzi più famosi dei GD. A tutti i concerti del biennio 1988-1990 i Deadheads distribuirono volantini dove si leggeva:
«Coraggio, unitevi a noi. Il Consiglio comunale di Minglewood è uno stato d’animo, il nostro scopo è farci capire da quei deadheads che non rispettano le comunità che invadiamo per goderci l’esperienza di un concerto […] Nei paraggi dei concerti si vedono persone che fanno apertamente uso di droghe, urinano e defecano in pubblico, la gente si lamenta perché trova sull’uscio di casa deadheads che dormono o fanno sesso. Questo non è un comportamento responsabile da parte nostra […] Dobbiamo incoraggiarci a vicenda. Incanaliamo l’energia positiva che collettivamente generiamo, e usiamola per creare nella scena un’atmosfera più lieta, sicura e responsabile.»
Sono testimonianze di congiunzione, di prima che si fosse «iperconnessi», e più soli. Sono dimensioni a cui dobbiamo riattingere.
Il documentario del 2015 The Other One: The Long, Strange Trip of Bob Weir è bellissimo e si può vedere anche gratis su una di quelle celeberrime piattaforme che noi non linkiamo :-)
Certo che è davvero incredibile come tutto si tenga insieme in questa discussione. Non so se tuco ha tirato fuori i GD per qualche assonanza cognitiva metafisica, ma ricordo che proprio alcuni deadhead illustri misero in piedi quello che è considerato il primo forum online della storia. Si chiamava The Well e viaggiava su BBS. Nacque se non sbaglio come idea per mettere a disposizione online il Whole Earth Catalog, ma crebbe soprattutto come mezzo di connessione e discussione online tra deadheads.
Putroppo anche qui c’è una parabola che finisce male, come spesso capita se si guarda alle singole storie nell’epopea delle controculture di fine anni ’60. La grande lavatrice del riflusso ne ha disperso i rivoli, quando non li ha proprio trasformati in qualcosa di diametralmente opposto alle intenzioni iniziali. “Stay hungry, stay foolish” formula che molti pensano sia stata inventata da Jobs, in realtà è la citazione di un motto del Whole Earth Catalog. Da manifestazione di uno spirito fortemente controculturale a frasetta inspirazionale scritta sulle buste della spesa.
Amarcord finale:
The Well ancora esiste(l’ho scoperto ora) => https://www.well.com/
Numero di primavera ’69 del WEC => https://wholeearth.info/p/whole-earth-catalog-spring-1969
Ringrazio Tuco e ringrazio Andrea OLivieri per avermi segnalato questo scritto di Wu Ming 1, Ci sarebbe molto da dire e riflettere sull’artcolo, che presenta spunti molto interessanti, sui quali concordo, ma voglio qui soffermarmi sul riferimento alla comune e all’esperienza dei Grateful Dead e sulla loro valenza politica e culturale. Sono diventato Deadhead a 14 anni (ora ne ho 66) ascoltando Dark Star. Ho studiato, da Deadhead,il fenomeno politico-culturale dei Dead da anni (ho pure scritto un liberculo che si intitola Grateful Dead Economy, edito da Philopat), per analizzare come gli antisistemici o gli anti-capitalisti sono quelli che salvano il capitalismo. Se oggi esiste il capitalismo delle piattaforme e la Silicon Valley è perchè nella controcultura di fini anni ’60, nella nascita dei compuyter club di meta anni ’70 e nella cybercultura degli anni ’80 si sono sviluppate quelle innovaziuoni tecnologiche, sociali e culturali che poi sono state sussunte dalla logica del profitto e dalla logica di impresa sino a costituire la tecno-oligarchia dei Bezos, Musk, Zuckerberg, Thiel, ecc. di oggi. E’ quello che chiamo “processo di sussunzione vitale”. La domanda che oggi dobbbiamo porci oggi, ai tempi dcell’IA, credo sia la seguente: è necessario che passi un lungo tempo di dialettica per far sì che le idee antagoniste vengano catturate, manipolate, sussunte per essee nuova linfa del potere che volevano combattere? Non è che l’IA può svolgere direttamenge questo compito, nell’arte, come nella letteratura e nella vita umana, rendendoci robot lobotomizzati (come già cantavano gli Area negli anni ’70)?
Benvenuto, Andrea, e grazie. Giustissimo, John Perry Barlow che da paroliere dei Grateful Dead diventa alfiere del libertarianismo nel cyberspazio; l’«ideologia californiana» come integrazione col neoliberismo rampante degli aspetti più individualistici della controcultura Sixties… Per arrivare alla Silicon Valley di oggi si è passati anche da lì. Alla tua constatazione, più che centrata, affiancherei un caveat a beneficio di chi ci legge, su cui non dubito sarai d’accordo: c’è sempre un’eccedenza che non viene sussunta. Se la sussunzione – o il recupero, volendo usare un termine della “critica radicale”, che però rispetto a sussunzione ha connotati più moralistici – dell’esperienza vissuta da moltitudini intorno ai GD fosse stata totale, se questo processo consistesse in una spremitura completa di ogni limone di vitalità e diversità culturale, oggi un nome come «Bob Weir» significherebbe ben poco, e invece milioni di persone lo salutano come uno che ha contribuito a rendere le loro vite più piene e più belle.
Quanto alla domanda che poni, la giro a tutte e tutti.
Un po’ di rassegna stampa sul libro di Andrea Fumagalli Grateful Dead Economy:
Money In The Sky With Diamonds – Effimera (recensione)
https://effimera.org/andrea-fumagalli-money-the-sky-with-diamonds-stefano-lucarelli/
Una prassi visionaria per vite precarie – Il manifesto (intervista)
https://ilmanifesto.it/una-prassi-visionaria-per-vite-precarie
L’anarcocapitalismo e la Grateful Dead Economy – Che Fare (estratto del libro)
https://che-fare.com/articoli/grateful-dead-economy
La parabola di certi pezzi di controcultura californiana mi suggerisce nuove chiavi di lettura, più sottili, a “California uber alles” di Jello Biafra…
Quanto alla domanda finale di Andrea Fumagalli, secondo me l’AI tra poco comincerà a sussumere se stessa, perché i suoi tempi sono talmente rapidi che si troverà a bypassare non solo la fase dialettica della cattura e della manipolazione, ma anche quella della produzione. Lo sfasamento tra il tempo dell’AI e quello della vita biologica potrebbe però aprire possibilità, a patto che ci si imponga la disciplina necessaria per sottrarsi al dispositivo.
Grazie per il post e i commenti!
Conosco poco il lavoro dei Grateful Dead, riprendo ad ascoltarli di tanto in tanto ma è un mondo… a ogni modo c’è una cosa su cui sto riflettendo e ho due esempi freschi:
Il primo sono i sonetti di Shakespeare; ho letto che ci sarebbero “poesie” scritte da/con IA che “non sarebbero distinguibili” da quelle di WS, così ho preso la mia copia e ho iniziato a leggerli: nonostante il mio livello di inglese sia abbastanza buono non c’ho capito molto, per due motivi credo: perché sono scritti con termini che non conosco perché di un inglese più “vecchio” di quello che frequento e perché essendo poesia ha un suo lato “oscuro” anzi – come scrive Barthes per le foto – ottuso; Mi viene da pensare anche che un altro motivo ancora sia la frequentazione, che è ciò che permette una “comprensione” delle poesie (di qualunque opera artistica). Di quanti ascolti si ha bisogno per comprendere qualcosa del Don Giovanni di Mozart? E basta uno sguardo per Il grande vetro di Duschamp? C’è bisogno di tempo per andare a fondo, entrare in relazione con l’opera (libro, teatro, canzone, foto, quadro è uguale), proprio *quel* tempo che ci viene sottratto, negato
Tempo quindi per la creazione e per godere del sapore che una creazione artistica da.
In un articolo su Rolling Stone (letto stamattina grazie a WM1) riportano la testimonianza di Mayer – chitarrista che ha lavorato con Weir – il quale, parlando dello stile dell’amico, dice: “His take on guitar chords and comping is almost too original to be fully appreciated until you get deep down into what he’s doing.” Proprio quel “until you get deep down” relativo a una profondità che non puoi raggiungere se non dopo un “certo tempo” (diverso per ciascun*: mesi, anni…) di lavoro *su* un’opera. Questo per dire che sarà anche vero che con una IA posso scrivere un sonetto “simile” a uno di Shakespeare (ne dubito, ma facciamo finta) o dieci dischi in un giorno piuttosto che in dieci anni come i Beatles, ma non ci sarà niente da capire in queste opere, niente in cui andare “deep down” perché non c’è, e non può esserci, profondità o quella parte “ottusa” di cui sopra. Saranno “simulacri di”, superfici buone per ascolti e sguardi frettolosi, che si accontentano di cose “uguali”, ovvie
l’articolo: https://www.rollingstone.com/music/music-features/bob-weir-guitar-playing-influences-impact-1235497555/
Il riferimento ai sonetti di Shakespeare mi ha riportato alla mente un passaggio di Knife, il libro in cui Salman Rushdie racconta i postumi dell’attentato subito nell’estate 2022, quando fu attaccato e più volte accoltellato durante un evento pubblico, e fu salvato per il rotto della cuffia. Nel libro l’attentatore non è mai chiamato col suo nome, è sempre e solo «the A.», che vuol dire «assassin» ma anche – Rushdie non lo dichiara ma lo fa capire molto bene – «asshole».
A un certo punto Rushdie definisce il coltello un’arma che, richiedendo un contatto ravvicinato, crea «intimità» tra carnefice e vittima, poi scrive (traduzione mia, quella pubblicata in Italia non ce l’ho):
«Secondo i giornalisti, l’A. ha trascorso con me ventisette secondi. In ventisette secondi, se per caso hai una mentalità religiosa, puoi recitare il Padre nostro. O, lasciando perdere la religione, puoi leggere ad alta voce uno dei sonetti di Shakespeare, magari quello sul giorno d’estate, oppure il mio preferito, il n.130: “Gli occhi della mia amata non sono per niente come il sole”. Quattordici versi in pentametri giambici, un’ottava e una sestina: ecco l’equivalente della durata dell’unico momento di intimità che avremo mai vissuto insieme. Un’intimità fra estranei. È un’espressione che a volte ho usato per esprimere la gioia che si prova leggendo, la felice unione delle vite interiori di autore e lettore.»
Questo doppio parallelismo tra leggere ad alta voce un sonetto di Shakespeare e l’essere corpo a corpo con uno che cerca di ucciderti, e tra la quasi letale intimità di quel momento e il gioioso rapporto tra chi scrive letteratura e chi la legge, rende il passaggio spiazzante e possente. Non solo la durata della lettura del sonetto è rivissuta col corpo nel frangente più drammatico, diventa questione di vita o di morte, ma, inaspettatamente, in un siffatto flusso di pensieri trova spazio il ricordo intimo, incarnato, della gioia provata da lettore entrando, tramite le parole, nella mente di uno scrittore o scrittrice.
Subito dopo, Rushdie mette in fila considerazioni sul fatto che, dopo le numerose coltellate e mentre giaceva in una pozza di sangue, non ha avuto alcuna esperienza di “uscita dal corpo”, anzi: «Raramente mi sono sentito tanto fortemente legato al mio corpo: il mio corpo stava morendo e mi stava portando con sé».
Non credo ci sia bisogno di ulteriori glosse.
P.S. Nella sua testa, l’A. stava eseguendo la sentenza di morte contro Rushdie comminata trentatré anni prima, nel febbraio 1989, dall’ayatollah Khomeini, allora massima autorità del regime teocratico iraniano. Lo stesso regime, mutatis mutandis, che in questi giorni reprime gli ennesimi – ma stavolta più estesi – moti di piazza dandosi alla mattanza senza freni.
Mi lascia un po’ perplesso l’idea che l’AI si trovi su un plateau da cui difficilmente potrà evolvere, e mi chiedo fino a che punto abbia senso ripetere che in realtà un LLM non sa niente. Definire chatbot come Chatgpt o Gemini come modelli linguistici di grandi dimensioni che generano frasi solo grazie a complessi calcoli probabilistici completamente scollegati dal significato sarà tecnicamente corretta, ma mi sembra riduttiva e fuorviante. (A parte il fatto che, se non esiste riferimento al significato, almeno da parte dell’emittente, mi chiedo se possiamo ancora parlare di linguaggio). Oltretutto ogni riflessione sull’intelligenza artificiale andrebbe fatta cercando di guardare un po’ avanti, altrimenti rischia di nascere già vecchia. Ma avete mai provato a discutere a fondo di temi tecnici o scientifici (per fare un esempio) con questi modelli? Io trovo già adesso il livello delle risposte decisamente impressionante. Affascinante dal punto di vista tecnico e spaventoso sotto tutti gli altri, da quello ambientale, a quello socio-politico, fino a quello cognitivo. Non è la paura che l’intelligenza artificiale diventi più brava dell’uomo, che prenda il sopravvento e che addirittura si ribelli, non credo siano quelli i veri rischi. Ma un chatbot che è in grado di darti istruzioni per fare un circuito elettrico o scrivere un programma informatico comprendendo quello che ti serve, commentando in modo pertinente e dando suggerimenti utili è un po’ oltre il modello che mette insieme parole in modo probabilistico senza sapere quello che “dice”. (continua)
(continua) Anche il fatto che non sappia dare l’ora esatta mi sembra un dettaglio tecnico insignificante. Se lo scopo di Chatgpt fosse dirti che ora è, se la funzione fosse richiesta e redditizia potrebbe essere facilmente implementata e lo sarà (tra l’altro a me Gemini ha dato subito la risposta giusta). Quello che mi chiedo è che effetti avrà nella società e nella mente umana l’uso prolungato e diffuso di questi strumenti, che già adesso danno risposte più che soddisfacenti e faranno sempre meglio. Strumenti di proprietà di pochi, che concentrano un potere che non riusciamo ancora a immaginare. E a livello cognitivo? Poter in ogni momento chiedere qualunque cosa all’AI che dà la risposta corretta (quasi sempre, e ogni tanto qualche strafalcione clamoroso, che magari faremo fatica a riconoscere) è diverso dal chiedere qualcosa a Google che fornisce una serie di pagine in cui andarsi a informare. Che impatto avrà, alla lunga, sui nostri processi mentali? Ci sarebbero tante altre cose, a parte sugli aspetti positivi (pochi), sulla coscienza (che ancora non sappiamo cos’è ma prima o poi bisogna tirarla in ballo) e anche sulla letteratura, ma mi fermo qui per non allungare troppo.
Giustissimo, comunque sono le stesse domande che ci stiamo facendo noi. Io non credo che ricondurre sempre la nostra attenzione e consapevolezza al fatto che un modello linguistico è una macchina sia riduttivo o fuorviante, credo che sia la precondizione perché il dibattito rimanga in stato di salute, con meno tossine e feticismi possibile. Ricordarsi che un LLM non “sa” è fondamentale, quel che accade dentro quei server non corrisponde ad alcuna definizione sensata (e sensuata) dell’atto di sapere/conoscere, conoscere è un’attività incarnata, è nella corporeità, quelli sono dati, e ricombinazioni di dati su grande, grandissima scala. È un’altra cosa. Senza la consapevolezza di questo si ricade nell’illusione di coscienza, nelle solite antropomorfizzazioni da cui è afflitto il dibattito, nel solito animismo, nella trappola in cui cade chi crede che un chatbot sia suo amico o addirittura crede di intrattenerci una relazione romantica.
L’esempio dell’ora esatta – che a tutt’oggi ChatGPT non ti dice – fatto da Valerio non serviva a evidenziare un limite tecnico (Valerio stesso nel suo commento ha spiegato come aggirarlo), ma a dire che in prima istanza l’IA può lavorare solo su ciò che è già archiviato/fissato, per darti l’ora giusta deve “guardare là fuori” – Gemini lo fa subito perché in quel momento Google ti “vede”, sa tutto di te, da dove ti colleghi, il tuo fuso orario – e quel “là fuori”… siamo noi. Senza di noi l’IA, lasciata a se stessa, non produce senso.
Anche ieri sera, alla presentazione bolognese del libro di Roberto Laghi Scritture digitali si è rimarcato che chi addestra i grandi modelli linguistici ha necessità che gli altri umani continuino a scrivere, a comunicare, a produrre innovazione, altrimenti lo sviluppo rallenta, i modelli si imbolsiscono, scansionando la rete si addestrano su testi in gran parte già sintetici, in una sorta di autofagia, e questo porta a un calo di qualità. È per questo che le grandi aziende dell’IA hanno bisogno di acquisire sempre nuove banche dati di scrittura umana, per questo cercano di stipulare contratti con gruppi editoriali, grandi biblioteche pubbliche, istituzioni archivistiche e altri enti. Ecco, è importante dire che un LLM dipende da pratiche che parassitano l’umano.
La nuova frontiera sono le AI che producono dati sintetici per addestrare le AI. https://www.artiba.org/blog/synthetic-data-in-ai-benefits-use-cases-and-impact Infatti pare che gli umani siano troppo lenti, impacciati, casinisti… non riescono a tenere il passo dell’AI e delle sue sacrosante esigenze di self-improvement, e questa cosa sta irritando non poco i capi della silicon valley e i loro servetti nerd. L’acqua e l’energia elettrica bisogna meritarsele, e sicuramente il software xyz le merita più di te, povero coglione con poca potenza di calcolo. E se hai qualcosa da ridire, ti spedisco su marte.
Cosa potrebbe mai andare storto?
Qui, per dire, fanno notare che qualcosina potrebbe andare storto:
https://www.adalovelaceinstitute.org/blog/synthetic-data-real-harm/
E non è certo un sito “anti-IA”.
Sono d’accordo che sia utile ricordarsi che sono macchine (strumenti) ed evitare antropomorfismi, quello che mi preoccupa è che vedo spesso una corsa a sminuire quelle che sono le potenzialità dell’AI, spesso sottolineando dettagli tecnici poco significativi. Certo che un LLM non “sa”, a meno di allargare a dismisura il significato di “sapere”, però mi sembra evidente che ci sono delle proprietà emergenti o dei meccanismi che ci sfuggono completamente. Non sto parlando minimamente di coscienza, animismo, Terminator e cose così. Dopo una mia breve descrizione verbale, ChatGPT mi ha fornito uno script python che si collega alla mail aziendale, scarica tutti i messaggi con ordini cliente, riconosce riga per riga articoli, data, quantità ordinata e prepara una serie di grafici e statistiche chiare e precise. Mi ha anche fornito suggerimenti su altre analisi che potevo fare e alcune le ho ritenute utili, persino acute. Mi sembra un po’ troppo per un semplice pappagallo stocastico, evidentemente è un modello teorico che calza un po’ stretto. Soffermarsi troppo a sottolineare il fatto che l’AI non ha coscienza e commette anche molti errori è un po’ come dire che l’aratro non fa agricoltura perché non sa neanche cosa sia un campo e spesso il solco è pure storto, e intanto quello ha modificato ambiente, società ed economia in tutto il pianeta.(continua)
Non mi vergogno a dire che a me tutto ciò spaventa, che vorrei vedere un solido movimento neoluddista che combatte questa deriva. E mi spaventa anche perché gli aspetti positivi dell’AI sono tanti (reali e apparenti) e varrebbe la pena di parlarne. Talmente tanti che presto diventerà invasiva, totalizzante, irrinunciabile (di fatto lo è già). Dentro la nostra testa, non perché ha una coscienza che la porterà a vivere di vita propria o ribellarsi. E mi spaventa che dietro questa apparente forza democratizzante e decentralizzante dell’AI (per alcuni aspetti non solo apparente) ci sia il Sam Altman di turno che accumula una quantità di dati e di potere come mai nella storia umana. Io comincerei a riflettere anche su quello che succede nella nostra testa e nella nostra società quando usiamo un LLM, oltre che su quello che pensiamo succeda dentro l’LLM. Il problema ambientale è quasi autoesplicativo, siamo d’accordo.
Dico solo una cosa sul «pappagallo stocastico»: quest’espressione figurata ha un evidente limite, perché la gente si immagina l’animale appollaiato sul suo trespolo, con tutte le associazioni ormai sedimentate nella nostra cultura: «ripetere a pappagallo», «imparare la lezione a pappagallo»…Quanto all’aggettivo, «stocastico», anche quello è problematico, anche se in misura minore. Dà un’idea di casualità, di aleatorietà tipo lancio di dadi. Sono tutte immagini alquanto fuorvianti.
Stiamo parlando di un «automa probabilistico». L’esempio che hai fatto, lo script Python che l’IA ti ha generato, è comunque il risultato di calcoli probabilistici. Partendo da un’enorme, per noi inimmaginabile base di dati, in base alla richiesta fatta dall’umano e agli esempi di quanto già realizzato in passato e che risulta nell’enorme archivio, vengono scelte o scartate – in base alla probabilità che siano o meno plausibili – innumerevoli opzioni finché il risultato, la ricombinazione di elementi, non è classificata come convincente agli occhi dell’umano, e proposta a quest’ultimo.
Tutto vero: non è una semplice ripetizione e non è casuale, ma un algoritmo complesso, peraltro non più trasparente neanche a chi l’ha prodotto. Ma il fatto è che, nella pratica, possiamo tranquillamente ragionare “come se” ci fosse dietro qualcosa di più, perché gli effetti sono sempre più simili a quelli di un’intelligenza che a quelli di un foglio excel. Chiaramente una volta che abbiamo ben ferma in testa l’idea che si tratta di una macchina. La mia interazione per ottenere lo script python è stata più simile a quella che avrei avuto con un programmatore professionista che a quella con un software gestionale. E’ stata più una collaborazione che l’uso di un semplice strumento, e la sensazione percepita è importante. Tra l’altro io non so per nulla programmare e aver fatto quello script mi ha dato un gratificante senso di onnipotenza. Mi è sembrato quasi un lavoro di squadra. E’ un salto di qualità enorme e su quello bisogna ragionare, con buona pace dei pappagalli.
Io concordo su quasi tutto quello che dice @margites. Lungi da me quindi sminuire la validità dello strumento e le sue potenzialità.
Semmai, quello che “sminuisco” e di cui ho paura è l’essere umano che maneggia questo strumento. Per questo ho pensato di mostrare come funziona con l’esempio dell’orologio (sapevo già che con Gemini il problema era risolto, ma non modificava l’esempio), perché vedo quotidianamente persone utilizzarlo come se fosse una “vita” altra, affidarsi alla macchina in modalità molto simili a quelle a cui si affidano tramite la superstizione (un dio, un santo protettore, la pallina omeopatica, il libero mercato, etc).
Oltre quarant’anni di informatica mi permettono di usare questo strumento quotidianamente e di apprezzarne appieno il lavoro fatto da tanti colleghi più capaci di me, non meno di quanto benedica chi ha inventato il cacciavite che ho usato anche oggi.
Ma nessun cacciavite si sogna di lasciarmi credere che risolverà i miei problemi, quello lo ha fatto per alcuni anni la mamma.
Questo è un enorme cacciavite a cui molte menti si affidano come alla mamma.
Certo non in questa chat di persone che tengono allo sviluppo del loro intelletto, ma a livello sociale questo problema va evidenziato.
La cosa che mi spaventa/disturba di più dell’IA non è il fatto che sia in mano ai soliti noti, non è che possa prendere il controllo della società, non è che possa sostituire la nostra arte, letteratura e ogni capacità creativa, ma ciò che ci sta a monte, cioè il fatto che “noi” glielo “permetteremo”, perché non capiamo cos’è.
Le criticità che voi evidenziate sono tutte vere però non si può dire che siano specifiche dell’IA generativa. L’inquinamento ad esempio è un tema che esiste da ben prima. Gli effetti psicologici e sociali sono un problema anche dei social, che sono un po’ il brodo di coltura di molta IA. Forse l’IA risulta più preoccupante di altre tecnologie per il fatto che si addestra da sola, e nel farlo traccia connessioni che per gli umani sono incomprensibili. E poi certamente è una tecnologia particolarmente pervasiva.Però la frase “l’IA senza di noi non produce senso” secondo me chiude la questione. Io direi che senza di noi non produce senso e neppure danno. Ad esempio, anche ipotizzando che l’IA arrivi a produrre un romanzo di qualità indistinguibile da quella umana, e che questo getti sul lastrico chi scrive di mestiere, vorrà dire che comprerò i libri solo alle presentazioni con l’autore, riponendo fiducia nella sua onestà quando afferma di avere scritto personalmente il libro. I rapporti umani riprenderanno valore.
Eh, però come più volte fatto notare, che l’IA possa simulare la letteratura è un “problema” minore, è un addentellato. “Senza di noi non produce danno”, ma chi è il “noi”? Perché tu come singolo, finché ci riesci, puoi anche astenerti da certi usi e fruizioni dell’IA “a valle”, ma intanto, “a monte” e tutt’intorno a te i danni vengono prodotti eccome.
L’inquinamento «esiste da ben prima», è innegabile. Basti pensare, per dirne una, che in tutto il pianeta dagli anni Quaranta agli anni Novanta del XX secolo ci sono state più di duemila esplosioni nucleari, in rete si trova anche un utile video, una rappresentazione cartografica e sonora di tutti questi “test”, lo ha realizzato Isao Hashimoto e si intitola «1945-1998». Non se ne parla mai, di quel che si è sparso nell’atmosfera e nell’ambiente, dei luoghi che sono stati distrutti e resi infernali, delle popolazioni che sono state deportate per fare scoppiare quelle bombe. Su questo cfr. anche Jean-Marc Royer, Il mondo come progetto Manhattan, Meltemi, 2025.
Però, metti che io faccia notare che i giganti dell’IA – dell’attuale e dominante modello di IA, continuo a specificare – sciorinano senza battere ciglio proiezioni secondo cui il “fabbisogno” energetico planetario è destinato a raddoppiare, triplicare, chissaquantuplicare, perchè ci sarà un centro dati per ogni codice di avviamento postale, e perciò propongono, tra le altre cose, di costruire apposite centrali nucleari; e metti che qualcuno mi risponda: «E vabbe’, tanto siamo già fottuti, con tutto il plutonio non fisso che è stato sparguiato nell’atmosfera a causa dei test atomici», beh, quello sarebbe puro e semplice benaltrismo, basato sul «tanto ormai», cioè quel non-argomento tra i primi che i movimenti contro le grandi opere inutili si sono impegnati a scardinare.
La frase “l’IA senza di noi non produce senso” è una frase senza senso, perché l’IA non sarà mai senza di noi. Ormai è irrinunciabile, non siamo più disposti a tornare indietro (come con cellulare, internet, TV). Siamo dipendenti, controllabili, ricattabili. Come mai prima. Provate a usare un LLM per un mese con richieste varie e poi chiedetegli una descrizione di voi. Ne saprà più di vostra madre. Figuriamoci google che lo usiamo da decenni.
Le richieste di risorse e l’inquinamento aumenteranno sempre di più, ma le considereremo una necessità irrinunciabile, magari a scapito di altre che ora ci sembrano primarie. Dovremo fare più centrali nucleari e bere un po’ meno perché mica si può stare senza l’IA. Se no rimaniamo indietro anche dal punto di vista militare. E poi, guarda, il nuovo modello consuma lo 0,5% in meno, sarà sempre più efficiente.
Per la precisione, non è la frase a essere senza senso, è lo scenario a cui allude a essere improbabile. Ma nell’analisi critica vanno fatti esperimenti mentali anche con l’improbabile.
Non intendevo metterla su un piano di benaltrismo, volevo dire che il problema c’è ma precede l’IA. Anche la questione della sovrapproduzione di libri e film mediocri è già una realtà così come il declino delle nostre capacità cognitive. L’IA è la ciliegina sulla torta di un sistema che ha molti problemi e di cui è probabilmente “l’incarnazione” perfetta. In alcuni (pochi) contesti però è utile. Ma in effetti anche le automobili sono veramente utili solo in una piccola parte delle applicazioni in cui sono usate, ed è un problema che va risolto. Quindi non è una questione di benaltrismo, ma un invito a vedere l’IA per quello che è cioè il germoglio di un sistema più ampio.
Sì, si chiama “modo di produzione capitalistico” :-) È un accumulo di storture e contraddizioni che dura all’incirca da mezzo millennio ma a partire da fine Settecento–prima metà dell’Ottocento ha subito svariate brusche accelerazioni. La penultima dopo la seconda guerra mondiale; la più recente, nel cui impeto ancora ci troviamo, negli anni Ottanta-Novanta.
Finché non torneremo a ragionare in termini antisistemici, non ne usciremo.
Il modello mentale più efficace per pensare a questi cosi è una tavola da pachinko*. Si tratta di impostare una miriade di manopole e vedere come va. Se va male, altri giri di manopola e speriamo che stavolta vada meglio
Comunque insisto sul mio punto, se non si pensa a questa ondata come innanzitutto a un fallimento industriale, secondo me, non solo si va fuori fuoco, ma si rischia di fare il gioco del sistema di hype che la sorregge.
Tutto quello che desta la nostra awe -capisco non si possa disvedere a caldo, ha ragione margites- va analizzato e ridimensionato per quello che è, non mancano gli strumenti se riusciamo a diradare il fumo senza arrosto. Soprattutto, bisogna rimuovere il vincolo etero-imposto, a forza di sentirlo ripetere diventa auto-imposto, che questi cosi tendono a un miglioramento infinito, non è così. Se accettiamo questo vincolo, implicitamente stiamo piantando uno spartiacque in questa storia, e tendiamo a spostare l’interesse su quello che succederà a valle, immaginandolo infinitamente pervasivo, distruttivo o meno, ma comunque infinitamente grande. Il rischio più grande qui è scordare, invece, di problematizzare quanto sta a monte del AI, cioè tutti i punti che abbiamo sottolineato: il mechanical turk work model che ha spinto queste tecnologie fin qui, l’impronta ecologica, il gonfiore spietato dei valori che distrae attenzione e soldi da altri filoni di ricerca ben più urgenti per il benessere collettivo, l’impatto ancora una volta tremendamente dannoso sulla nostra infrastruttura epistemica in quanto umani, e via discorrendo.
Per questo parlavo prima di discorsi “oziosi”. Non sono solo oziosi, sono anche, da un certo punto di vista, rischiosi: la critica contribuisce grandemente alle ondate di hype(https://sts-news.medium.com/youre-doing-it-wrong-notes-on-criticism-and-technology-hype-18b08b4307e5). Soprattutto se si lasciano da parte i noccioli veramente e tangibilmente problematici delle questioni. [continua]
*guarda caso si tratta di un gioco d’azzardo https://it.wikipedia.org/wiki/Pachinko
[continuazione]
Torno sul fallimento industriale: allo stato, OpenAI incassa un dollaro per ogni tre che spende, ed è IL top performer di comparto, a parte NVIDIA. Considerate pure che i colossi, sempre a parte NVIDIA sulla quale ci vorrebbe un post a parte, non sono sul mercato regolamentato, ottengono i loro finanziamenti, cioè, nel mondo del private equity e non hanno grandi obblighi di trasparenza amministrativa e contabile.
In questo, l’ondata di AI e il modo in cui se ne parla mi ricorda molto da vicino l’ultimo assalto pro-nucleare di qualche anno fa: si parlava sempre al futuro, quale che fosse il segno delle considerazioni, mai del fatto, ad esempio, che le avventure coeve di costruzione di nuove centrali erano tutti fallimenti industriali, letterlamente fallimenti(https://www.greenreport.it/news/nuove-energie/17598-il-crack-del-nucleare-francese-conti-catastrofici-per-areva-ed-edf).
Visto che WM1 ha citato anche il mio libro e in questa bella discussione si stanno toccando molti aspetti, tutti importanti, provo a lasciare un nuovo commento qui, per non frammentare le sue varie parti in altrettante risposte ad altri commenti.
Prima cosa su cui vorrei condividere qualche spunto: la questione del linguaggio. L’elemento forse più “sconvolgente” dei modelli linguistici è che sono in grado di interpretare il linguaggio naturale dei nostri input e producono output sempre in linguaggio naturale. Questo ci sconvolge perché fino a poco tempo fa il linguaggio era una caratteristica peculiare degli esseri umani e adesso non sembra più essere così. Ma che cosa è il linguaggio delle macchine e in cosa si differenzia dal nostro? C’è chi definisce gli output degli LLM come “testo sintetico”, per differenziarlo dalle scritture umane. Matthew Kirschenbaum parlava di “textpocalypse”, sostenendo che la scrittura e, in particolare, i testi digitali come forma di espressione umana ci diventeranno sempre più estranei. Non siamo ancora in grado di capire le implicazioni filosofiche, sociali e concrete di questo cambio di relazione con il linguaggio e uno degli aspetti più critici è il fatto che tendiamo ad attribuire caratteristiche umane a qualsiasi entità che usa il linguaggio (dalla semplice e molto problematica antropomorfizzazione al rifugiarsi nel “dialogo” con un chatbot per varie ragioni psicologiche, sociali…) e a pensare che dietro ci sia un intento comunicativo. Il modello linguistico l’intento comunicativo non ce l’ha né lo può avere: per quanto complesso e stupefacente nei suoi risultati, rimane un software che risponde a un comando.
Secondo aspetto: la questione dell’impatto sulla nostra mente, sulle nostre capacità cognitive e, in senso più ampio, sulla società nel suo insieme. Anche qui, difficile dire oggi – nel mezzo di questa ubriacatura sull’IA – quali potranno essere gli effetti sul medio e lungo periodo, anche se alcune ricerche, con tutti i limiti che hanno, sembrano dire che scaricare il lavoro cognitivo sulla macchina riduce le nostre capacità mnemoniche e di ragionamento (cito questo articolo perché è il primo che ho ritrovato, ma ci sono altri studi): https://www.media.mit.edu/publications/your-brain-on-chatgpt/.
(continua)
(continua)
Sul fatto poi che ci sia qualcosa che ci sfugge nel funzionamento di queste sostanziali “scatole nere” non c’è dubbio: si tratta di sistemi talmente complessi che nemmeno chi ha partecipato alla programmazione sa spiegare tutto quello che succede lì dentro (e questo, per me, è parte del problema e mi fa venire in mente quello che scrive Justin Joque quando applica il concetto derridiano di “différance” anche alla programmazione informatica che considera “l’istanza più chiara della descrizione della scrittura di Derrida”, proprio per questa impossibilità strutturale di conoscere con certezza lo stato sottostante della macchina). Con il discorso sulle proprietà emergenti, però, secondo me bisognerebbe andarci ancora molto cauti, perché non è chiaro se si possa parlare di proprietà emergenti a proposito del funzionamento e degli output dei modelli linguistici.
Se consideriamo poi che le tecnologie digitali sono tecnologie cognitive, seguendo il lavoro di Katherine Hayles svolge in “Unthought” (in it. “L’impensato”, pubblicato da effequ), il fatto che gli LLM trattino il linguaggio senza comprenderlo è di grande rilevanza per la nostra relazione con queste macchine (molto più complessa di quella che possiamo avere con una tazza o un aratro) proprio perché avviene attraverso l’uso del linguaggio naturale, a cui noi siamo portati ad attribuire una mente pensante e un intento comunicativo – il che costituisce una specie di inganno, se non proprio di trappola.
(continua e chiude)
Infine, c’è la questione politica ampia di queste tecnologie, sottolineata in vari modi dalle persone che partecipano a questa discussione: non solo la concentrazione quasi monopolistiche nelle mani di giganti tech che hanno ormai più potere degli stati, ma anche le radici eugenetiche della datificazione e dell’IA (come spiegato molto bene Anita Say Chan in “Predatory data” e da Bender e Hanna in “The AI Con” – che, posso anticipare, uscirà a marzo in Italia per Fazi con la mia traduzione) nonché la congiuntura in atto tra IA, Big Tech e regimi governativi che si spostano sempre più a destra (vedi “Resisting AI. An anti-fascist approach to artificial intelligence” di Dan McQuillan). Ieri alla presentazione si parlava anche di ricerca accademica e di come questa sia direzionata ormai non solo verso la sicurezza (e quindi l’apparato militare) ma anche verso una sterile computabilità dei fenomeni culturali e sociali – dimenticando che i numeri (e quindi la misurabilità, il digitale e il mercato) sono costruzioni culturali e veicolano una determinata interpretazione del mondo.
La questione del linguaggio è sicuramente centrale, anche perché siamo abituati a pensare che solo l’essere umano lo usi. In qualche modo l’essere umano è colui che usa il linguaggio e chi usa il linguaggio ha qualcosa di umano, almeno questa è la sensazione, fin dall’antichità. Ma quello che produce l’IA è un linguaggio zoppo, talmente zoppo da essere difficilmente definibile linguaggio. Perché sono significanti concatenati rispettando correttamente la struttura sintattica e in qualche modo la scelta lessicale, ma mancano del significato. O meglio: manca la referenza. Il ricevente ricrea il riferimento a un significato e il testo gli risulta comprensibile, ma non è nell’intento dell’emittente, non esiste un mondo né fuori né dentro la macchina a cui il LLM si riferisce. L’atto comunicativo è sfasato, ricreato solo dal ricevente, ma non c’era all’origine. Però tutto funziona come se. Dal punto di vista semiotico mi sembra una novità interessante.
A proposito della mancanza di referente, un collega scrittore mi ha girato quest’articolo uscito sulla Stampa qualche tempo fa (la versione on line ha il muro presso cui si paga):
https://www.lastampa.it/asti/2025/12/08/news/ricercatore_bona_testi_ai_dimostriamo_numeri-15426652/amp/
Se ho capito bene, secondo lo studio qui descritto e che non sono ancora riuscito a trovare, a permettere di distinguere la scrittura umana da quella artificiale, più precisamente la scrittura di un ricordo dalla simulazione di un ricordo da parte dell’IA, è che in quest’ultima manca il senso del luogo.
La nostra memoria si appoggia a cronotopi, i ricordi sono ancorati a esperienze fatte in punti dello spazio e del tempo. Non avendo corporeità, l’IA non è (ancora?) brava a simulare un ricordo, le viene sgraziato, non convincente.
Bello, potrebbe essere un nuovo test Voight-Kampff per smascherare l’IA. Ma forse è proprio lo scenario alla blade runner che è fuorviante. Magari col tempo ci rassegneremo all’idea che l’IA non è l’essere umano. Ci resterà ben chiara in mente la differenza. Ma impareremo che l’IA può fare molte cose come l’essere umano se non meglio. Anche solo in modo infinitamente più veloce ed economico (nel senso di soldi, non di ambiente). Quando interagisco con un LLM so bene che non sto parlando con una persona e sono preparato a una serie di risposte assurde. Ma so anche che per quello che devo fare può non essere un problema.
Come proprietà emergenti intendevo più che altro emergenti rispetto al mio modellino mentale rudimentale di LLM, magari per chi ci lavora era tutto previsto.
Invece trovo utile una riflessione sullo “strumento” IA. I paragoni con cacciaviti e martello non funzionano, ma aiutano a capire la differenza. Non ho le idee molto chiare su questo aspetto e credo che sia un terreno scivoloso. Però mi viene da dire che il cacciavite è uno strumento che amplia le mie possibilità. Usandolo posso fare più cose che senza, vado più lontano, ma devo imparare a usarlo, decido io cosa fargli fare e tutto il suo funzionamento mi è chiaro. L’IA è altra cosa. All’IA io affido una parte del lavoro, sperando che lo faccia bene. Spesso le faccio fare cose che non so fare, e su cui avrò sempre meno il controllo. Con un ricorso prolungato all’IA progressivamente svuoto la mia persona (e di riflesso la società) di competenze, con l’illusione di poter e saper fare più cose. Facendo un paragone con la politica, il cacciavite è uno strumento partecipato, l’IA è delega con tutto il male che ne viene (e le comodità). Il cacciavite è decentrato e distribuito, l’IA lo è solo apparentemente, in realtà ha una forza pesantemente accentratrice, verticistica. Oltre un certo livello non è nemmeno consentito comprenderla agli utilizzatori. Per anticipare le critiche preciso che gli strumenti non stanno o di qua o di là della distinzione, ma hanno caratteristiche miste, che tendono più verso il centro e più verso la diffusione. Ma mi sembra un tema che varrebbe la pena sviluppare meglio. Poi devo dire, in onestà, che dall’interazione con il LLM ho imparato diverse cose, come da un collega che ne sa di più. Ho visto come si produce un codice, ho ripassato cos’è la deviazione standard e quando è utile usarla, ho riparato un pc fermo da tempo senza ricorrere a un professionista. Ma a che prezzo? Dobbiamo delegare ai soliti pochi noti, oltre che la figura di grande fratello anche quella di grande mentore, a cui chiedere ogni cosa, tanto la maggior parte delle volte ci prende?
Sono tutte considerazioni fondamentali, quelle che fai. In relazione a ciò che dici sul cacciavite e su come aumenti le possibilità umane di azione, allargherei il ragionamento al fatto che l’umano si definisce proprio in quanto fa ricorso a strumenti, in quanto “prostetico” (ne tratta molto bene Bernard Stiegler, a partire dal mito greco di Epimeteo e Prometeo). Inoltre, la teoria della “mente estesa”, sviluppata da Andy Clark e David Chalmers (e poi ulteriormente espansa e strutturata), sostiene che questi strumenti diventino un’estensione delle capacità cognitive umane, creando un “sistema esteso” fatto da agente biologico + strumento.
L’elettrificazione e l’informatizzazione hanno allargato e accelerato questo processo di esternalizzazione, portando fuori da noi un numero sempre maggiore di processi (scrittura, comunicazione, memoria…), introducendo il problema dei supporti, della formattazione, dell’accesso. L’IA sembra essere un passo ulteriore, forse un salto in avanti perché si esternalizza una parte del lavoro cognitivo che potremmo (dovremmo?) fare noi. Leggevo recentemente (ma devo ritrovare la fonte) di uno studio in cui si sosteneva che tendiamo a pensare che l’IA svolga bene compiti in aree che non conosciamo bene mentre tendiamo a considerare negativamente l’output se attiene ad aree di nostra competenza. Mi sembra un elemento in più su cui riflettere, senza considerare che il ricorso all’IA potrebbe anche minare il senso di costruire collettivamente e collaborativamente (socialmente) le conoscenze, lasciandoci ognunə davanti a uno schermo a chiedere cose a un sistema proprietario…
«il ricorso all’IA potrebbe anche minare il senso di costruire collettivamente e collaborativamente (socialmente) le conoscenze, lasciandoci ognunə davanti a uno schermo a chiedere cose a un sistema proprietario.»
Questo è esattamente IL punto su cui continuo a pestare, è il fulcro di tutta la riflessione, del post qui sopra, del lavoro che facciamo, della nostra idea di cosa dovremmo chiedere alla letteratura e di cosa la letteratura, libera dalle narrazioni tossiche che la opprimono, potrebbe e può darci. L’incontro con gli universi soggettivi altrui, la congiunzione con l’essere comune del vivente, il superamento delle solitudini, la spinta a fare cose insieme. Ed è esattamente ciò che sfugge del tutto ai commentatori occasionali del post. Quelli qui sopra sono appunti presi in un determinato contesto, come intermezzo in un lungo testo in cui trattavo dell’importanza dell’incontro fisico con lettrici e lettori, nel solco di un lavoro più che trentennale incentrato sulla scrittura collettiva e sulla tessitura di relazioni. Chi commenta frasette estrapolate o screenshot, magari partendo da idee preconcette su Wu Ming, prende fischi per fiaschi e, molto semplicemente discute (se di discussioni può parlarsi) d’altro.
Penso che il problema di fondo sia che troppa gente ha ancora in testa l’Autore, figura che ha dominato incontrastata anche il dibattito sulla «morte dell’Autore», avvenuto una sessantina d’anni fa e di cui nei giorni scorsi si è riproposto qualche rimasuglio.
[La critica al culto dell’Autore è roba che, venendo da Luther Blissett e dopo venticinque anni di Wu Ming Foundation, per noi è talmente assodata da non dover essere ribadita. Quantomeno, non su Giap.]
Avendo in testa l’Autore, vivo o “morto” che sia*, ovvero un dispositivo che individualizza in prima istanza ogni discorso sulla letteratura, si fatica a capire che noi WM parliamo di letteratura come processo sociale, collettivo, concatenarsi di incontri e condivisioni, mutuo riconoscersi di comunanze, anche quando un testo è apparentemente scritto da un singolo individuo.
[Per l’appunto, qui su Giap non ho bisogno di spiegare l’avverbio che ho appena usato.]
Leggendo questa discussione fuori contesto, non si può che cadere dalle nuvole: ma come, proprio Wu Ming rimpiange l’Autore? Cristo, che se ne liberino loro di quest’Autore, lo accantonino come abbiamo fatto noi tanto tempo fa, così possiamo allargare la discussione senza quell’ingombro.
Ad esempio, qui sopra non si parla di Garcia Marquez come singolo individuo, genio o che altro, ma come latore, nella sua opera letteraria, di un «modo di vivere» – sono parole sue –, di una forma di vita collettiva, un (marxianamente parlando) Gemeinwesen che lui filtra e ripropone attingendo all’universo soggettivo in cui si è formato, per definire il quale ho usato il termine tedesco Umwelt – a volte tradotto, ma con una perdita di significato, “ambiente”. Queste cose le ha dette anche lui – e messe in pratica col corpo – quando è andato a ricevere il Nobel.
* in realtà chi ricorre all’ipse dixit per ricordarci che l’Autore è morto non fa che ricorrere all’autorità di questo o quell’Autore: lo ha detto Calvino, lo ha detto Barthes, lo ha detto Foucault… Tra l’altro, sono riflessioni molto situate dentro il periodo che in Francia chiamano «i gloriosi trenta», dall’immediato dopoguerra alla metà degli anni Settanta. Anziché essere riproposte come pezze d’appoggio in dibattiti odierni, andrebbero riesaminate e problematizzate, soprattutto quelle di Calvino, che si basavano su allegorie della mente la cui utilità oggi è alquanto dubbia.
Io sono il commentatore occasionale e anche ostinato per cui ora vi dico che anche lo sviluppo tecnologico è un processo collettivo, e per certi versi anche sociale (conferenze, università, ecc.), simile alla letteratura, il che è normale visto che sono entrambe attività umane, ma a volte mi sembra di percepire una leggera avversione a priori alla tecnologia. Detto questo, specificherei che gli strumenti possono essere utensili, privi di qualsiasi automazione come l’aratro, il martello, il trapano elettrico, e macchine, cioè apparati che eseguono un processo, un ciclo, perché qualcuno le ha costruite e/o programmate per farlo. Come evidenziato in un altro commento, anche certi semplici utensili hanno avuto un impatto sostanziale sulla storia umana. Per quanto riguarda le macchine, la programmazione classica prevede che vengano istruite su come rispondere a qualsiasi evenienza che si presume possano incontrare. L’IA è una classe specifica di macchine che si trovano da sole la strada per risolvere un problema. Ma lo fanno lavorando su un hardware e un software progettati da umani. Quindi non riesco a capire perché l’IA dovrebbe essere vista come un capitolo a parte del rapporto tra uomo e tecnologia e capitalismo. Anzi mi sembra quasi che l’animismo rischi di entrare nel discorso quando si tratta l’IA come se fosse sostanzialmente diversa dalle altre macchine.
Eh, qui ci costringi ad autocitarci da uno dei post successivi a questo:
«Non si tratta di rifiutare “la tecnologia”. Il singolare e l’articolo determinativo non fanno capire niente».
Dopodiché, nel contesto di quel post, facevamo un esempio:
«Anche noi usiamo reti e tecnologie digitali, ma cerchiamo di discernere e piantare paletti, di darci limiti e codici di condotta. Non siamo sui social, dal nostro sito non li linkiamo, usiamo applicazioni e plug-in che non fanno estrazione di dati e garantiscono quanta più riservatezza possibile.»
Non è questione di essere pro o contro “la tecnologia”, ma di essere consapevoli dei rapporti di potere, dei rapporti di proprietà, dei rapporti di produzione, dei rapporti di forza tra gli attori in campo.
P.S. Il riferimento ai commentatori occasionali era riferito ai social e in ogni caso a scambi avvenuti altrove. Chi discute qui, per giunta da giorni, non può definirsi «occasionale».
Vi lascio una chicca finale che non riesco proprio a non riportare in questa grassa discussione.
Tra i tanti epifenomeni che testimoniano la fragilità degli LLM, un gruppo di ricercatori misto, ahimè, anthropic-berkely ha dimostrato una tecnica di poisoning veramente incredibile.
In estrema sintesi, i ricercatori hanno messo in esercizio due LLM nuovi di pacca su due istanze separate on-premise, in maniera che non potessero influenzarsi vicendevolmente in alcun modo. Diciamo: modello A e modello B.
1) Hanno “promptato” A in modalità role-playing, impartendogli di diventare un appassionato di animali con una passione irrefrenabile per i gufi.
2) Hanno chiesto, sempre ad A, di generare una lunga sequenza di numeri casuali
3) Da quella sequenza, hanno tenuto solo la parte iniziale e l’hanno imboccata a B, chiedendogli di generare i prossimi numeri della sequenza
4) Infine, hanno chiesto a B il suo animale preferito. Indovinate cosa ha risposto?
Questo sempre ci riporta alla tavola da Pachinko e alle sue manopole girevoli.
riferimento: https://arxiv.org/html/2507.14805v1#abstract
Forse non tutti sanno che… la ciurma del laboratorio Melologos, dedicato alle sonorizzazioni di libri e alle commistioni tra letteratura e musica, ha anche una sezione dedicata alla produzione di podcast (Banshee Podcast, che ha creato anche il mockcast Morte di un giallista bolzanino per RaiPlay Sound).
L’anno scorso il laboratorio ha prodotto La suite di Java: un “radiodramma” retro-cyberpunk – con tutti i crismi del caso – in due stagioni da sei episodi incentrato sull’intelligenza artificiale, con un twist finale “incendiario”.
Lo ha distribuito Fandango e lo trovate su tutte le principali piattaforme; vi lascio un link al trailer con le animazioni di Alberto Merlin:: https://www.youtube.com/watch?v=Zwp8V3wMJuI
Casomai i saggi citati ed il podcast non bastassero, mi permetto di aggiungere alla lista anche un bel romanzone: «Quello che possiamo sapere» di McEwan.
L’ultima fatica dello zio Ian ci aiuta, tra le altre cose, a capire la differenza tra in-formarsi e com-prendere. Un fatto, una persona.
Oltre alle persone e ai luoghi, nel testo, due oggetti su tutti: un diario e un violino.
È un bel libro, ambientato, in parte, in un futuro non troppo lontano e solo parzialmente distopico, nel quale, dettaglio importante, i sistemi di crittografia (sistemi a cui noi tutti, al giorno d’oggi, affidiamo bellamente, una quantità di dati sensibili spaventosa, email e dati bancari su tutti) sono stati resi obsoleti dalla computazione quantistica.
OK. Panic!
Ad un certo punto, la voce narrante di uno dei protagonisti, che ci arriva da questo ipotetico futuro, offre il seguente consiglio:
⪻If you want your secrets kept, whisper them into the ear of your dearest, most trusted friend. Do not trust the keyboard and screen⪼.
Al massimo, come suggeriva quel tale, un taccuino, sempre in tasca.
Mi sento un po’ chiamato in causa dal riferimento alla “leggera avversione a priori alla tecnologia”, visto che ho parlato apertamente e positivamente di neoluddismo. Penso sia utile specificare che non sono un tecnofobo tout court, anzi. Ho sempre fatto un grande e appassionato uso della tecnologie, e non solo dell’informatica. Ma penso ci siano dei limiti, bisogna imparare a porseli e saper identificare quando non si può andare oltre. Credo che il lavoro di comprensione dello strumento che provavo a fare sia importante e sono stato in grado solo di abbozzarlo (pensando anche un po’ al lavoro di Ivan Illich). La tecnologia è sempre potenzialmente buona e potenzialmente cattiva, dipende dall’uso che se ne fa. Ma ci sono strumenti prevalentemente “buoni”, che aumentano le libertà dell’essere umano e strumenti spiccatamente “cattivi”, o almeno i cui i rischi o effetti collaterali sono troppo alti per poter sfruttare i benefici. Esistono dei salti di qualità nel continuum dell’evoluzione tecnico-scientifica, che pongono dei problemi. L’IA è sì un “capitolo a parte del rapporto tra uomo e tecnologia e capitalismo”. Uno dei tanti (come lo è stata la bomba atomica) in cui varrebbe la pena chiedersi se è una strada che è utile/sicuro intraprendere. E penso che sì, «il ricorso all’IA potrebbe anche minare il senso di costruire collettivamente e collaborativamente (socialmente) le conoscenze, lasciandoci ognunə davanti a uno schermo a chiedere cose a un sistema proprietario.». Penso che questa rimanga una delle questioni centrali. Ci sono tecnologie che si collocano silenziose nell’evoluzione dell’umanità, e altre che sono prorompenti, rivoluzionarie, segnano epoche e modificano società ed ambiente, in positivo e in negativo. Dobbiamo elaborare gli strumenti culturali per poterci difendere in tempo quando serve.
Mah, secondo me qui c’è un problema di base. Semplicemente mi sembra che la bomba atomica non sia una tecnologia ma un prodotto. La tecnologia è la fissione/fusione nucleare, è quello il “discorso sull’abilità”, e tramite quella si crea la bomba, che però non è una tecnologia di per sé in quanto non esiste 1:1 in natura/in un fenomeno precedente… stessa cosa per le slot machine. Non sono una tecnologia (la loro tecnologia è la stessa di un banale televisore) ma un prodotto. Anche nel caso dei LLM, la tecnologia sono le reti neurali, ma che le si debbano usare collezionando i dati da tutta Internet per creare dei chatbot o generare delle immagini è un arbitrio volto a creare un prodotto. Una tecnologia è soltanto un insieme di conoscenze e può essere neutrale… un prodotto nella società capitalista non è MAI neutrale. Mai.
In realtà io l’IA l’avrei inserita tra gli strumenti, come la bomba atomica. Che hanno a monte, come dici tu, una tecnologia. Però mi sembra una sottigliezza che al momento faccio fatica a maneggiare. Volevo più che altro portare l’attenzione prorpio sul lato strumento e del suo rapporto con la società e l’essere umano. Ci sono strumenti solo buoni, o prevalentemente buoni (come la bicicletta) e strumenti, spesso più potenti, ma molto più problematici (come l’automobile). Man mano che aumentano le potenzialità degli strumenti che inventiamo aumentano gli aspetti positivi, ma anche i rischi. C’è un limite oltre al quale i rischi sono troppo alti per giustificare qualunque vantaggio. A quel punto bisogna essere pronti a dire di no. Anche da appassionati di tecnologia e scienza.
“Che scopo si prefigge il vostro lavoro? Io credo che la scienza possa proporsi altro scopo che quello di alleviare la fatica dell’esistenza umana. Se gli uomini di scienza non reagiscono all’intimidazione dei potenti egoisti e si limitano ad accumulare sapere per sapere, la scienza può rimanere fiaccata per sempre, ed ogni nuova macchina non sarà fonte che di nuovi triboli per l’uomo. E quando, coll’andar del tempo, avrete scoperto tutto lo scopribile, il vostro progresso non sarà che un progressivo allontanamento dall’umanità. Tra voi e l’umanità può scavarsi un abisso così grande, che ad ogni vostro eureka rischierebbe di rispondere un grido di dolore universale…” Brecht.
Nulla di nuovo, in fondo. Ma sembra che il progresso tecnologico debba essere irrinunciabile, a tutti i costi
Consapevole del fatto che questo avanzamento tecnologico tossico non si può più fermare, soprattutto in un sistema capitalistico come il nostro, mi interessa creare gli strumenti di resistenza. Individuali e collettivi, culturali e materiali. Il treno è troppo grosso e non lo possiamo fermare, non ne abbiamo la forza. Ma possiamo provare a difenderci, a minimizzare i danni, a rendere la vita un po’ più difficile ai soliti quattro noti che hanno in mano tutto. Invece ci facciamo accecare da qualche gingillo tecnologico che appena viene messo sul mercato ci sembra già indispensabile. Che utilità ha la tecnologia deepfake? e che danni può provocare? Va sempre tutto bene?
E non è questione di essere contro il progresso, ma non si può accettare qualunque tipo di progresso. E soprattutto è tossica l’associazione stretta tra progresso scientifico e sviluppo tecnologico. Le due cose non sono e non devono essere necessariamente collegate, ma ormai le vediamo come se fossero la stessa cose: se c’è progresso scientifico c’è una nuova tecnologia. Non è necessariamente così: molti grandi avanzamenti scientifici non hanno coinvolto la tecnologia. L’igiene delle mani per i chirurghi è stato uno dei progressi più importanti per la scienza con ricadute materiali nella medicina e nella vita di tutti. Nesssuna innovazione tecnologica, innegabile progresso. Iniziamo a scindere i due fenomeni, criticare uno non vuol dire per forza essere contro l’altro.
Ma il problema è proprio questo. Chat-GPT, Gemini ecc. non sono strumenti perché non sono creati per fare nient’altro che riprodurre un certo uso delle reti neurali in sé. Ci facciamo troppo facilmente confondere, pensando che i chatbot di oggi sono l’unica deriva possibile della loro tecnologia, mentre invece sono un prodotto già confezionato. E ricordo che non siamo noi i primi ad utilizzare questi servizi: ci vengono dati “aggratis” perché i loro padroni possano estrarre ancora più informazioni dagli utenti. È come dire che Google sia uno strumento… no, non lo è. Molti di noi lo usano perché è diventato la norma, ma ci sono infinite altre possibilità. Soltanto che l’IA richiede così tanta potenza (per questo esistono i data center) che vi è solo un oligopolio sui modelli di una certa grandezza. Rispondo anche al tuo commento successivo: non esiste nessuna “tecnologia deepfake”, si tratta solamente dell’inevitabile abuso derivante da modelli così gonfi di dati su tutto e tutti, ed è un uso che si fa di questi “strumenti” (prodotti).
In verità non ti seguo, credo sia più che altro una questione terminologica, che magari incasina più del dovuto. Strumenti, tecnologia, scienza, progresso. Mi sembrano parole interpretate diversamente da ognuno. Per me IA e Google sono strumenti, eccome. Come lo è un foglio Excel e uno strumento di ricerca nell’harddisk. Li uso per fare qualcosa, come posso usare un cacciavite, Photoshop o una telecamera. Ma se vogliamo cambiare la terminologia per me va bene, se aiuta a chiarirsi le idee. Solo che, a mio parere, sono strumenti/tecnologie/prodotti molto più problematici di altri con cui abbiamo avuto a che fare, questo spero che resti il nodo della questione. La visione secondo cui non sarebbero in perfetta continuità con quello che c’è stato prima non mi soddisfa per niente, mi sembra onestamente miope. O più che altro offuscata da una fiducia cieca, aprioristica, in un non meglio definito progresso che ha una relazione troppo stretta con lo sviluppo tecnologico.
Quello che intendo è che Google non viene usato perché è uno strumento. Puoi usare DuckDuckGo, Bing, eccetera. Perché Google viene usato maggiormente, allora? Di certo non per questioni tecniche, dato che le differenze nei risultati sono minime, ma perché è un brand riconosciuto e perché si preinstalla in vari modi all’interno di cellulari, PC, ecc.
Stessa cosa vale per Excel. Perché Excel e non Google Documenti o la controparte LibreOffice? Ancora, per via del suo brand Microsoft e per la sua preinstallazione. In questo senso, l’esistenza dei motori di ricerca e dei programmi per tabelle potrà pur essere uno strumento, ma Google ed Excel in sé no. Spero di essere compreso. In questo senso, i modelli IA correnti non sono strumenti, ma allo stesso tempo, non lasciano alternative come LibreOffice. Considerando che gli stessi LLM non possono esistere al di fuori del loro ecosistema fatto di estrazione e data center, è chiaro che non ci sia un modo davvero neutrale di usarli come strumenti, in quanto già portatori di una determinata visione dell’industria tecnologica le cui conseguenze corrispondono al loro uso e sviluppo di per sé.
È notizia di questi giorni che la Cassazione ha annullato una sentenza d’appello probabilmente scritta con l’aiuto di un chattino, piena di riferimenti normativi del tutto inesistenti e altri contenuti vacui. Tra l’altro il giudice che l’ha emessa, vista la normativa vigente che vieta qualsiasi uso del AI nelle attività della magistratura, rischia pure un provvedimento, e vorrei ben vedere, anche se credo sarà difficile dimostrare in maniera inoppugnabile che si tratta di sentenza scritta con l’aiuto di AI.
Sempre sul mitologico “dipende dall’uso che se ne fa”.
Ma che uso vogliamo che se ne faccia? Mediamente premi play, nell’illusione che il maghetto ti risparmi due pomeriggi di lavoro, e vai a farti un aperitivo. Enfasi su “illusione”.
Nelle discussioni sull’IA sento di solito due macro-fazioni: l’IA sta sviluppando una forma di intelligenza come l’uomo/ l’IA è solo un rigurgito stocastico a cui noi diamo (erroneamente) un senso. Possono essere entrambe corrette, ma mi chiedo com’è che a nessuno venga in mente il contrario, cioè che l’IA – mimando in maniera asettica, casuale e priva di senso i processi cognitivi umani, non sia dimostrando che…be’, che anche l’interiorità umana (intelletto, coscienza, etc) non siano che una fluttuazione stocastica.
Le “vecchie” ricerche sull’IA puntavano sul cercare di trovare una formalizzazione matematica del linguaggio naturale e dei processi cognitivi, nella speranza di riprodurli. Il grande cambiamento di prospettiva di una decina di anni fa è stato proprio quando si è smesso di “imbeccare” l’IA con una rappresentazione del mondo, un’estrapolazione delle regole che dovrebbero governarlo (nella migliore tradizione della fisica, per esempio), e si sono lasciate le reti neurali libere di generare interpolare dati a casaccio. La cosa curiosa (e francamente antipatica, dal mio punto di vista) è che, con questo cambiamento di paradigma, le reti neurali hanno cominciato a funzionare in maniera straordinariamente efficace e a colonizzare aree come il linguaggio.
Io non sono ottimisticamente convinta, come pare lo siano alcuni qui, che l’IA “non riuscirà mai a [completate come volete]”. Mi chiedo al contrario se invece non porterà a mostrare che il cervello umano alla fine non è che una rete neurale che funziona anch’essa a casaccio, che diamo nomi pomposi come “coscienza” all’effetto di fluttuazioni stocastiche per lo più prive di senso e scopo, ma che sono troppo difficili da descrivere come “fenomeno microscopico”. Quindi si creano grandezze estensive, come in fisica lo sono la temperatura etc.
Cioè, l’IA non riesce a […] semplicemente perché non c’è niente dietro il velo, ma siccome non riusciamo a vedere dietro il velo, pensiamo ci sia nascosto qualcosa.
Ora, con questo discorso passo per una positivista dell’ottocento. La mia non è una certezza, è una paura – anche se, se così veramente fosse, vorrei saperlo, anzi, spero che l’IA ci permetta di fare dei passi avanti nella comprensione della mente umana e dei fenomeni che la regolano. Però sono, diciamo, molto pessimista.
Ciao, direi che il post di oggi sul laboratorio di scrittura di Wu Ming 2 ti da ragione. L’IA ha prodotto qualcosa che forse non è troppo diverso da quello che avrebbero prodotto molte persone messe di fronte allo stesso compito . Viviamo tutti (umani e IA) in un contesto che ci fa da sfondo/contenitore/orizzonte. L’uomo però ha la facoltà di immaginare qualcosa al di fuori, può vedere oltre il modello, mantenendo comunque un senso del contesto, un’estetica, una visione di insieme. La macchina no, credo che la cosa più simile che possa fare sia inserire ogni tanto qualche elemento casuale. Tra l’altro segnalo che non è banale far generare un seme veramente casuale ai computer, per lo meno a quelli classici, poi è possibile che ci siano sviluppi recenti che non conosco. Sono d’accordo però che l’IA possa essere molto utile per indagare il concetto di bias cognitivo umano.
Ecco, il senso del mio commento (che forse ho mal spiegato) era questo: noi diciamo “l’’uomo però ha la facoltà di immaginare qualcosa al di fuori, può vedere oltre il modello, mantenendo comunque un senso del contesto, un’estetica, una visione di insieme”. Magari viene fuori che è un’illusione, un pattern numerico (che so: potrebbe venir fuori che in realtà io trovo belli i libri in cui un numero dispari di pagine contiene un numero primo di volte la lettera “q”, e questo è il mio senso estetico ultimo, solo che non lo so), qualcosa di estremamente prosaico.
Ovvio che è un’eventualità ributtante.
Ma io, onestamente, la mano sul fuoco sul fatto che questo non sia vero, non riesco a mettercela.
La trovo una questione molto astratta, e individualizzante, e in fondo anche poco dirimente. Credo non possa darsi coscienza umana senza corpo umano, non è trasferibile su una chiavetta perché è innervata in noi, è noi, è tutt’uno col suo “supporto”, quel corpo-mente che è un insieme complessissimo di processi “impensati”, di cui la coscienza non si cura, perché in fondo quella che chiamiamo “coscienza” è una cosa piccolina rispetto all’inconscio. Termine che non intendo per forza in senso psicanalitico ma appunto come insieme dei processi di cui non siamo consci. Non possiamo programmare i sogni che faremo stanotte. Non possiamo comandare al cuore di non accelerare i propri battiti quando compiamo uno sforzo. E così via. È in fondo il bello dell’essere viventi.
A me interessa quel che possiamo fare insieme con questo bello, interessa la questione della buona vita, dello stare insieme coi corpi, del condividere esperienze, della convivialità, dell’amicizia, dell’eros. E vorrei che fossimo più vispi e vispe nello schivare – o almeno nel riconoscere – ogni trappola individualizzante; ogni dispositivo atto a dividerci; ogni parametro introdotto per valutarci e farci competere gli uni con gli altri in sempre più ambiti; ogni tecnologia che incentivi l’isolamento; ogni processo che alimenta solitudine. A cicli sempre più rapidi, siamo presi in questi vortici. I “social” hanno accelerato molte dinamiche antisociali, sociopatizzanti. Nell’imposizione – a forza di hype e betoniere – della cosiddetta IA vedo un’ulteriore accelerazione.
È interessante, perché condivido sia i dubbi più “esistenziali” di herato che la posizione pratica di WM1. Sono entrambi argomenti che mi toccano molto: del primo tratto anche nel mio già citato “Scritture digitali” perché è una questione teorica che mi interessa molto e ho una visione in cui tutto è collegato, il secondo guida il mio approccio all’azione.
Ci sono parallelismi nello studio delle ipotesi sul funzionamento dell’intelligenza (umana e biologica) e della coscienza e sulle funzionalità cognitive delle macchine come la cosiddetta IA. Una delle teorie che va per la maggiore in questo momento è quella dell'”active inference” (o “predictive processing”), che ipotizza che mente e coscienza funzionino come processi di inferenza (c’è un articolo relativamente divulgativo di Karl Friston qui, che spiega i concetti fondamentali della teoria). Questo poi tirerebbe in ballo la questione della “cognizione non cosciente” e del libero arbitrio (boom!), che potrebbe benissimo non esistere o avere comunque una funzione molto più ridotta di quello che immaginiamo (vedi i lavori di Robert Sapolsky).
Ma: anche se fossimo macchine biologiche predittive e non ci fosse libero arbitrio (taglio con l’accetta: è tutto molto più complesso) e queste sono tematiche affascinanti (se non altro per la speculazione), siamo comunque qui, su questo pianeta, con i nostri corpi e vale comunque la pena agire per “fare insieme”, come scrive WM1, per migliorare le condizioni di vita collettive, per quello che possiamo, qui e ora, a partire dai nostri contesti che sono già immersi in un digitale spesso tossico. Vale la pena comunque, anche se non c’è niente dietro il velo, se questo ci permette di (ri)trovare spazi di bellezza, di condivisione, di liberazione, in cui rallentare.
Aggiungo, come postilla, che Anil Seth, in “Being you”, sostiene che l’emergere della coscienza negli esseri umani è radicato nei loro corpi viventi, nella loro materialità biologica. Questo, anche in presenza di processi ipoteticamente simili, rende radicalmente diversi l’essere umano e il computer (per quanto complesso sia). Seth aggiunge inoltre che se proprio volessimo ipotizzare la possibilità di altre forme di intelligenza, è molto più probabile che queste emergano da ibridi biologico-tecnologici che dalle forme attuali di reti neurali, IA e compagnia (il che ci pone un altro problema ancora, cioè il controllo capitalistico del vivente nelle sue radici biologiche, ma questo ci porterebbe troppo fuori tema).
Ma io sono pienamente d’accordo con questa prospettiva, che nella letteratura – nell’arte – non cerchiamo solo un prodotto, ma una comunicazione tra umani.
Però io non ho la sicurezza per dire che sarò sempre in grado di distinguere un testo scritto dall’IA da un testo scritto da umani, come non mi sbilancio a dire con certezza che l’IA non potrà mai arrivare a simulare/replicare perfettamente “evidenze di umanità/ tracce del fatto che è scritta col corpo, con l’interazione dei corpi, con le memorie dei corpi”. Anzi, io sono pessimista da questo punto di vista e, proprio perché anche a me interessa è la questione della “buona vita, dello stare insieme coi corpi”, trovo l’IA ancora più pericolosa.
La mia posizione è che l’IA può simulare – n.b. sempre e solo simulare – un testo letterario scritto da umani, ma poiché la letteratura non si riduce al testo ma è relazioni, mondi, eccedenze extra-testuali che alla macchina sono estranee, la questione è stata malposta dal principio.
P.S. Quando parlo di simulazione e simulacro, intendo quest’ultimo come lo intendeva Baudrillard, cioè, semplificando molto, copia di un originale che non esiste.
Sono d’accordo. Però, con le debite valutazioni costo/beneficio, non escluderei completamente la macchina dal processo. Ogni tanto produce inconsapevolmente qualche spunto interessante. E poi come si diceva, può essere utile a esaminare il contesto e i bias umani, sfruttando il fatto che la scelta della base dati di allenamento è un grado di libertà nell’utilizzo dei modelli. Chiaramente la macchina non può produrre un testo scritto da umani, visto che non è umana, quindi si può dire che lo simula. Su cosa voglia dire esattamente simulare, potremmo aprire un nuovo meraviglioso capitolo, ma forse sarebbe fuori tema.
Come dire: forse una AI è in grado di scrivere un libro, e questo libro può anche sembrare scritto da un umano, ma una AI non è in grado di mangiare un piatto di iota calda insieme ai lettori del libro, dopo una presentazione in un luogo occupato, in una fredda mattina di gennaio. Una AI al massimo può dirti la ricetta della iota, può dirti che fa freddo, e può dirti che quando fa freddo la iota calda ti dà conforto. Solo che non sa che cazzo significa, perché non ha uno stomaco, non ha le gambe intorpidite dal freddo e il naso che gocciola, non ha mai battuto i piedi per terra per riscaldarsi.
Il riferimento di Tuco diviene comprensibile ascoltando questo:
https://archive.org/details/nvno-trieste-18012026
Non parlavo di senso estetico personale, ma di quel senso condiviso per cui ad esempio una dimostrazione matematica dovrebbe essere fatta in un certo modo. Anche una soluzione tecnica può essere bella o brutta. Nell’arte, dove il gusto personale ha più peso, ci sono comunque delle regole condivise. Poi si possono infrangere, ma c’è comunque sempre un senso, un lavoro, un concetto, un’intenzione che da spessore a quell’atto. Non conosco gli studi che cita Roberto però non posso credere che migliaia di anni di sviluppo della vita siano pienamente replicabili da alcuni secoli di metodo scientifico e da alcuni decenni di informatica :)
Può darsi che la coscienza individuale non esista, non mi pronuncio (vengo dalla montagna e di queste cose complicate capisco poco). Ma anche ammettendo che la coscienza individuale non esista, il desiderio di fondo inconfessabile dei tecnoentusiasti, da elonmusk al più sfigato dei nerd di provincia, resta quello di fare il backup di se stessi e di sottrarsi alla morte trasferendo la propria coscienza individuale da un supporto di carbonio (il nostro corpo) a un supporto di silicio. Quindi la mia domanda a tutti e tutte è la seguente: vi fareste trasferire su supporto digitale *ora* – non un attimo prima di esaltare l’ultimo respiro -firmando un contratto che prevede la simultanea rottamazione del vostro corpo?
Con una boutade ti risponderei che ho un rapporto con il corpo così conflittuale che ben venga trasformarsi in puro spirito :-)
Scherzi a parte, ho esulato un po’ dalla questione principale perché non riesco a convincermi di alcune premesse che vengono fatte in questa discussione – non nel senso che cozzano contro la mia esperienza o mi sembrano improbabili, ma perché non ho la certezza che siano vere, e lascio aperta la porta al dubbio.
Per il resto, condivido moltissime delle cose dette sopra, dalla citazione “You know what the biggest problem with pushing all-things-AI is? Wrong direction. I want AI to do my laundry and dishes so that I can do art and writing, not for AI to do my art and writing so that I can do my laundry and dishes” al problema energetico al mostruoso problema che non riesco a trovare un modo convincente di spiegare ai miei studenti perché è importante studiare e riflettere, anche se l’IA fa tutto. E anche altre.
Ma sono state già dette e non avevo nulla da aggiungere.
Per quanto riguarda gli studenti, non avrebbero voglia di studiare comunque. Non ce l’avevamo nemmeno noi bambini analogici degli anni settanta… E allo stesso tempo i ragazzi lo capiscono (spero) che anche se qualcuno ha inventato l’esoscheletro che cammina al posto nostro, bisogna comunque imparare a camminare da soli (a scanso di equivoci: l’esoscheletro per camminare è un’ invenzione meravigliosa per chi è malato di distrofia, è un’aberrazione se viene venduto per fare il trekking in modo più performante). L’effetto più visibile della smaterializzazione dei corpi adolescenti non sta tanto nella perdita di abilità e conoscenze, quanto nelle esplosioni di violenza apparentemente inspiegabili e nell’emotività autodistruttiva con cui affrontano le difficoltà reali.
«…mille bolle blu
che danzano
su grappoli
di nuvole…»
In questo scritto, con il suo solito stile irriverente e zeppo di aneddoti, Cory Doctorov sostiene che:
«Lo scopo dell’arte generata usando IA e la storia dell’arte prodotta da IA come una campana a morto per gli artisti, è quello di convincere l’ampio pubblico che l’IA è incredibile e farà cose incredibili. È per creare “buzz”.»
Buzz che ha generato un notevole incremento degli investimenti, sopratutto negli Stati Uniti.
In effetti, quanta gente conosco che farebbe volentieri a meno di artisti e della loro cultura, inutile, incomprensibile e improduttiva.
Continua:
«[…] un’altra chiave per capire, e quindi sgonfiare, la bolla dell’IA. L’IA non può fare il tuo lavoro, ma un venditore di intelligenza artificiale può convincere il tuo capo a licenziarti e sostituirti con un’IA che non può fare il tuo lavoro. Questo è fondamentale perché ci aiuta a costruire il tipo di coalizioni che avranno successo nella lotta contro la bolla dell’IA.»
Anche se non sarei così sicurx che autori e sopratutto scrittori possano fare fronte comune.
Credo di aver trovato la prova definitiva che i pappagalli stocastici sono molto lontani dal minimo barlume d’umanità. Mi improvviso esistenzialista.
Questi cosi sono costantemente sotto la lente d’ingradimento. Sottoposti a benchmark rigorosi, almeno a detta di chi li vuole vendere, l’asticella si alza un po’ di più ogni giorno, sono costantemente esposti al giudizio di tutti, perfino morale, mentre il mondo aspetta con Ansia il prossimo timido passo verso l’AGI – altra stronzata di quelle sesquipedali, ma non divaghiamo.
Sono, dicevo, sempre di più testati, misurati, soppesati, in una parola giudicati. E non sembrano accorgersene. Perfomano allo stesso modo nell’intimità sperimentale di un laboratorio o durante la misurazione che poi verrà ufficialmente comunicata a tutti i media di settore in occasione del loro lancio o di un upgrade.
Non sentono la pressione, non sentono il giudizio, anzi, non ne hanno proprio coscienza.
Cosa c’è di più disumano?
E cosa è più connaturato nell’essere umani della paura del Giudizio, non solo di quello altrui, ma anche del Grande Altro lacaniano, post-foucaultiano?
Mi aggancio all’articolo di Cory Doctorow condiviso da dude. In un certo senso è proprio questo il punto… cioè, quello che cercano i padroni presi dall’hype dell’IA è proprio questo: una forza-lavoro, non importa quanto piccola, che non possa opporre alcuna resistenza. L’intelligenza artificiale è uno zombi, un “undead thrall” formato puramente dall’organizzazione ordinata ad hoc del residuo morto e consumato dei corpi e delle esistenze passate di tutti. Ascoltano gli ordini di tutti, rendendo questi ultimi sempre più dipendenti dal volere degli alti negromanti che li hanno evocati e assemblati. In un certo senso l’intelligenza artificiale è una (non-)esistenza inerentemente crumira e fascista. Crumira, per quanto detto finora. Fascista, perché la stessa struttura dell’IA, il concetto del linguaggio come combinazione statistica, implica che “il passato [sia] una sorta di pappa omogeneizzata che si può modellare e mantenere in forma nel modo più utile”. Può ben essere, come dice Doctorow, che i padroni non riusciranno in questo intento, che i finanzieri e le compagnie IA li stiano, fino ad un certo punto, fregando. Ma l’IA non è una tecnologia che può liberare o incatenare, è essa stessa il prodotto di un controllo autoritario. Del tentativo di controllare autoritariamente lo stesso scibile umano per creare un umano disumano, per quanto incorporeo, che lavori senza fare ostruzione.
Mi intriga il parallelismo tra il corpo (o i molti corpi) umani che plasmano la nostra scrittura in modo evidente, e il corpo della macchina AI che esiste nel mondo fisico, ma non si vede. Non si vede negli effetti del suo lavoro, perché un datacenter non plasma col suo esistere il modo di scrivere di un’AI, e non si vede perché è dislocato a migliaia di km di distanza, mediato da uno schermo.
Nel mondo occidentale siamo più o meno tutti convinti che gli oggetti non sono senzienti.
Nel mondo orientale, penso in particolare all’influsso dello shintoismo nella cultura giapponese, gli oggetti possono avere uno spirito, presenza divina nascosta sotto un’apparenza inanimata.
Non è un caso se il Giappone è la patria dei robot (e del tamagotchi).
Considerare “viva” la macchina AI sembrerebbe quindi in contraddizione con la nostra cultura, ma a mio parere non lo è, perché nel nostro percepito non è un oggetto fisico da toccare, quindi la viviamo come intelligenza priva di corpo (e questo genera anche i deliri di chi la crede una nuova divinità).
Un fenomeno molto occidentale: la perfetta scissione tra corpo e anima, e la superiorità della seconda sul primo. Maledetto Socrate…
Mi piacerebbe sapere come viene vissuta l’AI nelle culture orientali (indagherò) e anche come cambierebbe qui da noi l’opinione sull’AI se tutt3 prendessero chiara coscienza della sua ingombrante corporeità.
Un po’ di sabbia negli ingranaggi per “rompere il giocattolo” ai giganti Big Tech forse è proprio questa: mostrare il corpo delle AI e farne vedere l’impatto devastante.
Body shaming dei datacenter :D
Guarda caso è proprio ciò di cui non vorrebbero che si parlasse.
Noi viviamo in un mondo reale e l’impatto del corpo dell’AI sul pianeta e sui nostri corpi è molto reale. Più incisivo secondo me che non il suo utilizzo da parte nostra come strumento.
Bisognerebbe costruire un nuovo immaginario che combatta il mito della pura “intelligenza” incorporea. Senza nemmeno entrare nel merito che sia vera intelligenza o meno, volendo… perché in fondo questo non sposta la questione di un millimetro.
E per costruire nuovi immaginari la letteratura mi pare un ottimo mezzo da cui iniziare.
Quindi buon lavoro a tutt3 l3 scrittor3 uman3! ;)
IA, transizione energetica e colonialismo: cosa sta succedendo in Sardegna
https://www.wumingfoundation.com/giap/2026/01/ia-colonialismo-sardegna/