[Prosegue la pubblicazione a puntate settimanali del saggio di Wu Ming 2 che chiude il nostro libro New Italian Epic. Narrazioni sguardi obliqui, ritorni al futuro (Einaudi Stile Libero, 2009). Questa è la seconda puntata. La prima è qui.]
.
2. Una termodinamica della fantasia
Dunque, riassumiamo.
Il mondo è piccolo, ma denso come un frattale. Per non andare alla deriva, cerchiamo di essere persone informate dei fatti.
Ci ingozziamo di notizie, per ritrovarci con più domande di prima e le poche risposte, troppo fredde per confortare il cuore. Allora semplifichiamo tutto, per abbandonarci a una fede: una realtà di comodo, facile da maneggiare, che seppellisca il tumulto.
E non ci sarebbe forse nulla di male in questa volontà di credere, se non che la nostra fede potrebbe essere la realtà di comodo di qualcun altro, il risultato di un’ipnopedia. Una buona storia, raccontata bene, è sufficiente a nascondere la trappola. Ma una buona storia, raccontata bene, può anche essere l’antidoto che ci serve.
Primo, perché quando si tratta di narrazioni, il nostro cervello è più incline alla complessità. Così per comprendere non siamo forzati a comprimere. Molti dubbi sopravvivono e la fede si allontana.
Secondo, perché i fatti non ci toccano, se sono corpi inanimati. Ma le storie sono macchine per la trasfusione di sangue, dispositivi per attivare emozioni.
Terzo, perché i fatti non vanno a picco, se c’è un intreccio che li tiene ormeggiati.
Quarto, perché abbiamo bisogno di leggere il mondo con la profondità e lo spazio che riserviamo ai romanzi.
Tutto sta nel capire come possiamo riuscirci. Come possiamo scrivere romanzi di trasformazione che traducano i fatti in storie o, per meglio dire, che trasformino il racconto stereotipato dei fatti in un racconto significativo e facciano emergere un guado, tra finzione e realtà, tra comprensione e compressione.
Io me ne sono fatta un’idea leggendo i racconti di alcuni diciassettenni.
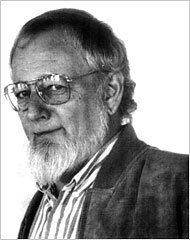 Qualche tempo fa un’amica professoressa mi ha invitato nel suo liceo per tenere una conferenza dal titolo: Cos’è la letteratura?
Qualche tempo fa un’amica professoressa mi ha invitato nel suo liceo per tenere una conferenza dal titolo: Cos’è la letteratura?
Spaventato dal compito, ero sul punto di rifiutare, poi mi sono detto che in fondo non dovevo essere per forza io a rispondere alla domanda, ma bastava forse che facessi riflettere gli studenti, per aiutarli a trovare la loro risposta.
Come prima mossa, ho chiesto alla mia amica di leggere nelle classi un racconto di Donald Barthelme, Il pallone, del 1981 [128]. In Italia l’autore non è molto noto, ma negli Stati Uniti è considerato uno dei più grandi scrittori di short stories, al pari di Hemingway e Carver. David Foster Wallace ha dichiarato in un’intervista che proprio la lettura di The Balloon gli fece capire che scrivere era tutto quello che voleva fare nella vita.
La storia è piuttosto semplice: il narratore gonfia un enorme pallone e lo fa piazzare nottetempo sopra i palazzi di Manhattan. La struttura occupa una cinquantina di isolati. Al risveglio, i cittadini la accolgono con reazioni diverse e si interrogano sulle sue possibili funzioni e benefici. Le autorità decidono di lasciarla dov’è, incapaci di sgonfiarla e convinte che dopotutto alla gente non dispiaccia. Passano ventun giorni, la compagna del narratore torna dalla Norvegia, vede il pallone e scopre che il protagonista lo ha gonfiato come «spontanea apertura autobiografica, connessa con il disagio e con l’astinenza sessuale». Così il pallone viene sgonfiato, ripiegato e riposto in un magazzino della West Virginia.
Come seconda mossa, ho chiesto alla mia amica di discutere in classe del racconto, senza esagerare con l’esegesi, giusto per arrivare a dire che Barthelme, in forma di parabola, ci offre il suo punto di vista sul senso e la funzione della letteratura.
Fatto questo, ogni studente ha ricevuto il file del racconto, con il compito di trasformarlo, riscriverlo, violentarlo a piacimento e poi di spedirmi il tutto.
I testi così prodotti, pensavo, potevano esprimere una critica creativa dell’originale, diversa dai commenti accademici che gli studenti imitano (o copiano) dalle antologie quando devono fare il tema di letteratura. Mi auguravo che alcuni concetti, difficili da esprimere in un linguaggio tecnico, potessero trovare la loro strada in una scrittura narrativa [129]. Come terza mossa, ho letto i racconti dei ragazzi e sono andato a scuola per discuterne con loro.
0. Romanzi di trasformazione.
L’esperimento che ho proposto agli studenti, rispetto a una riscrittura spontanea, si differenzia per il fatto che il racconto di partenza è già indicato, non lo si può scegliere. Di solito, quando qualcuno decide di modificare un testo in maniera creativa, lo fa sotto la spinta di due forze contrapposte: l’originale lo affascina, ma è deluso da alcuni elementi. Se un appassionato di Il Signore degli anelli scrive un racconto collaterale della saga, è perché l’universo narrativo di Tolkien, per quanto meraviglioso e dettagliato, non gli sembra completo. O magari non è del tutto coerente, o sacrifica troppo un personaggio, o non illumina abbastanza un cono d’ombra.
Quando si tratta di «raccontare i fatti», cioè di trasformare un racconto dei fatti in un nuovo racconto, la nostra scelta è guidata dagli stessi elementi: fascino & frustrazione. La realtà ci affascina e ci opprime perché ne siamo circondati, perché è in parte prevedibile – dunque possiamo controllarla, ma a volte ci annoia – e perché è in parte imprevedibile – dunque ci fa inciampare ma stimola la nostra curiosità. Il racconto della realtà, invece, ci affascina quando è complesso e ci frustra quando è complicato. Ci affascina con l’ordine degli elementi e ci frustra con la semplificazione.
Proviamo questi sentimenti al massimo grado quando ci imbattiamo in simulacri di storia, di cronaca o di memoria. Resoconti schematici e stereotipi, che finiscono per essere considerati più veri della realtà stessa, quando invece sono buoni al massimo per rievocazioni in costume. In questo sta il loro aspetto frustrante, ma il vuoto che impacchettano è anche motivo di grande fascino, perché sentiamo che è il luogo ideale dove affondare il coltello, per far esplodere le contraddizioni del senso comune e degli ideali conclamati. Quel vuoto è tale perché svuotato. È un nulla artificiale che allude a centinaia di tesori: il dopoguerra, Hitler, i Balcani, la Resistenza, la mafia…
1. Trasformazione espansiva: integrare il testo.
 In inglese si chiama nitpicking, fare le pulci, ed è l’operazione creativa più semplice e primordiale che si possa fare su un testo. Correggere gli errori. Oppure: lasciare gli errori dove stanno e correggerne le conseguenze. Uno degli studenti, ad esempio, ha modificato il sistema di ormeggio del pallone, perché il gioco di contrappesi inventato da Barthelme non gli pareva convincente. Ha introdotto funi e cavi d’acciaio, che poi hanno finito per ricavarsi un ruolo nello sviluppo della storia, provocando danni e addirittura una testa mozzata. Un altro ha cercato di spiegare meglio come mai le autorità cittadine non siano in grado di sgonfiare il pallone.
In inglese si chiama nitpicking, fare le pulci, ed è l’operazione creativa più semplice e primordiale che si possa fare su un testo. Correggere gli errori. Oppure: lasciare gli errori dove stanno e correggerne le conseguenze. Uno degli studenti, ad esempio, ha modificato il sistema di ormeggio del pallone, perché il gioco di contrappesi inventato da Barthelme non gli pareva convincente. Ha introdotto funi e cavi d’acciaio, che poi hanno finito per ricavarsi un ruolo nello sviluppo della storia, provocando danni e addirittura una testa mozzata. Un altro ha cercato di spiegare meglio come mai le autorità cittadine non siano in grado di sgonfiare il pallone.
Se il Doctor House sbaglia a elencare i sintomi di una malattia, il fan della serie esperto di medicina gli fa subito le pulci. Se ne ha voglia, può anche riscrivere la puntata e trasformare lo sbaglio in un elemento narrativo: non più un errore degli sceneggiatori, ma un errore di House, che incide sulla trama e sulla salute del paziente.
Non sempre una storia si porta addosso pulci di tipo tecnico. Altre volte si tratta di buchi nella struttura del racconto. In quel caso, una critica creativa del testo consiste nel rendere più chiaro un passaggio, più esplicito un dialogo – o viceversa: renderli più oscuri se risultano troppo telefonati. Una sorta di editing senza il consenso esplicito dell’autore (ma in fondo, cos’è pubblicare una storia, se non dare un assenso esplicito a questo genere di operazioni?)
Quando la materia prima della trasformazione narrativa sono i simulacri di cronaca che ho descritto prima, fare nitpicking significa interrogare gli archivi, le fonti orali e scritte, i testimoni oculari. Fare un lavoro da storico, ma con obiettivi diversi. Infatti, mentre lo storico compie le sue ricerche per avvicinarsi alla realtà dei fatti, il narratore ha solo bisogno di allargare la sua base di lavoro, sapere cos’è già stato raccontato e quante versioni alternative esistono del suo racconto di partenza. Non è questione di essere esatti, ma di essere consapevoli.
Inutile dire che Internet e l’intelligenza collettiva hanno aumentato a dismisura questa possibilità di ricerca. Un semplice appassionato può rintracciare e consultare con facilità materiali che un tempo erano appannaggio di storici e giornalisti. Questo fa sì che la scrittura (e la lettura «esperta») di storie che utilizzano quei materiali sia alla portata di un numero sempre maggiore di persone.
Il genere del romanzo storico è uscito molto cambiato dalla rivoluzione digitale: se un tempo si scrivevano soprattutto romanzi di ambientazione storica – perché i materiali rintracciati dall’autore non accademico non consentivano altro – oggi si scrivono romanzi di trasformazione storica, dove le fonti di storia e di cronaca sono i materiali di partenza della macchina narrativa.
Se prima la storia era per lo più un fondale, lo scenario di un teatro, i costumi, oggi essa entra a far parte dell’intreccio in una sorta di realtà mista, nel senso di mixed reality, l’intero spettro che va dalla realtà alla finzione, passando per i diversi incroci delle due [130].
2. Trasformazione ermeneutica: interpretare il testo.
Prima di iniziare a scrivere, i «miei» studenti hanno estratto dal racconto di Barthelme un’interpretazione minima: il pallone gonfiato è un’allegoria dell’opera letteraria.
Non è sempre detto che un passaggio così esplicito sia necessario per trasfigurare una storia. Nella fiaba di Andersen I cigni selvatici, si racconta di un principe che condanna a morte una povera ragazza, perché qualcuno gli ha fatto credere che sia una strega. Al momento di bruciare sul rogo, la ragazza riesce però a convincerlo della sua innocenza e il principe, pentito, la sposa.
«Io me ne sarei andata», commenta dal suo letto mia figlia di cinque anni, ma poi non mi sa spiegare perché non avrebbe sposato il principe. La lingua e le strutture narrative di un testo ci possono suggerire una critica creativa senza passare da un’interpretazione esplicita.
Quando però la materia prima è una cronaca, cioè un racconto di fatti, è raro che la lingua e l’intreccio siano abbastanza vitali da fornire un’ispirazione immediata.
Credo anzi che sia ingannevole voler raccontare una storia di questo tipo senza prima aver preso la mira, non tanto con la trama, ma con un’ottica sul mondo. Il rischio è di riprodurre un’interpretazione data, incorporata nella narrazione, senza nemmeno accorgersene o peggio fingendo di non vederla, in nome dell’obiettività, del distacco emotivo e della natura letteraria del proprio lavoro [131].
Inoltre, è proprio un’interpretazione consapevole – esplicita nella testa di chi scrive, anche se dissimulata sulla pagina – che permette a un romanzo di diventare metastorico, cioè di trascendere le epoche, tanto quella dell’azione narrativa quanto quella dell’effettiva pubblicazione.
Di recente Spike Lee ha girato un film sulla strage nazifascista di Sant’Anna di Stazzema. Ha ricevuto molte critiche per via di alcune scelte narrative che non rispecchiano la realtà storica. L’associazione dei partigiani lo ha accusato di non aver raccontato la verità e Lee si è difeso dicendo che il film, fin dal classico disclaimer iniziale, dichiara di essere un’opera di fantasia.
A mio parere, hanno torto entrambi. Da un lato, chi rimprovera a una storia di non essere vera, dall’altro, un regista che non si assume la responsabilità di aver interpretato i fatti, a maggior ragione perché le scene criticate sono farina del suo sacco, frutto della sua fantasia, dunque di una scelta consapevole e non di un banale errore storico [132].
Lars von Trier, nel già citato manifesto, sostiene il bisogno di sfuocare, contro un’informazione inginocchiata di fronte all’altare della nitidezza. Il passaggio non è chiaro, né si chiarisce oltre, ma se il bersaglio è la mitologica «purezza dei fatti», non si può che essere d’accordo. Se i fatti sono puri non significano nulla. Se invece hanno un senso, allora non sono puri, e ogni presunta «obiettività» è malcelata interpretazione. Se non si indossa un paio di occhiali, i fatti risultano sfuocati. Von Trier canta proprio le lodi del fuori fuoco, di un «puro sguardo» in qualche modo speculare al «puro fatto»: io preferisco tenermi gli occhiali.
3. Trasformazione visuale: orientare il testo.
Qualunque racconto ha bisogno di un punto di vista. Scegliere quale non è un’operazione tipica di un certo modo di raccontare, ma un passaggio inevitabile
per costruire una storia.
Quando però il punto di partenza della narrazione è a sua volta una narrazione, il senso della scelta cambia in modo radicale. In questo caso, infatti, un punto di vista esiste già, proprio perché esiste già un racconto, cioè il canone che intendiamo trasformare.
Giocare con le prospettive è un aspetto tipico della narrativa di trasformazione. Come sarebbe L’isola del tesoro raccontata da Long John Silver? Come sarebbe il Vangelo raccontato da Giuda? Come sarebbe un ventennio di storia italiana, visto con gli occhi dei criminali della Banda della Magliana?
Nella short story di Barthelme il narratore è colui che ha gonfiato il pallone. Nella storia ufficiale di Sant’Anna di Stazzema, i punti di vista sono quelli dei superstiti, dei partigiani, degli ufficiali britannici. Chi vuole elaborare queste storie non è davvero libero di scegliere uno sguardo, ma deve decidere se mantenere quelli che ha già – perché ne è affascinato – oppure se cercarne altri, per riempire un buco che lo assilla.
Spike Lee ha deciso di rappresentare nel suo film il punto di vista dei neri americani che combatterono nella zona di Sant’Anna. Una studentessa iconoclasta ha cancellato l’intero racconto di Barthelme e l’ha sostituito con poche righe, dove la ragazza del narratore torna dalla Norvegia, pensando a quanto è stata bene lassù. Arrivata a casa, l’uomo le racconta che il pallone sospeso su Manhattan è opera sua e che l’ha messo lì perché si sentiva solo. Allora lei gli dà del pallone gonfiato egocentrico e se ne va a vivere a casa di un’amica.
Henry Jenkins ha fatto notare lo stretto legame che esiste tra lo scegliere in questo modo il punto di vista di una storia e una delle classiche domande che la media education insegna a porsi di fronte a un testo: «Quali stili di vita, valori e punti di vista sono rappresentati, oppure omessi, da questo messaggio?» [133].
L’osservazione è importante perché ribadisce una volta di più come le scelte narrative che facciamo per trasformare una storia siano l’espressione creativa di una critica alla storia stessa.
Nell’ottavo canto dell’Odissea, Ulisse è alla corte di Alcinoo, re dei Feaci. Nessuno sospetta la sua vera identità, finché l’aedo cieco Demodoco, durante un banchetto, narra gli eventi della guerra di Troia. Allora l’eroe, incontrando se stesso nelle parole del poeta, scoppia in lacrime e rivela ad Alcinoo il suo nome.
Non è il semplice ricordo, la nostalgia del passato a far piangere Ulisse. Né i fatti cantati dall’aedo sono di per sé tristi: al contrario, celebrano la vittoria degli Achei e l’astuzia del loro campione. Sono due gli elementi che li rendono commoventi, cioè significativi: l’intreccio del racconto e lo sguardo dall’esterno del poeta [134].
Per comprendere cosa siamo, non bastano i fatti, ci serve una storia. E perché quella storia non sia un semplice parlarsi addosso, non basta guardarsi l’ombelico, serve il punto di vista di un altro. Niente di più vero della famosa frase di Gobetti, che definì il fascismo «l’autobiografia di una nazione» [135]. Non a caso molta letteratura postcoloniale, e in particolare il cosiddetto realismo magico, ha come tratto distintivo la scelta di un punto di vista altro, schiacciato dalla Storia e dall’imperialismo. In Occidente, la stessa strategia narrativa porta a mettere il racconto nelle mani di criminali, devianti, comprimari, animali, oggetti. Ma questo allargamento segnala anche un cambio di strategia. Nella letteratura postcoloniale le voci che riemergono portano in superficie verità perdute: ciò che è altro è per ciò stesso vero, perché è un pezzo rimosso di realtà. Nei romanzi di trasformazione l’accento non è sulla verità, ma sull’alterità dei punti di vista. L’angolo scelto dall’autore per interpretare i fatti non coincide con il punto di vista di un personaggio in particolare. Anche chi racconta ha bisogno di straniamento, così fa a pezzi la propria visione e la declina con cervelli diversi, occhi alieni, per evitare, in ultima analisi, di fare il tifo per se stesso. Questo scarto permette al romanzo di nascere con una forte interpretazione, ma di non morire
per eccesso di consapevolezza «politica»: si tratta di aiutare a comprendere, non di spiegare.
4. Trasformazione prossemica: abbracciare il testo.
 Nella short story di Donald Barthelme, il narratore si ritira appena ha piazzato il pallone. È un demiurgo burlone che crea il mondo e poi lo osserva per il proprio divertimento. Tornerà soltanto alla fine, per dare l’ordine di ripiegare l’opera e di riporla in magazzino.
Nella short story di Donald Barthelme, il narratore si ritira appena ha piazzato il pallone. È un demiurgo burlone che crea il mondo e poi lo osserva per il proprio divertimento. Tornerà soltanto alla fine, per dare l’ordine di ripiegare l’opera e di riporla in magazzino.
La maggior parte delle critiche creative degli studenti ha riguardato proprio questa distanza, percepita come artificiosa. Nei loro racconti il narratore viene costretto a interagire con gli abitanti di New York, a usare il pallone in qualche modo, a subire le conseguenze della sua stessa installazione: incagliato in una fune da ormeggio, spazzato via da un getto d’aria improvviso, linciato dalla folla.
Risale a Kant l’idea che il giudizio estetico sia puro, cioè indipendente dall’utilità o bontà dell’oggetto e dalla sua reale esistenza. Per questo motivo il vero artista deve essere distaccato dalla sua opera, e l’errore sentimentale è il peggiore che egli possa fare. Nel dare vita a qualcosa di bello, non dovrebbe avere nemmeno la bellezza come fine, ma l’arte dovrebbe germogliare dalle sue mani come una foglia dal ramo. Che dire allora di una casa? Il fatto che sia bella o brutta non dipende dal suo essere abitabile. Ma se non è abitabile non è neppure una casa, e per quanto bella, come palazzo sarà un fallimento. D’altra parte, se la casa è funzionale ma bruttissima da vedere, preferisco non abitarci. In questo la narrativa è simile all’architettura. Non si dovrebbe costruire una casa senza pensare alle persone che ci vivranno dentro.
Il distacco predicato da Kant ricorda da vicino l’oggettività scientifica: anche in questo caso l’economia, la volontà di potenza e l’inconscio sembrano minarlo alle fondamenta. Quando poi si tratta di compiere una trasformazione creativa che ha come materia prima il «racconto dei fatti» e come referente un’intera comunità, allora l’arte disinteressata è davvero impossibile, perché il racconto mi riguarda e l’uditorio mi comprende. Non posso lasciarmi andare alla retorica come se niente fosse, contemplare l’assurdità senza sentirmi in rivolta. Non posso chiudere il libro e vivere oltre la copertina. Usare le parole mi impegna, è un atto reale. Usare la cronaca e la storia non è come assemblare pezzi di cultura: se li guardo dalla giusta distanza scopro che sono pezzi di vita, che ancora pulsano dentro di me e dentro gli altri. Posso usare tutti i metalinguaggi che voglio, ma non posso essere una metapersona. Dire: «Piove, ma non ci credo» [136]. Posso concedermi qualsiasi atteggiamento: la risata e il pianto, lo scherzo, il gioco e la tragedia. Ma non posso fingermi estraneo e distante, perché mentirei: de nos fabula narratur. Ogni storia parla di noi. Dunque, anche di me.
Questo coinvolgimento non significa intromettersi nella narrazione, fare il tifo per un personaggio o per l’altro, spiattellare in faccia al lettore la propria morale, lottare con le parole per dimostrare una tesi. Significa solo questo: scrivere i libri che si vorrebbero leggere e non soltanto quelli che si vogliono scrivere. Costruire il romanzo come se fosse la casa che dovremo abitare. Dunque siamo obbligati a essere seri? Nient’affatto. Antoni Gaudì ha costruito a Barcellona diverse dimore tutt’altro che «serie». Spesso ha stupito gli stessi committenti, ma non ha potuto lavorare come se non esistessero. Il committente di un romanzo non è l’arte, l’editore o lo scrittore stesso. È una comunità di persone: una comunità potenziale, non legata a un tempo e a uno spazio precisi,
ma non per questo meno reale. Un coacervo di bisogni, relazioni, meschinità e conflitti. È in quel contesto che una storia propone la sua visione. Non per insegnarla, ma per discuterla.
Molti scrittori si guardano bene dall’attribuire alla letteratura un ruolo educativo. Spesso affermano il contrario e ricevono un plauso immediato. Scrivere con intento pedagogico è roba da presuntuosi o da catechisti. A me pare che questa falsa modestia sia in realtà codardia sotto mentite spoglie.
La parola «educare» ha il significato etimologico di «tirare fuori» (dal latino ex+ducere). L’esempio classico è quello di Socrate, il figlio della levatrice, che aiuta gli interlocutori a partorire concetti e dunque li fa crescere senza inculcare nulla. La nostra idea di educazione è legata al rapporto maestro/allievo, ma di una comunità nel suo complesso potremmo ben dire che educa se stessa e che ciascuno è a suo modo responsabile di quel che essa tira fuori da sé.
Essere consapevoli di questa dinamica significa accettare il proprio ruolo educativo.
La crescita è il risultato di un conflitto tra forze contrapposte: da una parte l’identità, cioè il mantenersi, il rimanere se stessi, dall’altra la libertà, cioè cambiare. Qualunque parola che si rivolga a entrambe le forze è una parola educante, che tira fuori la libertà dall’identità: tu sei questo e puoi diventare quest’altro. Per crescere abbiamo bisogno di sapere chi siamo e cosa desideriamo essere. Secondo Miguel Benasayag, nell’epoca delle passioni tristi l’educazione è entrata in crisi perché al desiderio di futuro si risponde solo con minacce [137]. La crescita dei figli si è trasformata in un addestramento, un kit di sopravvivenza per tempi oscuri. Non si impara l’inglese per avere un’enorme opportunità di conoscenza, ma perché è indispensabile nel mondo del lavoro. Non si può sprecare il tempo con interessi senza tornaconto: attività fisiche che non siano fitness, giochi che non insegnino qualcosa, conoscenze che non siano spendibili. Tutto diventa armatura, corazza artificiale imposta sulla vita, perché senza l’attrazione di un futuro possibile, non si riesce a tirar fuori nulla dagli individui.
Dire che una storia ha valore educativo, non significa trasformarla in incantesimo, scriverci in fondo la morale o illudersi che possa cambiare da sola la condotta della gente. Perché sia educativa, è sufficiente che la si racconti per una comunità, a partire da un’interpretazione e immaginando un futuro possibile. Sta prima di tutto in questo la dimensione epica di certi romanzi di trasformazione, e non a caso l’epica era lo strumento educativo dei tempi antichi. Qualcuno l’ha chiamata passione civile, ma prima ancora è passione verbale. Fiducia nel compito epico della parola e consapevolezza del suo ruolo tragico.
Epico, perché il linguaggio può mettere in crisi il mondo e immaginarne uno nuovo.
Tragico, perché le parole sono lente, e il mondo è molto veloce.


 Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)
Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Ciao, il link della nota 128 non funziona, quello corretto dovrebbe essere questo:
http://www.minimumfax.com/upload/files/minimum_classics/assaggio_09_barthelme_atti.pdf
Corretto, grazie!
Riporto un breve passaggio già contenuto nel mio intervento sul NIE, che forse potrebbe fare da corollario…
L’epica è la storia dalla parte giusta delle Storia per parafrasare il disclaimer di Manituana. Manituana potrebbe correre in parallelo all’Iliade se l’Iliade fosse raccontata dalla parte di Troia e se l’Odissea fosse l’Ettorea: la narrazione delle gesta di un Ettore sopravvissuto alla morte e in viaggio nel cuore di tenebra della sconfitta. Epic in New Italian Epic allora avrebbe a che fare, non con l’epica in sé – o in senso classico – ma con un afflato epico della narrazione e/o con un’evoluzione del modo d’intendere l’epos filtrato attraverso la sacra trimurti della modernità, invero ormai piuttosto acciaccata, Nietzsche, Freud e Marx, in cui il ruolo fondamentale è quello ricoperto dall’hybris presocratica10 e quindi mutuato dalla tragedia. Lo stesso valore etico, in senso morale, non di costume, che avrebbe il NIE deriva, a mio parere, dall’assenza di equilibrio dell’universo. La sacra trimurti deve fare i conti con l’oste. E l’oste potrebbe essere l’esistenzialismo di Albert Camus. Se così fosse, si potrebbe tracciare un parallelo tra la rivolta dell’individuo – mi rivolto dunque siamo – (individuale ma universale ed ecco il valore epico simbolico del solipsismo), e la lotta, sempre e comunque, solitaria, dell’eroe.