
Milano, 22 settembre, lo spezzone di chi lavora coi libri.
Da ieri è evidente, anzi, eclatante, e oggi viene scritto in lungo e in largo: non si tratta più di “mobilitazioni”, ma di un movimento.
Si era subodorato con le immagini di Genova alla partenza della Freedom Sumud Flotilla, e Connessioni Precarie aveva parlato di «un movimento già nato, che pure non c’era mai stato». Il nostro «Bloquons tout» – che, rispetto a quello francese del 10 settembre, si è più concentrato sul genocidio palestinese e sul rifiuto della guerra – lo ha confermato oltre ogni dubbio: c’è un movimento.
Anzi, «un mondo», titola Il manifesto, alludendo alla pluralità che si è espressa in piazza. Con sorpresa e clamore, ma – non dimentichiamolo – dopo aver seminato per due anni.
Un’ecologia, diremmo noi, seguendo l’indicazione di Rodrigo Nunes.
Non poteva esserci momento più calzante per l’uscita italiana del suo libro Né verticale né orizzontale: mentre appare, dopo lungo tempo, un movimento di massa su scala nazionale e di impronta internazionalista.
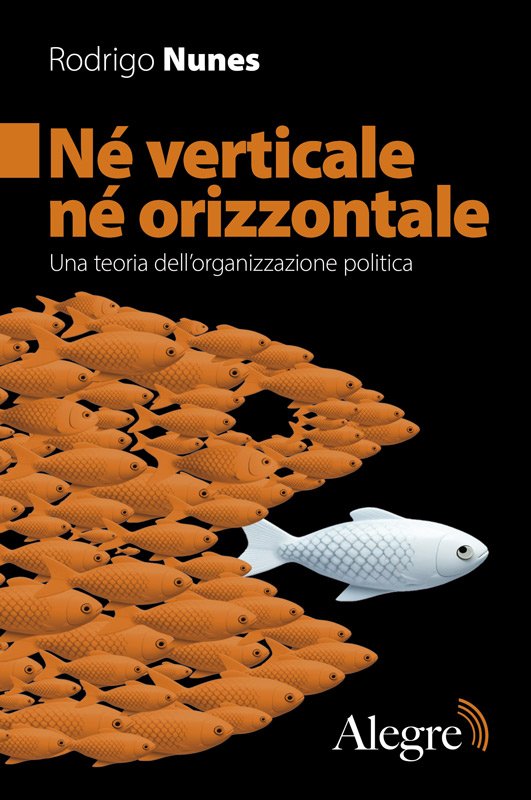 Che probabilmente si troverà ad affrontare gli stessi problemi dei movimenti precedenti, ed è in questa prospettiva che Né verticale né orizzontale può rivelarsi una lettura preziosa.
Che probabilmente si troverà ad affrontare gli stessi problemi dei movimenti precedenti, ed è in questa prospettiva che Né verticale né orizzontale può rivelarsi una lettura preziosa.
Del libro avevamo scritto nel 2023, facendo riferimento all’edizione in inglese.
In quell’occasione, tra l’altro l’avevamo fatto reagire con le lezioni che abbiamo tratto dalla lotta No Tav, che ci paiono attuali anche in queste ore:
«non si prendono le distanze dalle tattiche che adottano le altre componenti. C’è chi fa gli scontri e chi fa ricorsi legali, chi mette insieme una lista civica e chi prega la Madonna davanti ai celerini. Nessuna componente deve forzare le altre su terreni in cui si trovano a disagio, ma che cento fiori sboccino. Se si rinuncia a questo principio, subito scatta il divide et impera, la falsa dicotomia tra “buoni” e “cattivi”, e il discorso del movimento viene dirottato: anziché degli obiettivi della lotta si è costretti a parlare della “violenza”. A quel punto è la fine.»
Dopo aver preso in esame i movimenti altermondialisti di inizio secolo e poi le due ondate planetarie di mobilitazioni del 2011 e del 2019, Rodrigo Nunes invita a pensare i movimenti come ecosistemi, per superare i dilemmi che ogni ondata di movimento si trova di fronte e su cui finisce per arenarsi, quelli riguardanti l’organizzazione.
Pensare la lotta come un’ecologia diffusa di relazioni che attraversano e mettono insieme diverse forme d’azione (aggregata, collettiva), forme organizzative disparate (gruppi di affinità, network informali, sindacati, partiti), individui che ne sono parte o ci collaborano, individui senza affiliazioni che partecipano alle proteste, condividono materiali on line o semplicemente seguono con simpatia gli sviluppi su testate giornalistiche, pagine web, profili social, spazi fisici ecc.
Qualunque cosa noi consideriamo come totalità del “movimento” è in realtà un network non afferrabile nella sua totalità, fatto di tanti network diversi, un’ecologia di network in evoluzione a sua volta incastonata dentro ecologie più vaste che si sovrappongono in vari modi.
«Non si organizza una totalità: ci si organizza dentro di essa.»
Torneremo a scrivere di Né verticale né orizzontale in modo più approfondito. Oggi cogliamo l’urgenza del momento, invitando chi sta lottando a dotarsene come utensile teorico, dentro una cassetta che, in una fase così difficile a livello mondiale, dovrà contenerne molti.
La traduzione, attenta e scrupolosa, è di Enrico Gullo. In quarta di copertina c’è anche una frase di WM1:
«Un libro che fa da crinale: dopo averlo letto si è su un nuovo versante, non si può più pensare al problema dell’organizzarsi con gli automatismi e gli approcci indolenti di prima. Una lettura liberatoria che cambia lo sguardo».
In autunno Nunes verrà in Italia per un articolato tour di presentazioni e dibattiti. Dettagli a seguire.

 Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)
Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)
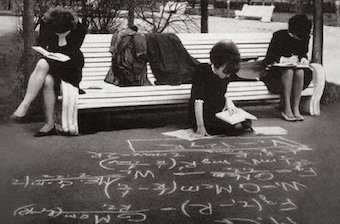

Mi sono appassionata come non avveniva da tempo a due band: Fontaine D.C. e Idles, e quindi da un po’ nel mio radar ci sono le parole punk e post punk. Quest’ultimo lo abbandono subito perché probabilmente non vuole dire niente, il primo mi attira perché non è mai stato nelle mie corde, ma ora la questione è urgente, e si va oltre il genere musicale, ovviamente.
Mi ha aiutato molto l’editoriale di fondo del n. 7/2025 della rivista musicale Rumore, di Sergio Messina.
“… un aspetto meraviglioso del punk … essere politici senza fare politica, assicurarsi che le cose migliorino per tutti, senza etichette ideologiche, comunicare la propria differenza attraverso pratiche e atteggiamenti, non discorsi o proclami…”
Qualche riga prima, riportando un’intervista di Anthony Bourdain al produttore musicale Steve Albini (doppio rest in peace), Albini dice:
“… mie pratiche aziendali, ovvero che siamo tutti sulla stessa barca, stiamo tutti cercando di fare la stessa cosa. Vogliamo solo che le cose migliorino per tutti… Non stai cercando di tirare fuori il massimo, stai cercando di assicurarti che tutto vada avanti”.
Anni fa, al festival “Il richiamo della Foresta” organizzato dallo scrittore Cognetti, ascoltai l’antropologa Michela Zucca durante un incontro dal titolo “Montagne ribelli”; ho ritrovato le parole che mi annotai, da cui evidentemente avevo da imparare:
…Vanno bene anche gli 80enni che sanno fare solo la Festa del Patrono, si collabora anche con loro…”
E poi, parlando delle popolazioni montane che subirono la dominazione dei Romani, e del Trentino odierno:
“… non viene rinnegata la disciplina”.
Tutto questo, per me, chiude il cerchio con il concetto “purchè funzioni”, che mi ronza in testa da tempo, che non vuol dire pressapochismo, anzi, è il contrario, che mi aiuta a liberarmi (la strada è ancora lunga) di tanti pre-concetti, tanti schemi inutili che poco hanno a che vedere con la libertà e anche il rigore (per me) necessari per fare le cose bene, per far che cento fiori sboccino.
Attendo davvero Il libro di Nunes.
Infine, penso all’enorme banalizzazione, dalla quale mi sono fatta prendere in pieno, della classificazione delle generazioni Boomer, X, Millennial, Z, che invece che aiutare alla comprensione, genera astio e semplificazione, e divisione.
Chissà se negli articoli sulla giornata di lunedì, che mi sono rifiutata di leggere, le hanno nominate.
Sara B
Io NVNH l’ho letto (e ora me lo rileggerò) e posso solo dire che condivido in toto l’analisi di Enrico Gullo:
«[…] dopo averlo letto si è su un nuovo versante, non si può più pensare al problema dell’organizzarsi con gli automatismi e gli approcci indolenti di prima.»
Aggiungerei soltanto un particolare. Quelle parole contengono anche un involontario monito: al termine della lettura ci si potrebbe sentire disorientatx e paradossalmente piú solx.
Potrebbe capitare per esempio, come in un pessimo trip, di accorgersi all’improvviso di essere circondati su tutti i fronti da «malinconici di sinistra», categoria che Nunes cita nel libro, riprendendola da Benjamin.
«Impegnati “più in una particolare analisi o ideale politico – persino nel fallimento di quell’ideale – che nel cogliere le possibilità di un cambiamento radicale nel presente”, i malinconici di sinistra si proteggono dall’affrontare il fallimento spostando l’identificazione narcisistica con l’oggetto perduto sull’odio per un sostituto.»
Traduzione mia, a braccio.
Quantx ne conoscete? E qunatx di questx sono tra “i rimasti” di cui parlano Cristina e Stefania?
Mi auguro davvero che il lavoro di Nunes trovi una platea il più ampia possibile, pronta e capace di discuterne gli importanti contenuti.