La questione dell’identità in Altai – di Gaia De Pascale

Bruno Fanciullacci, generoso interprete della filosofia della prassi, protagonista di una rapida ma intensa disputa con Giovanni Gentile. Lo citiamo nell'intervista a Pisanotizie (clicca sulla foto per approfondire). La filosofia, nata nelle strade, alle strade dovrà tornare.
{ In questo post proponiamo:
- i link a due interviste che hanno qualche motivo di interesse, una apparsa sul sito romanzistorici.it…
[ «Nel giugno 1998, dopo aver consegnato il testo di Q all’Einaudi (sarebbe uscito nel marzo dell’anno successivo), pour parler iniziammo a fantasticare sui personaggi, sul proseguimento delle loro vite e vicende. Capiamoci: non perché volessimo scrivere un sequel, anzi, il nostro interesse si stava già spostando verso altre epoche e altre storie. Ma avevamo passato quasi tre anni in compagnia di quei personaggi, e la nostra curiosità su cosa avrebbero fatto dopo era una curiosità da lettori e… da amici, prima ancora che da autori.» ]
…e l’altra sul sito Pisanotizie
[ «Che la storia "non si faccia con i se" è una vecchia fregnaccia, uno dei più logori luoghi comuni. Il passato non è una costellazione fissa e immota, perché non è fatto solo di "nudi fatti". I fatti non sono mai nudi, sono sempre vestiti di interpretazioni. Il passato è un teatro di guerra, un luogo di conflitto durissimo: il conflitto per l'egemonia sulla memoria pubblica.» ];
- Qui di seguito, un bel testo su Altai di Gaia De Pascale, sistemazione e approfondimento di quel che avrebbe detto al Buridda di Genova la sera dell’11 febbraio scorso, se qualcuno non le avesse tolto la parola con la forza.}
***
Altai, il falco di stirpe meticcia, la cui madre proviene dalle lande ghiacciate ai confini del mondo e il cui padre vola sopra i deserti dell’Asia Centrale. È questo animale a dare il titolo all’ultima fatica dei Wu Ming; è il meraviglioso volatile dalle ali screziate a campeggiare sulla copertina e a richiamare, fin da subito, quello che può essere considerato il tema centrale di quest’opera e, forse, di ogni lavoro della band: l’identità.
A ben guardare, infatti, la questione identitaria è inscritta nel lavoro dei quattro (e prima cinque) brainworkers fin dalle origini, fin da quando, insomma, smesso il multi use name Luther Blissett, il collettivo ha deciso di battezzare la nuova versione di se stesso, quella legata a filo doppio alla scrittura, con il “nessun-nome-Wu-Ming”. Dunque tutto comincia dai nomi, com’è giusto, e anzi, dal proprio nome. Perché tra l’opera e il suo autore, e tra questi e il suo lettore, non c’è più soluzione di continuità: ciascuno è specchio dell’altro, e viceversa.
Ma torniamo ad Altai. Torniamo a un romanzo ambientato quindici anni dopo l’epilogo di Q, e che di Q riprende alcuni personaggi e alcune situazioni salvo poi, attraverso un radicale scarto linguistico, stravolgerne i significati.
La storia, come sempre, è popular. Un po’ romanzo storico, un po’ romanzo d’avventura e, per certi aspetti, un po’ romanzo di formazione, Altai narra le vicende di un ex agente segreto di Venezia accusato (ingiustamente, ma fino a che punto?) di tradimento e costretto a riparare a Costantinopoli, proprio nella dimora del suo antagonista storico, Yossef Nasi, acerrimo nemico della Serenissima.
 Yossef coltiva un folle sogno: regalare al popolo della diaspora la Terra Promessa, un’isola felice da cui ricominciare per riparare il mondo e fondare la nuova Sion. Ma il prezzo di questo sogno è altissimo: la conquista di Cipro a ogni costo, con l’appoggio del Sultano e il contrasto armato di Venezia e delle potenze cattoliche. Tutto si risolverà in un bagno di sangue, una macchia rossa che allaga qualsiasi prospettiva di utopia realizzata dall’alto.
Yossef coltiva un folle sogno: regalare al popolo della diaspora la Terra Promessa, un’isola felice da cui ricominciare per riparare il mondo e fondare la nuova Sion. Ma il prezzo di questo sogno è altissimo: la conquista di Cipro a ogni costo, con l’appoggio del Sultano e il contrasto armato di Venezia e delle potenze cattoliche. Tutto si risolverà in un bagno di sangue, una macchia rossa che allaga qualsiasi prospettiva di utopia realizzata dall’alto.
Dentro queste vicende si muove una selva di personaggi bastardi, sradicati, divisi. Uomini e donne in lotta con se stessi, con le ombre del passato, con i fantasmi del futuro. Traditori che diventano traditi, amici che si fanno nemici, traghettatori ora traghettati, fughe che si presentano come ritorni a casa. Vuoti da riempire attraverso fuorvianti processi poetici, la costruzione di quella storia e di quella geografia “immaginarie” da cui già Edward Said ci metteva in guardia nel suo Orientalismo: “Un tempo” si costruì la relazione tra il Tuota e Manuel Cardoso, e in quel tempo, che è il tempo dell’infanzia, il protagonista di Altai identifica l’inizio della sua ricerca di un padre. Allo stesso modo, la prima volta che Nasi parla a Manuel del suo sogno di conquistare Cipro, lo fa associando a un luogo geografico il verbo immaginare, tingendo in questo modo dei colori del sogno uno spazio reale: “Immagina una terra… (Immagina) un luogo… (Immagina) una nazione”. Del resto, gli elementi onirici, le favole e gli incubi che tempestano i sonni dei protagonisti portando con sé un bagaglio di presagi, si alternano continuamente a rappresentazioni terrestri e sensuali, in cui appunto tutti i sensi, e in particolare l’olfatto, vengono continuamente attivati.
Ciascun personaggio, dunque, è molto di più di un corpo rinchiuso nella gabbia di un’identità monolitica. Così Manuel Cardoso è figlio di un padre (veneziano) assente e di una madre (ebrea) a sua volta figlia di “chissà chi”. E’ Manuel Cardoso ed Emanuele De Zante, “giudeo mascherato da cristiano travestito da giudeo”, questo e quello, a seconda delle circostanze, dei luoghi, della direzione in cui lo portano le sue alterne fortune. Yossef Nasi è anche Giuseppe Nasi, alias Joao Miquez, ebreo portoghese alla corte di un sovrano musulmano. Gracia, dal canto suo, si porta continuamente appresso la sua altra identità di Beatriz Miquez. E ancora, Dana è una giovane donna strappata da un corsaro dalle coste della Morea ed entrata nella corte di Selim, di cui la giovane è costretta a seguire i diversi trasferimenti. Per non parlare di Ismail, di tutte le vite che ha avuto, di tutti i nomi: Ludovico, Gert dal Pozzo, Tiziano l’Anabattista, e cosi via.

Furio Jesi
Anello di congiunzione tra Q e Altai, Ismail crea un doppio raccordo: tra il tempo dello svolgimento dei due romanzi e tra il tempo della scrittura delle due opere. La sua presenza – evanescente, in controluce, eco di voci di altri che ne disegnano i fragili contorni – riempie le distanze cronologiche ipostatizzando una catena di cambiamenti. Quelli che hanno investito il mondo cinquecentesco e quelli che hanno travolto i nostri giorni. Così la questione identitaria, oltre alla sua naturale declinazione antropologica, trova anche una declinazione politica. In Spettri di Müntzer all’alba i Wu Ming, facendo autocritica sulla loro posizione rispetto ai fatti del G8 di Genova, puntano tra le altre cose l’indice contro il loro essersi autoproclamati artefici di una mitopoiesi che, volta com’era a un fine specifico, li ha portati inevitabilmente all’evocazione di un pericoloso mito “tecnicizzato” (secondo la definizione che ne dà Furio Jesi riprendendo e “aggiustando” il lavoro di Karoly Kerenyi).
Eccolo allora il protagonista di Q dieci anni dopo (rispetto al tempo della scrittura). Ecco che il suo agire è tornato nelle mani della moltitudine, ora che tutto il suo essere si riversa nelle storie che racconta e, soprattutto, in ciò che la gente dice di lui: voci che rimbalzano di bocca in bocca, brusio sotterraneo che si appropria del mito e lo rimodella, cambiandolo definitivamente di segno e riadattandolo al presente, quello delle storie, e quello della Storia. Il passato bussa alla porta, ma questa volta non è un singolo soggetto ad aprire, bensì la vox moltitudinis.
Attraverso questo processo, la frattura identitaria tra correnti in cui all’epoca del G8 si incancrenì il movimento perde il motivo del suo stesso essere, perché il coacervo di voci, di cui ciascuno è partecipe, funge da setaccio al fondo del quale, di questa figura quasi-mitologica, non resta che la forza del suo essere-umano. Il mito, tolto dalle mani di un singolo soggetto, si sfrangia in un mare di dati contrastanti che portano a una naturale epurazione del superfluo per giungere al nocciolo della questione: quella volontà di insubordinazione che ora non è più soggettiva, ritagliata ad hoc da qualcuno su qualcun altro, ma comunitaria.
In tutto questo contesto, Ismail entra in scena mettendosi in viaggio. Si sceglie dunque per lui la figura della transizione come figura emblematica del cambiamento.
Al momento della partenza, e dunque di quella frattura con una parte di sé che è sempre dolorosa, Ismail decide di portarsi dietro alcuni oggetti, che hanno una valenza altamente simbolica.
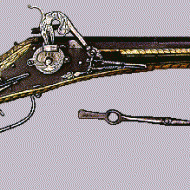 Ci sono le pistole, ovviamente, a ricordare che il personaggio resta comunque, e sempre, un uomo in rivolta.
Ci sono le pistole, ovviamente, a ricordare che il personaggio resta comunque, e sempre, un uomo in rivolta.
C’è il libro, le parole vergate nel corso degli anni: si tratta di Q, il punto di raccordo con le vite passate ma anche la testimonianza della fiducia nella scrittura come mezzo capace di incidere potentemente sulle cose. Gli scritti vergati di suo pugno che Ismail porta con sé sono un atto d’amore verso la narrazione come mezzo per tenere vivo il passato e per creare un filo rosso di continuità con il presente e il futuro. Di più: in Altai il “libro” è anche l’unico punto di approdo possibile per il popolo della diaspora. E’ nelle Scritture che risiede l’unica Terra Promessa possibile. E’ la Parola che costituisce l’unica vera patria che non sia solo terra dei padri ma anche, e soprattutto, terra dei figli. I libri dunque, quelli che riempiono la biblioteca di Nasi, possono essere il fondamento dell’identità di un popolo, e non la carta geografica macchiata del vino/sangue di una conquista calata dall’alto, di un’utopia costruita a tavolino e incarnata da un luogo fisico nel quale esercitare un potere, per quanto “buono” nelle sue intenzioni.
 Due sono le mappe presenti in Altai: una e’ la carta rappresentata su un foglio di pergamena, che Nasi stringe tra le mani e segna con la moneta d’oro del dominio economico. L’altra è un disegno tracciato attraverso la tecnica del mosaico sul pavimento del salone di Palazzo Belvedere. Qualcosa dunque da calpestare, da tenere sotto i piedi. In queste mappe Nasi vede il passato, sogna il futuro. Ma non riesce a scorgere il presente di orrore che le invade.
Due sono le mappe presenti in Altai: una e’ la carta rappresentata su un foglio di pergamena, che Nasi stringe tra le mani e segna con la moneta d’oro del dominio economico. L’altra è un disegno tracciato attraverso la tecnica del mosaico sul pavimento del salone di Palazzo Belvedere. Qualcosa dunque da calpestare, da tenere sotto i piedi. In queste mappe Nasi vede il passato, sogna il futuro. Ma non riesce a scorgere il presente di orrore che le invade.
Andando avanti con gli oggetti che Ismail decide di portare con sé troviamo poi uno specchio, la cui funzione evidente viene esplicitata fin da subito nel corso dello scritto. Ismail ha la necessità di riconoscersi, di ritrovare se stesso da questa e da quella parte del mare, da questa e da quella parte del tempo. Il passato non si vuole dimenticare, anzi non si deve. Solo bisogna evitare che si sclerotizzi impedendo di andare oltre. Ismail porta lo specchio con sé perché sa che questo viaggio lo cambierà ma che, in un certo qual modo, anche nel viaggio e dopo il viaggio sarà sempre se stesso.
Anche Gracia, nelle pagine che danno avvio all’intera narrazione, è davanti a uno specchio. Nel momento in cui sente la morte vicina scosta il drappo verde che copre il vetro riflettente, e si guarda. Questo atto del guardarsi la fa andare a ritroso nel tempo, al momento del cambio di identità quando, bambina, ricevette un nuovo nome per salvarsi dall’Inquisizione. Lo specchio riflette dunque entrambi i nomi di Gracia. Se è vero, come sostiene Eric J. Leed, che le identità si costruiscono con specchi e riflessi, è in questo gioco di immagini che Gracia, come Ismail, può recuperare definitivamente le sue identità e trovare il coraggio di lasciarle definitivamente andare: attraverso la morte, o attraverso un viaggio – in fondo, è la stessa cosa.
Infine, Ismail non parte da solo, ma porta con sé i due gemelli, Hafiz e Mukhtar, che ha salvato dalla schiavitù e che costituiscono ora la sua nuova famiglia. Eccoci dunque in un punto chiave della narrazione per quanto riguarda quest’analisi delle identità. Il protagonista di Q non aveva famiglia, nulla si sapeva del suo passato. Era, alla lettera, uno sradicato. Ora i Wu Ming sentono l’esigenza di creare intorno a lui una comunità, fondata non tanto su legami di sangue quanto su legami d’elezione. Ismail si costruisce, a modo suo, una “casa”. Un luogo affettivo da chiamare suo, e che al contempo non lo fissa per sempre a un destino, ma lo accompagna nelle sue infinite mutazioni.
 A ben guardare, il ruolo simbolico dei gemelli non è poi così diverso da quello del carrubo di Dana. Il carrubo, si legge in Altai, è la “copia di un ricordo”. Proteggendo le radici del carrubo, avvolgendole con cura in un telo di iuta al momento del trasloco, proprio come ha fatto con il suo corpo coprendolo con un abito sontuoso, Dana dimostra di avere cuore e mente sufficienti a sopportare i rovesci della sorte. Lei sa che, comunque andranno le cose, niente andrà perduto. Ogni cosa è legata da una catena i cui estremi Dana non smette di tenere tra le mani, e che nessuno le può strappare.
A ben guardare, il ruolo simbolico dei gemelli non è poi così diverso da quello del carrubo di Dana. Il carrubo, si legge in Altai, è la “copia di un ricordo”. Proteggendo le radici del carrubo, avvolgendole con cura in un telo di iuta al momento del trasloco, proprio come ha fatto con il suo corpo coprendolo con un abito sontuoso, Dana dimostra di avere cuore e mente sufficienti a sopportare i rovesci della sorte. Lei sa che, comunque andranno le cose, niente andrà perduto. Ogni cosa è legata da una catena i cui estremi Dana non smette di tenere tra le mani, e che nessuno le può strappare.
 Rifiutando il legame amoroso con Dana in favore del legame affettivo ma al contempo di potere con Nasi, Manuel perde per sempre la possibilità di radicarsi. Per quasi tutta la narrazione Manuel affida il suo passato e il suo futuro alla sorte, a quei dadi che stringe in continuazione tra le dita per riempire tutti i vuoti della sua vita: la morte della madre, l’ossessiva ricerca di un padre. Manuel vuole il suo passato. Lo vuole così tanto da cadere nel fatale errore di innescare volontariamente un processo, per usare una definizione di Gerard Lenclud, di “filiazione inversa”.
Rifiutando il legame amoroso con Dana in favore del legame affettivo ma al contempo di potere con Nasi, Manuel perde per sempre la possibilità di radicarsi. Per quasi tutta la narrazione Manuel affida il suo passato e il suo futuro alla sorte, a quei dadi che stringe in continuazione tra le dita per riempire tutti i vuoti della sua vita: la morte della madre, l’ossessiva ricerca di un padre. Manuel vuole il suo passato. Lo vuole così tanto da cadere nel fatale errore di innescare volontariamente un processo, per usare una definizione di Gerard Lenclud, di “filiazione inversa”.
Secondo l’etnologo francese, la tradizione è una retroproiezione: non è il passato a produrre il presente ma il presente a produrre il passato. Non sono i padri a generare i figli, ma i figli a generare i padri. Tutto questo avrebbe un senso in un mondo, e in un tempo, in cui i padri esistono davvero. Ma i padri di Manuel sono tutti, per certi aspetti, “abortiti”. In fondo, non può essere altrimenti dato che il tempo di chi scrive continua ad entrare in cortocircuito con il tempo dei fatti narrati. E il tempo dei Wu Ming è un tempo in cui i padri sono morti, se ne sono andati, non ritorneranno più – per usare una metafora di David Foster Wallace ripresa da WM1 in un articolo dal significativo titolo di Noi dobbiamo essere i genitori – a rimettere a posto le cose dopo questa festa in cui tutti ci siamo impegnati a sovvertire l’ordine senza riuscire a immaginare un dopo. Senza preoccuparci del futuro.
Così, sembra in defintiva volerci dire Altai, se è necessario rifiutare come voleva Bronislaw Malinowski “l’algebra dell’identità”, e svincolarsi da cristallizzazioni del proprio “io” che portano inevitabilmente, come nel caso dell’utopia di Nasi, a guastare progetti che si sarebbero voluti aperti e malleabili, non è nemmeno possibile seguire la strada tracciata da Manuel, intestardendosi a inventare un passato che non c’è e fondando su questa invenzione tutta la propria esistenza.
Del resto, anche Manuel, sul finire della propria vita, se ne rende conto. Il suo passato non si può cambiare, la possibilità di un cambiamento retrospettivo è defintivamente perduta. Ma ciò che Manuel riesce a salvare è ancora più importante. Perché, salvando dall’orrore della guerra un bambino, Manuel salva il futuro. Con quell’azione, inconsapevolmente, Cardoso ricompone anche quel “bambino in procinto di spaccarsi in due” che sta al cuore delle sue identità. Il piano che doveva “resituirlo a se stesso” è fallito, ma molto in questa perdita è stato guadagnato: “Avere provato a tracciare un futuro, essermi librato in volo anche solo per un momento, è ciò che adesso mi dà la forza di affrontare quello che mi aspetta”. Almeno per un attimo, Manuel smette dunque di cercare i suoi padri per farsi lui stesso genitore. E’ a quel punto che abbandona i dadi, lascia la sorte. In questo slancio verso il domani, Manuel ricompone tutti tempi dell’esistenza proprio come è accaduto a Gracia e a Ismail davanti agli specchi. Ora può anche morire, dirsi addio, perché il futuro è ormai salvo.
Il libro si chiude con un’ultima immagine altamente simbolica. Cinque anime in groppa a cinque dromedari si incamminano lungo una pista che serpeggia tra colline riarse, verso una città bagnata dal mare. Una giovane donna, un arabo con una lunga scimitarra, un giovane dal volto glabro, un bambino, un vecchio. Cinque generazioni, cinque persone unite da nient’altro che un’affinità elettiva. E’ il segno di una nuova famiglia che si è scelta e in questa scelta ha trovato e protetto le sue radici. E’ una nuova comunità che non ha rifiutato il passato, ma ne ha attraversato il deserto per andare incontro al futuro.
E’ la cifra della scrittura di Wu Ming, che non smette di mettersi in discussione e di ricomporre brandelli identitari per superare l’apparente paradosso di un “io” che è tanto più unito quanto più è molteplice, tanto più fedele a una propria verità quanto più non resta mai uguale a se stesso.
Di fronte al deserto del nostro tempo i Wu Ming hanno fatto la stessa scelta di Ismail: “farsi nuvola e piovere sulle montagne”. Solo così il collettivo può continuare a essere fiume senza rinunciare ad attraversare i luoghi e i tempi della nostra desolazione. Del resto, “la libertà non rimane mai la stessa”, né può rimanerlo una scrittura che a tale libertà continui a tendere.
 .
. Calendario presentazioni
Calendario presentazioni Giap, l'epicentro della nostra presenza sul web
Giap, l'epicentro della nostra presenza sul web Home Page
Home Page Libri
Libri Suoni e voci
Suoni e voci ISCRIVITI AL FEED DI ALTAI
ISCRIVITI AL FEED DI ALTAI